Autoinvidia
a) Ad occhi aperti e concentrato, in stato di beatitudine, il bambino sta succhiando il latte dal seno materno. Con una mano tiene il seno come per sentirne la presenza. Aveva pianto nella seppur brevissima attesa e mostra rabbia, disappunto e ancora pianto quando la mamma lo allontana per un momento, per sistemarlo meglio in braccio. Riprende allora a succhiare con evidente aggressività, quasi mordendo, come ad esprimere un sentimento che, se potesse parlare, forse gli farebbe a dire alla madre: “Ma perché il seno ce l’hai tu e non ce l’ho io?”.
b) Muovendosi più e più volte in quel luogo gli era venuta in mente una soluzione per cambiare le cose. Si era perfino compiaciuto di come si stava muovendo proiettando su quel problema l’invenzione a cui stava pensando. Si sporgeva anche volentieri a immaginare come tutto sarebbe stato bello, dopo. A un certo punto però iniziò a tornargli indietro una domanda che diveniva sempre più insinuante: la soluzione che ho inventato è bella, ma sono io quello che può realizzarla davvero? Introiettò quella domanda, abbastanza rapidamente, e si trasformò in angoscia: no, non sono io ad avere le capacità di fare la cosa bella che ho pensato.
In principio è il movimento con cui ci sporgiamo sull’orlo dell’esistente, proiettandoci nel possibile. Quello, per essere almeno in parte efficace deve essere un movimento di andata e ritorno, tale cioè da riportarci una gratificazione o un riconoscimento del valore che abbiamo proiettato. Quando funziona, comunque può generare invidia: ovvero la nostra incapacità di vedere come mai non possediamo noi, per noi stessi, quello che ci piace e sentiamo di volere. Non riusciamo a vedere perché quello che tanto vogliamo ce l’ha un altro e non noi.
Può accadere, inoltre, e accade spesso, che non sia l’altro da noi a generarci invidia, ma sia una parte di noi stessi che si mette contro l’altra che aveva pensato il possibile, l’attacca e la protegge troppo, la parassita, fino a farla sentire incapace di realizzare quello che sempre noi avevamo concepito come possibile. È l’autoinvidia. Col suo volto semmai non cisposo come l’invidia, ma corrosivo e molle, come sabbie mobili, da cui risulta difficile far emergere la bellezza che avevamo concepito.
Esiste una continuità tra l’invidia e l’autoinvidia, ma nel secondo caso l’oggetto è una parte di noi e ci porta a sentire che, mentre possiamo muoverci verso quello che ancora non c’è e concepirlo, non saremo certo noi a essere effettivamente capaci di inventarlo.
Luigi Pagliarani, ne Il coraggio di Venere, ha formulato l’ipotesi dell’angoscia della bellezza. Proprio quel particolare tipo di ansia che sembra caratterizzare noi e il nostro tempo attuale: operiamo spinte per cercare di concepire qualcosa di bello che potrebbe portaci fuori dalle situazioni in cui siamo, ma produciamo allo stesso tempo comportamenti e atteggiamenti che finiscono, di fatto, per lasciare le cose come stanno. Nel conflitto estetico tra la nostra condizione di dipendenza dal presente e la nostra spinta all’autonomia, lasciamo prevalere la paura di non essere all’altezza, non vedendo o negando – in una parola autoinvidiandoci – le nostre capacità. Si disperde così il nostro sentire progettuale e si neutralizza, rientrando nella normalizzazione e sottostando alla forza dell’abitudine.
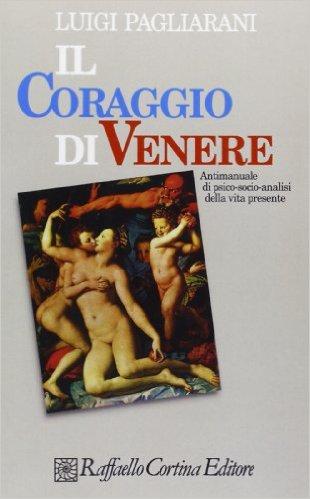
Dell’invidia, è la tensione che essa attiva quello che conta. Quella tensione può dare vita a esiti costruttivi o distruttivi. Ogni emozione è relazionale. L’invidia è relazionale e non se ne comprende la natura se non come emergenza nelle relazioni. L’identificazione sociale e la simulazione incorporata sono aspetti contingenti e coevolutivi del processo di individuazione, come viene sempre più ampiamente comprovato dalla ricerca sperimentale e dall’osservazione fenomenologia. Nelle dinamiche del riconoscimento e della individuazione, laddove si creano le condizioni per la costruzione di sé, essere sollecitati nel desiderio dalla vista della soddisfazione del desiderio altrui può concorrere a cercare e a generare ulteriori possibilità per sé. Può, allo stesso tempo, portare a posizioni distruttive e autodistruttive. È l’ambiguità del gioco dell’invidia. Nelle sue molteplici manifestazioni, l’invidia tende ad assumere almeno tre forme. La prima è l’autoinvidia. Essa riguarda la pensabilità del proprio progetto di espressione di sé, la concepibilità della bellezza di un cammino di autorealizzazione, di fronte al quale possiamo trovare il passo giusto e graduare le energie per realizzarlo, o possiamo perderci e tradirci per il fatto di non riuscire a contenere la bellezza di ciò che noi stessi abbiamo immaginato. Invidiarsi vuol dire, perciò, sperimentare l’attacco che l’invidia può portare alla progettualità individuale.
Si tratta di una problematica diffusa nel nostro tempo, anche per la difficoltà a immaginare progetti di crescita e autorealizzazione partendo da appropriati esami di realtà. Le aspettative, troppo impropriamente sollecitate, spesso vedono l’immaginazione di sé trasformarsi in illusione vuota e i percorsi di autorealizzazione sono a rischio di annichilimento. La seconda è l’invidia propriamente detta. L’equilibrio, tra l’autonomia e l’effettivo esistente da un lato, e le aspettative a cui si tende, il desiderio che trascina, dall’altro, non sempre è efficace. Accade, in caso di equilibrio inefficace, che si può rinunciare alla propria autonomia e al proprio linguaggio specifico per adottare, invidiosamente, quello dell’altro, in una dispersione imitativa che può risultare autodistruttiva. È, per molti aspetti, quello che sta facendo la cosiddetta sinistra in Italia negli ultimi anni, invidiando e di fatto imitando la destra. La terza è l’invidia sociale. I rinforzi storici e culturali dei processi invidiosi emergenti nelle relazioni interpersonali possono indurre dei veri e propri “vertici” sociali o equilibri nelle relazioni sociali diffuse, basati sull’invidia. In questi casi le energie appaiono investite prevalentemente nel cercare di impedire le iniziative degli altri, nel tendere a fare in modo che non vi siano progetti innovativi efficaci capaci di mettere in evidenza la propria mediocrità o incapacità. L’attacco principale di questo tipo di invidia, così come del resto per l’autoinvidia, è verso l’innovazione e la progettualità sociale.
L’invidia si associa al conflitto della conoscenza: a quel processo in base al quale ogni conoscenza innovativa entra in conflitto con quelle esistenti e dalla elaborazione di quell’incontro tra differenze, quale il conflitto è, emerge una conoscenza innovativa. L’invidia del nuovo, anche in forma di autoinvidia, è una costante, sia in quanto mobilita verso la ricerca e l’innovazione, sia in quanto può assumere una propensione distruttiva e impedire che l’innovazione emerga e si affermi. Siamo ancora una volta alla biforcazione tra invidia e gratitudine. La visibilità del nuovo, essendo l’innovazione la condizione stessa della vita, meriterebbe la cura da riservare ad ogni eccedenza e ad ogni discontinuità. Eppure non è così, nella maggior parte dei casi, nel tempo in cui viviamo.
Si è mai visto qualcuno che si fa indietro dopo aver pensato una buona idea? È mai successo che si rinunci a realizzare un progetto per timore di non farcela? Sì, è successo e continua a succedere. “Tanto non ce la farò mai”, è un’espressione molto frequente. Ognuno di noi l’ha pronunciata almeno una volta o a se stesso o a qualcun altro. “Bella da morire!”, come diceva sempre Luigi Pagliarani, è un’espressione emblematica. Può riferirsi a un’idea, a una cosa o a una persona. Chiedendosi con un po’ di attenzione perché mai si usa quel modo di dire, è possibile accedere a una ben strana esperienza che allo stesso tempo pare molto diffusa: l’autoinvidia. Si potrebbe dire: ma come? Cosa significa invidiare se stessi? Beh! Significa non vedere le proprie capacità di realizzare il possibile pur avendolo concepito.
È proprio il possibile che ci fa difetto in questo nostro tempo che inventa e reinventa il passato celebrando riti alla tradizione e facendo del revival etnico un modo di essere e di vivere costante.
Eppure il possibile e il senso del possibile sono prima di tutto manifestazioni fondamentali di noi esseri umani, che abbiamo tra le caratteristiche essenziali quella di sporgerci dall’essere verso il poter essere e il dover essere, cioè di protenderci a diventare quel che ancora non siamo o a far accadere quello che ancora non è. A distinguerci come specie è una tensione verso il possibile, verso l’oltre rispetto a ciò che siamo e che esiste. Come diceva sempre Aldo Giorgio Gargani, e come ha scritto ne Il coraggio di essere, siamo un progetto e un’invenzione.
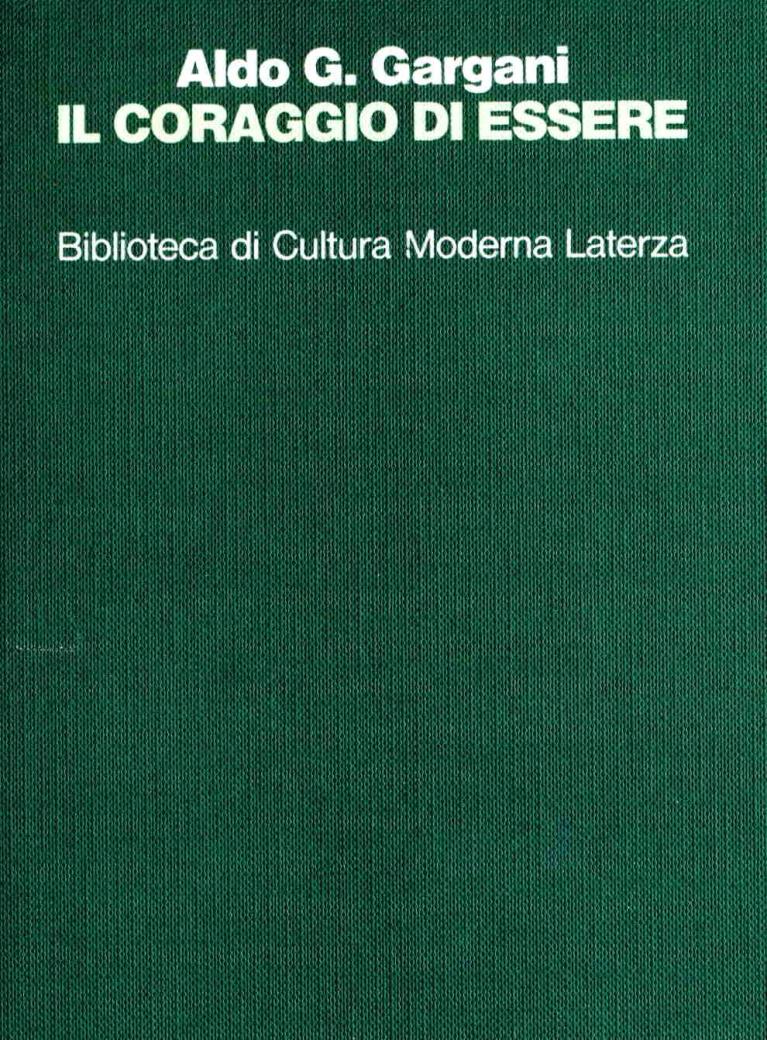
Quella propensione è stata definita “tensione rinviante” in uno studio sull’arte e la creatività umana pubblicato in Mente e bellezza. Arte, creatività, innovazione, per cogliere il nostro modo di tendere a quello che ancora non c’è, per cercare di comprendere la nostra capacità creativa con cui mostriamo di combinare e ricombinare le cose del mondo e noi stessi in modi almeno in parte originali; per individuare quella capacità che è sodale della nostra inquietudine, per cui siamo sempre solo in parte appagati e soddisfatti, per ricominciare poi a cercare. Esprimiamo questa nostra tensione certamente nella creazione artistica, ma la ritroviamo distribuita nella vita quotidiana, quando le condizioni di possibilità sono almeno in parte soddisfatte. E non sono solo le condizioni materiali ad essere rilevanti, ma soprattutto quelle culturali e educative e politiche.

Era stato Robert Musil ne L’uomo senza qualità a cogliere da par suo la rilevanza del senso del possibile: “…..se il senso della realtà esiste, e nessuno può mettere in dubbio che la sua esistenza sia giustificata, allora ci dev’essere anche qualcosa che chiameremo senso della possibilità”. Musil chiama “attitudine creativa” quella capacità umana. È una capacità di cui disponiamo e che utilizziamo poco, anche perché siamo principalmente protesi e anche educati al conformismo.
Nonostante i vincoli della propensione al conformismo, sempre Musil mette in evidenza l’agire umano positivo nella dimensione del possibile.
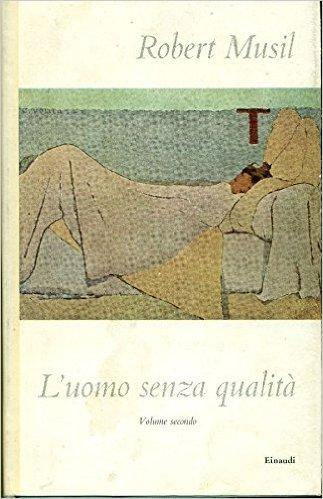
“Un’esperienza possibile – scrive ancora Musil – o una possibile verità non equivalgono a un’esperienza reale e a una verità reale meno la loro realtà, ma hanno, almeno secondo i loro devoti, qualcosa di divino in sé, un fuoco, uno slancio, una volontà di costruire, un consapevole utopismo che non si sgomenta della realtà bensì la tratta come un compito e un’invenzione”. Da par suo Musil sostiene, infine: “ È
la realtà che suscita la possibilità, e nulla di errato come il negarlo”.
Spesso si contrappone la realtà alla possibilità e si vede nella realtà qualcosa di intrinsecamente negativo, capace soltanto di resistere e di opporsi. Ora, indubbiamente, il reale ha questa caratteristica. Al tempo stesso, però, è la fonte del possibile, perché è proprio a partire da quello che c'è che si aprono le possibilità. Dentro alla realtà, a quello che c'è, è per così dire "incassata" la possibilità, quello che può esserci. È proprio perché ognuno di noi è quello che è, con la sua storia e la sua natura, che gli si aprono certe possibilità invece che certe altre.
L’autoinvidia è proprio la condizione che, tra l’altro, vincola l’opportunità di riconoscere la realtà incassata nella possibilità.
Nella tradizione delle arti visive l’invidia è rappresentata con un sistematico ricorso alle categorie del brutto e viene associata al deforme e al deformante. Si tratta in molti casi della trasposizione in arte dell’invidia come peccato capitale. È
il caso di Ensor che dipinge l’invidia come attacco all’amore: l’invidia non sopporta di vedere la giovane madre che allatta il suo bambino. Se l’invidia può essere considerata come un attacco all’amore, l’autoinvidia sembra proporsi come attacco all’amore di sé. Nella negazione di una parte di noi da parte di un’altra parte, invidia e autoinvidia si intrecciano e sembrano ridurre, intralciare o rendere impraticabile in modo evidente il senso del possibile.
Proviamo a seguire questa storia, che descrive un fatto realmente accaduto.
“Sotto la pergola la sera era dolce. In quei giorni di fine agosto l’estate dava il meglio di sé. Finito il raccolto del grano vi era una pausa nelle fatiche dei campi e da anni in quel periodo, alla bottega si organizzava il torneo di scopa. Anche il prete acconsentiva ad un’esperienza innocente dove in palio era un caffè fatto con la caffettiera, ma con maestria. Durava alcune sere e quell’anno sembrava proprio che la sorte rivolgesse il suo sguardo benigno a Luigi il pastore detto “cotica tosta”, cotenna dura. Era lui l’eterno finalista e eterno secondo. A vincere ci pensava mastro Gino. Quel muratore con l’accento napoletano e le competenze professionali improbabili, la cui fortuna con le carte era proverbiale. Un uomo piccolo, con una paglietta ingiallita, gli occhi vispi e furtivi e la giacca sgualcita eternamente a tracolla, indice, per la gente del luogo, di una predisposizione alla pigrizia; il mozzicone di “alfa” connaturato in bocca. Luigi era alto, con le mani forti e un eterno odore di pecora addosso. La sua camicia a scacchi con i polsini arrotolati aveva ceduto i colori ai raggi del sole ma resisteva al tempo e alle fatiche. In testa aveva una coppola che sbatteva sulla coscia destra quando le parole non gli bastavano per sostenere le proprie ragioni. Verso la conclusione della partita finale, in condizioni di quasi parità, Luigi mostrava una certa baldanza e stringeva tra le mani le carte arcuate e spesse dall’unto e dal sudore, per il troppo uso. Mastro Gino era ironico e impassibile e mugugnava di “scienza” dicendo ogni tanto: non è finita. Fu all’ultima mano che, dopo la distribuzione delle carte, i giocatori e quel nucleo di spettatori silenzioso in piedi o distribuito sulle poche sedie della bottega, capirono con un rapido calcolo che Luigi, pur avendo il sette di danari, avrebbe dovuto cederlo a mastro Gino, dandogli così con quel punto, la primiera, le carte di danari e la vittoria. Lo capì anche Luigi e, digrignando i denti, con un gesto che avrebbe segnato la mitologia del villaggio per anni, azzannò il sette di danari divorando e inghiottendo la carta unta e resistente di fronte al volto allibito di mastro Gino e alle esclamazioni di stupore degli astanti. Persino i passeri interruppero per un istante il loro concerto serale sulle querce tra la bottega e la chiesa.”
La seconda storia, elaborata da un wiz popolare. “Un contadino, tornando a casa dai campi verso sera, incontra, a una svolta del sentiero, Aladino, che dopo averlo salutato gli dice: prendi con te questa lampada che contiene un genio; potrai chiedere al genio tutto quello che vuoi, ti basterà strofinare la lampada per ottenerlo. Di fronte allo stupore del contadino Aladino lo rassicura, dicendogli che non vi sono limiti alle richieste possibili e che se vuole può consultarsi con la moglie, avendo la notte a disposizione. Basta che l’indomani all’alba si faccia trovare in quello stesso posto con la lampada e il desiderio individuato. Il contadino confuso e raggiante lo ringrazia e sta per allontanarsi verso casa, quando Aladino lo richiama e gli dice: scusami, avevo dimenticato una piccola cosa; tu potrai chiedere qualsiasi cosa e l’avrai; sappi che tutto quello che avrai, il tuo vicino lo riceverà nella misura del doppio. Il contadino ascoltò impietrito e si avviò con passo lento e incerto verso casa. Trascorse la notte insonne con la moglie cercando una soluzione. Nel momento in cui sembrava loro di poter chiedere dieci mucche, una vera ricchezza, si fermavano di fronte al fatto che il vicino ne avrebbe avute venti. Se pensavano di chiedere un ettaro di terreno, li bloccava il fatto che il vicino ne avrebbe avuti due. E così via. La notte passò lenta e la mattina dopo all’alba il contadino andò incontro ad Aladino assonnato, con gli occhi rossi e con passo triste. Vedendolo Aladino gli chiese cosa fosse mai accaduto; se avessero trovato una soluzione per una proposta che sembrava allettante. Il contadino rassegnato gli rispose: accecami un occhio.”









