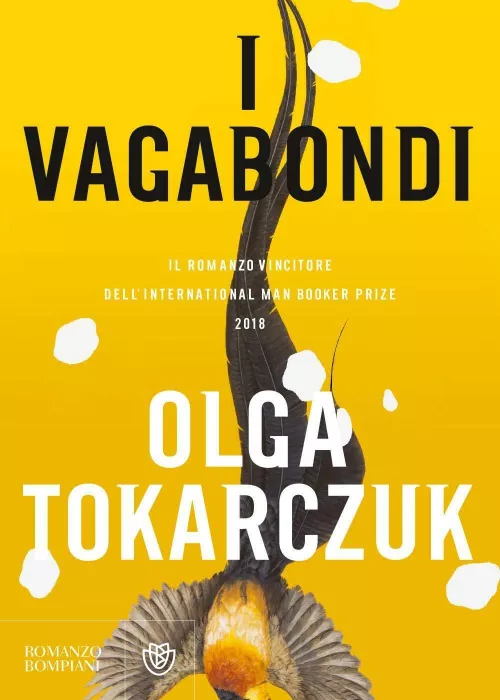Viaggiare / Olga Tokarczuk, I vagabondi
«Volo da Irkutsk a Mosca. Si decolla da Irkutsk alle otto del mattino e si atterra a Mosca alla stessa ora – otto del mattino dello stesso giorno. Questo è il momento esatto in cui sorge il sole, quindi si vola per tutto il tempo all'alba. Si rimane in questo singolo istante, grande, tranquillo, espanso come la Siberia. Dovrebbe essere il momento per la confessione di un'intera vita. Il tempo scorre all'interno dell'aereo, ma non fuoriesce all'esterno.»
Il viaggio è una luce sempre accesa, è un’ansia, è una ricerca, il viaggio è la solitudine estrema e il suo contraltare. Il viaggio è una persona che ne incontra un’altra, il viaggio è la storia personale che si mescola a quella degli altri. Il viaggio è un odore, una vaga speranza, è una possibilità da rinnovare ogni giorno. Il viaggio è il fuso orario che cambia, un riparo, una doccia non fatta, un letto ricevuto in regalo. Il viaggio sono mani che si toccano, spalle che si sfiorano, sono gli aeroporti, i porti, sono i treni, sono le banchine delle stazioni.
I viaggi sono l’unica vera casa che abbiamo, sono tutto quello che impariamo, sono poi quello che lasciamo. Il viaggio è cultura ed è aver cura. Il viaggio è sradicamento, è una donna sola che asseconda il vento, è una nuova misurazione del tempo. Il viaggio è un abbraccio in un altro territorio, è una stanza dove non disfare le borse, è un libro trovato su un comodino, lo stesso libro lasciato su una panchina. Il viaggio non è mai un miraggio, sono le parole scambiate all’alba con uno sconosciuto, mentre aspettiamo un traghetto per chissà dove. Il viaggio non è mai il luogo dove si va, perché non è mai una destinazione, ma è più spesso un destino.
«È proprio in questa direzione che mi muovo paziente nei miei viaggi, cercando gli errori e gli incidenti della creazione.»
Il viaggio è dimenticarsi di sé per trovare altro, per farsi cogliere da una luce inattesa “Una luce inattesa ci aveva rapiti fin dall’inizio. Mentre ci inoltravamo nell’indicibile splendore di quel primo mattino ci sembrava davvero di essere penetrati in una sorta di mondo incantato, per il quale non ci sentivamo pronti.”, scriveva Jason Elliot, una ventina d’anni fa, nel suo splendido Una luce inattesa. Viaggio in Afghanistan (Neri Pozza, 2002, trad. M. Ghilardi), uno dei libri di viaggio più belli che io abbia mai letto. Elliot tra le montagne dell’Afghanistan, tra Faizabad e Herat, andava a cercare di capire un popolo, bevendo il tè con i ribelli, spostandosi su mezzi di fortuna. Olga Tokarczuk, nel suo I vagabondi (Bompiani, 2019, trad. Barbara Delfino), sostituisce le montagne con le sale d’attesa degli aeroporti, la neve e il deserto con bar sperduti e distributori di benzina, ma cerca, come Elliot, la luce inattesa quella che arriva dopo l’alba, quando sulla strada si scorge la prima persona venirci incontro.
«Ogni volta che parto scompaio dalle mappe».

Scrive Tokarczuk, ed è una vera dichiarazione di poetica, ancor più che d’intenti. Significa rinunciare alla definizione del luogo, del posto, del termine del viaggio. Per la scrittrice polacca non esiste l’arrivo e la sua partenza coincide con gli anni in cui era bambina, una sera in cui fu lasciata a casa da sola e tra suggestione e preveggenza «ho scoperto per caso il limite del mondo […] perché per un attimo mi hanno lasciato sola, incustodita», scoprì la voglia di uscire «ma non saprei dove andare»; la sua forza sta proprio nel non averlo mai saputo. Tokarczuk è vagabonda, ma – attenzione – se proviamo a farci caso, lo siamo tutti, basta scomparire dalle mappe.
I vagabondi ha vinto l’International man booker prize l’anno passato, è un’opera di narrativa, è un memoir, è un taccuino, è un libro di viaggio; è una storia nomade che attraversa il tempo e restituisce all’incontro e all’ascolto dell’altro la sua centralità. La scrittura di Tokarczuk è fatta di molti tessuti, a volte scorre con velocità di un fiume in prossimità delle rapide, altre volte si concede la lentezza di una passeggiata in mezzo ai campi. La costruzione ricorda la piazza di un mercato popolare. Ogni storia arriva nel centro della piazza da un punto diverso, non importa in che ordine. A volte è una storia lunga, un vero e proprio racconto; altre è la trascrizione di un appunto o la descrizione di ciò che l’autrice ha davanti agli occhi.
Troviamo piccoli brani di venti righe, capitoli lunghi una pagina, a volte due, qualche volte delle storie che superano la decina di pagine. Troviamo delle lettere arrivate dal passato. Ciò che sta a pagina cento potrebbe stare altrettanto bene a pagina trecento. Non essendoci la mappa del viaggiatore, non può che scomparire anche quella dello scrittore. I capitoli perciò hanno titoli ma non hanno numeri. Una conversazione riportata a pagina sessanta, è facile che venga ripresa ottanta pagine più avanti. Il lettore può fare avanti e indietro proprio come si fa con i libri di poesia, facendo un salto di dieci pagine per rileggere un verso, per attraversare una seconda volta un ponte.
«Guardarsi intorno ancora una volta è come osservare un quadro nel quale sotto milioni di particolari c’è una forma nascosta nel caos. Una volta vista non si può dimenticare.»
Donne e uomini normali, donne e uomini fuori dall’ordinario. La scrittrice si siede a tavola con sconosciuti, osserva le persone ai margini di conferenze tenute all’interno degli aeroporti, racconta del dottor Blau, un anatomista molto particolare, ci dice di Cioran e di Cleopatra, dei bieguni, nomadi slavi che si muovono contando sulla gentilezza altrui. Di balene e di marinai perduti. Una donna che sente il bisogno improvviso di allontanarsi da casa e per giorni interi viaggerà lungo le linee della metropolitana, chiederà a una barbona di dormire con lei, di raccontarle la sua storia. Un’altra donna sparirà per alcuni giorni con il suo bambino, su una piccola isola durante una vacanza. Apparirà in due momenti del libro, nella prima troveremo suo marito e la sua spasmodica ricerca della moglie e del figlio; nella seconda li ritroveremo più avanti, tutti e tre a casa, ma con una domanda senza risposta, e non saranno ancora in salvo. Ogni tanto qualcuno vuole (deve) sparire. Leggeremo la storia della sorella di Chopin che porta il cuore del fratello morto da Parigi a Varsavia.
Proprio questo brano così commovente risponde almeno in parte a una delle domande che pone Olga Tokarczuck, ovvero che il viaggio è sempre una sorta di ritorno, non alla casa da cui siamo partiti, non a una nuova, ma un ritorno al cuore di noi stessi; la conoscenza del nuovo, il bagaglio leggero che si riempie piano piano, prende il nostro cuore e lo riporta a casa. L’altro tema che il libro affronta riguarda un diritto, quello di reinventarsi da un’altra parte, e non una volta sola, un diritto che molti non conosceranno, che molti altri non sapranno mai di avere.
«Sembra proprio che esista un punto fisso attorno al quale continuo a girare. Da cosa troppo lontano e a cosa troppo vicino?»
L’altra cosa che si impara da I vagabondi – un libro davvero illuminante – è che si viaggia ogni volta che lasciamo da parte i preconcetti e tutto ciò che crediamo di sapere per ascoltare la parola, la lingua, i motivi dell’altro. Allora il luogo non ha più ragione di essere nominato perché il movimento riguarda tutto, saremo in viaggio nella sala d’attesa del medico, lo saremo al supermercato, lo saremo quando condivideremo un pensiero, prima ancora di un pezzo di pane.
Un libro, infine, sul futuro; ecco quel che saremo. Diventeremo nomadi perché già lo siamo, noi che fatichiamo ad accogliere, chiederemo accoglienza. Partire è un metodo, un rimedio, il miglioramento della nostra capacità cognitiva, la consacrazione della curiosità, un modo di stare nel mondo a perduta dimora.