La macchina del gene / Venki Ramakrishnan, peripezie di un premio Nobel
“Capii allora che non dovevo vergognarmi di ciò che non sapevo perché nessuna domanda è troppo stupida se ti interessa la risposta”.
Detto da un premio Nobel, vale la pena rifletterci. E anche considerando – come annota Venki Ramakrishnan nell’epilogo” del suo La macchina del gene, di recente tradotto e pubblicato da Adelphi – che ai premi Nobel capita sovente di essere invitati in radio o alla televisione dove possono pontificare su qualsiasi cosa, perfino sul futuro del mondo: e quando si diventa famosi all’improvviso, la tentazione può essere grande. Vale la pena rifletterci, invece, perché Venkatraman Ramakrishnan ricorda di averlo pensato a Cambridge, tra il 1991 e il 1992, ai seminari del Laboratory of Molecular Biology, ascoltando le domande di Max Perutz, uno scienziato che premio Nobel lo era già dal 1962 e fondatore dell’LMB in quello stesso anno insieme a Francis Crick e James Watson, gli scopritori del DNA, e a John Kendrew.
Di Crick e Kendrew Perutz era stato supervisore del dottorato, di James Watson advisor post doc: in quel medesimo 1962 che li laureò Nobel tutti e quattro – Perutz e Kendrew per la Chimica, Crick e Watson (insieme a Maurice Wilkins) per la Medicina – spostarono i loro laboratori in un edificio a quattro piani alla periferia meridionale di Cambridge: nasceva, “con il botto”, il MRC Laboratory of Molecular Biology, da quel momento uno dei luoghi leggendari della ricerca scientifica internazionale. In quelle aule dove Ramakrishnan arrivò per un sabatico tra il ’91 e il ’92, Perutz e Aaron Klug, altro eminente biologo molecolare e allora Direttore del laboratorio, senza alcun imbarazzo facevano domande che risultavano banali per gli addetti ai lavori. Fatto sta che a loro interessavano le risposte.
A chi interessasse capire come un giovanissimo studente indiano cresciuto nel Gujarat, innamorato della fisica teorica e ispirato da Richard (the genius) Feynman, sbarcato negli Stati Uniti nel 1971, possa ritrovarsi a Stoccolma quasi quarant’anni dopo, seduto di fianco alla Principessa Vittoria, in attesa che un annoiato Carl Gustav XVI gli consegni la medaglia del Nobel per la chimica, non resta che salire a bordo di La macchina del gene e, insieme a quella, delle molte automobili e furgoni sui quali Ramakrishnan ha caricato moglie, figli e suppellettili varie, traslocando per tutti gli Stati Uniti, ogni volta ripartendo dalle basi. Ché, come chiude il suo affascinante racconto, i suoi inizi non erano stati promettenti, più volte aveva imboccato strade senza uscita dopo innumerevoli false partenze e rischiando addirittura di sparire dal mondo della scienza: destino che ha sempre evitato soltanto “cambiando rotta e ricominciando da capo”.
La “macchina” di cui al titolo di un’autobiografia a un tempo personale e di un’avventura di ricerca, è il Ribosoma. Ogni molecola in ogni cellula di qualsiasi forma di vita viene assemblata da questa minuscola macchina, e se quella molecola è costituita da enzimi – le strutture che “catalizzano”, ovvero accelerano le reazioni chimiche – anche loro sono prodotti dal ribosoma. Nel tempo che basta per leggere una pagina della sua autobiografia, ci avverte l’autore, i ribosomi di ognuna del migliaio di miliardi di cellule del nostro corpo hanno prodotto migliaia di proteine. E sono le proteine che ci permettono di vedere la luce, di muovere i muscoli, di sentire il caldo e il freddo e di combattere le malattie. Quando leggiamo, scriviamo, ricordiamo, quando proviamo qualsiasi emozione, è grazie alle proteine. Ogni cellula ha bisogno delle proteine non solo per mantenere la sua struttura e la sua forma: gli servono per poter funzionare. E a quel bisogno provvede incessantemente, il ribosoma, la macchina del gene. Una meraviglia biologica. Ma che cos’è?
Intuitivamente, ciascuno di noi ha un’idea – o almeno pensa di averla – del DNA e di come funziona, tanto è vero che “fa parte del… o non è nel suo DNA” è diventato un luogo comune del discorso, applicato agli ambiti più distanti da quello biologico, un’affermazione lasciata cadere come se il significato sia patrimonio comune. In parte se ne comprende la ragione: di fatto la struttura della molecola del DNA, i due filamenti avvolti a formare la famosa doppia elica, orientati in direzione opposta, con le quattro basi azotate (Adenina, Timina, Citosina, Guanina) i cui nomi impariamo a scuola, suggerisce quasi direttamente come i geni possano essere duplicati e trasmessi ereditariamente. Ma fu James Watson, giocherellando con le rispettive sagome di cartone, ad intuire che le basi potevano legarsi solo esclusivamente: l’Adenina di un filamento con la Timina dell’altro, e così la Citosina con la Guanina. In sostanza, l’ordine delle basi di un filamento determina esattamente quello sul filamento opposto. Al momento della divisione cellulare, i due filamenti si separano, ognuno contenendo l’informazione necessaria per fare da stampo dell’altro: due copie di DNA a partire da una.
Crick e Watson avevano scoperto niente meno che il meccanismo di trasmissione delle caratteristiche ereditarie. Ma non come l’informazione contenuta in ciascun gene fosse poi concretamente usata per produrre le proteine, tutte quelle che ci servono per vivere. Sebbene Francis Crick avesse capito che la sequenza delle basi del DNA rappresentava il codice che determinava l’ordine degli amminoacidi in ogni singola proteina, il problema era capire come: come passare da quattro basi a venti aminoacidi diversi? Problema troppo complesso. Per qualcuno come Sydney Brenner, che il Nobel lo conquisterà nel 2002, addirittura secondario e di cui a Cambridge non valeva la pena occuparsi, tanto era roba che facevano negli Stati Uniti. Sydney Brenner era stato uno degli scopritori dell’mRNA, la molecola che trasporta il messaggio genetico dove serve; Francis Crick aveva scoperto anche la funzione di un’altra molecola chiamata RNA transfer (tRNA) che legge e trasferisce gli amminoacidi in maniera appropriata. Tutti però si erano accorti della presenza, dentro ogni cellula, di migliaia di corpuscoli dalle dimensioni infinitesime, se pensate in base a standard normali, ma che in termini molecolari apparivano enormi: ognuna conteneva circa cinquanta proteine e tre grandi unità di RNA. Alla fine degli anni ’50, nel corso di una conferenza le “particelle ribonucleicoproteiche della frazione microsomiale” furono battezzate “ribosomi” da uno scienziato di nome Howard Dintzis: almeno il nome si capiva meglio. Ma non il funzionamento. Che fosse il crocevia della vita, la macchina in grado di collegare i geni alle proteine, all’inizio degli anni ’50 era già chiaro a tutti; che fosse composto da circa mezzo milione di atomi, distinti in due masse informi, una più grande e una più piccola, anche. Ma come comprenderne il funzionamento senza conoscerne la struttura?
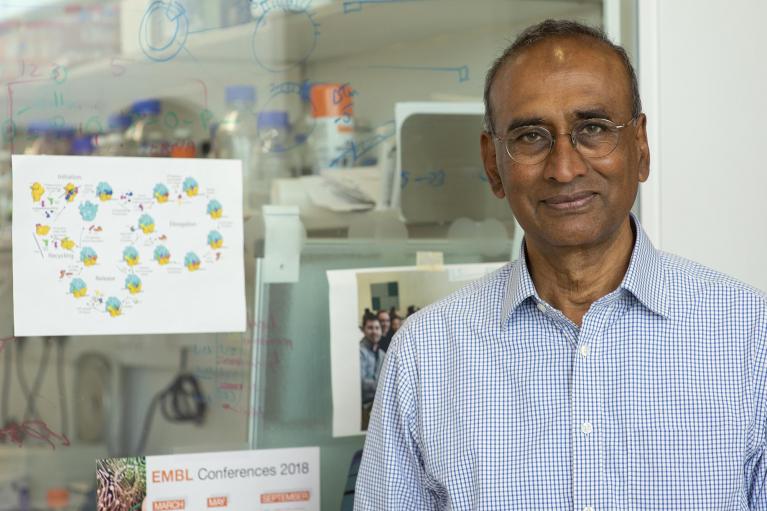
“Immaginate di essere marziani che guardano la Terra dall’alto – suggerisce Ramakrishnan – sulla superficie del pianeta vedreste minuscoli oggetti che si muovono soprattutto in linea retta, facendo qualche svolta occasionale. Avvicinandovi un po’ di più potreste notare che questi oggetti si muovono soltanto quando altri oggetti, ancora più piccoli, vi entrano dentro e smettono di muoversi quando questi escono nuovamente fuori. Mediante sensori potreste scoprire che consumano idrocarburi e ossigeno ed emettono diossido di carbonio e acqua oltre ad alcune sostante inquinanti e a calore. Però non avreste alcuna idea di cosa siano effettivamente questi oggetti, per non parlare di come funzionano. Soltanto conoscendo la loro struttura dettagliata potreste notare che sono formati da centinaia di componenti che lavorano insieme e hanno, in particolare, un motore connesso a un albero motore che fa girare le ruote. Ma dovreste compiere un’osservazione ancora più minuziosa per capire che il motore a sua volta è provvisto di camere con pistoni e risucchia un miscuglio di carburante e ossigeno che viene incendiato mediante una scintilla di una candela di accensione in modo da produrre uno scoppio e spingere il pistone verso l’alto”. Così funziona un’automobile, così accade con le molecole. E Venki Ramakrishnan ci accompagna in un viaggio dove la metafora “meccanica” e “automobilistica” ricorre più volte. Non a caso, come vedremo.
Nel leggere il suo memoir possiamo ripassare alcune nozioni di chimica e biologia che dovrebbero far parte del bagaglio di conoscenze minime e comuni provviste dalla scuola dell’obbligo, ma che raramente rimangono nella memoria di chi, professionalmente o per curiosità, abbia intrapreso altre strade: un viaggio a ritroso che può riportare alla mente antiche cartoline. Sicché, oggi che assistiamo alla corsa per capire struttura e funzionamento di Covid-19 – e parallelamente, e complementarmente, delle sostanze che ci possono vaccinare e o curare – si tratta di un esercizio e di un viaggio tutt’altro che oziosi. Semmai ce ne fosse stato bisogno, la pandemia ci ha ricordato che capire come funziona la ricerca scientifica non è accessorio e nemmeno circoscrivibile al genere dell’intrattenimento colto. Così, farsi guidare da Venki Ramakrishnan nel suo ritorno al futuro da Stoccolma alla Baroda University, e poi un po’ dappertutto negli Stati Uniti, e a Cambridge e in giro per convegni e seminari a varie latitudini, significa capire la complessità di un’impresa fatta di collaborazioni e di feroce competizione, di mode, di scienziati “farfalla” capaci di passi pioneristici ai quali non danno seguito mentre altri colleghi perseguono con tenacia i propri obiettivi per decenni, non facendosi scoraggiare dall’apparente insolubilità dei problemi che incontrano.
Il piacere intellettuale che la lettura di La macchina del gene assicura poggia sulla forma di questo racconto che procede, capitolo per capitolo, restituendo quella del suo oggetto d’indagine. Che è una macchina, una macchina molecolare – o una nano macchina, come la chiameremmo ora – che usa energia per muoversi, spostando l’RNA messaggero e aiutando il tRNA a leggere i codoni (così si chiamano le basi lette a gruppi di tre alla volta). Venki Ramakrishnan si sposta come il ribosoma, nel tempo, muovendosi su due piani principali della narrazione, in un serrato e continuo flash back and forward tra biografia scientifica personale e quella delle tante scoperte senza le quali lui, e insieme a lui tanti colleghi, non avrebbero potuto avanzare nella comprensione. E si sposta anche nello spazio. Lo conosciamo, nel prologo a Yale nel 1980, quando segue per caso la conferenza di un’oscura ricercatrice di origine israeliana, Ada Yonath, che avrebbe poi ritrovato infinite volte fino a sedersi tra lei e la principessa ereditaria di Svezia, il 10 Dicembre 2009, ambedue in attesa della medaglia Nobel. Subito dopo, ma è la sera del 17 Maggio 1971, è in Ohio, appena atterrato a Urbana Champaign, felice all’idea di seguire i corsi di fisica della locale università, sorpreso da una folata di vento gelido che mai aveva sperimentato nel Gujarat dal quale proveniva, scioccato dalla poca convenzionalità degli studenti del college americano, vestiti di abiti hippy e manifestanti per la pace, al punto di provare a raggiungere gli unici giovani che gli sembravano vestire come lui, salvo accorgersi che erano agenti dell’FBI infiltrati.
A Urbana conoscerà Vera Rosenberry, una donna da poco separata e con una figlia di quattro anni e, a ventitré anni, si ritroverà sposato e già padre di una figlia di cinque. Ma, più che altro, consapevole che quella rivoluzione dei costumi che aveva appena conosciuto, nella fisica c’era stata all’inizio del ‘900, mentre quella della biologia molecolare, iniziata con la scoperta della struttura del DNA, era ancora in pieno svolgimento. “Presi la difficile decisione di ricominciare da capo la graduate school”: difficile ma lungimirante. Gli Stati Uniti degli anni ’70 si confermano terra per le opportunità. A Ramakrishnan la offre Dan Lindsley dell’UC di San Diego, e Venki affitta un camioncino Ryder, ci carica moglie e due figli – nel frattempo si è aggiunto un neonato – e si trasferisce in California. Al pari delle proteine di trasporto che studierà tutto il resto della sua vita, attraversa confini come fossero membrane. Il ribosoma lo incontra, la prima volta, in un articolo pubblicato da Scientific American firmato da Don Engelman e Peter Moore: amore a prima vista. Moore è la quintessenza dell’intellettuale della Ivy League (“mi chiedo se sia mai riuscito davvero a capire cosa vuol dire non far parte per tutta la vita di istituzioni elitarie”) e un pozzo di conoscenza, anche di storia e letteratura. Altro camioncino, altro trasloco e alla fine dell’estate del 1978 la famiglia si ritrova a New Haven.
Dove, tra le mille altre cose, ne impara una oggi molto utile se si vuole comprendere come funziona la ricerca scientifica: che non può fermarsi ai confini delle discipline, che invece deve continuamente attraversarli, come si fa con le membrane cellulari, come Ramakrishnan ha fatto con gli stati dell’unione. A Yale, da Peter Moore, capisce che dei neutroni non si occupano solo i fisici, e che il loro impiego può essere fondamentale per studiare le strutture biologiche. Per fortuna, racconta l’autore, l’Oak Ridge National Park in Tennessee, agli inizi degli anni ’80, aveva aperto un laboratorio dedicato allo scattering neutronico e cercava qualcuno con una solida preparazione fisica che potesse collaborare con i biologi. Questa volta la macchina è una piccola Ford Fiesta, dove Venki e Vera caricano tutto quello che poteva servire per trasferirsi, nel 1982, da New Haven nel Tennesse, passando attraverso una bufera di neve e ghiaccio in Pennsylvania. Ma dura poco, il laboratorio di biologia in effetti non c’è. Soltanto quindici mesi dopo, nell’estate del 1983 il nuovo trasloco è verso il Brookhaven National Laboratory a Long Island, dove il direttore Benno Schoenberg gli offre una posizione. Nuova macchina, nuova metafora automobilistica: a Brookhaven pochi apprezzabili progressi nella comprensione del ribosoma, “era come esaminare un mucchio di pneumatici e pistoni tutti separati senza avere una vaga idea di come fossero montati”. Dopo dieci anni da che è sbarcato negli USA, a Venki Ramakrishnan sembra che la sua seconda carriera non stia facendo miglior fine della prima.
Non sarà così, ovviamente, già lo sappiamo e seguiranno molti altri traslochi e viaggi, compreso quello della “settimana a Stoccolma”. Pure l’inciampo di Brookhaven non sarà l’ultimo, insieme alla sensazione di girare a vuoto nel seguire un’avventura che invece porterà alla “visione”, in senso metaforico e non, della molecola del ribosoma. Per “vedere l’invisibile” Ramakrishnan ci riporta all’invenzione del microscopio, alla scoperta dei raggi X, agli esperimenti di William Bragg che per la prima volta fanno “vedere le molecole” con la tecnica della cristallografia a raggi X. Le vedrà anche Dorothy Hodgkin lavorando su quelle della penicillina e della vitamina B12, un’impresa definita epica al tempo, tanto da farle meritare il Nobel nel 1964. Un evento che dai giornali dell’epoca venne salutato con titoli del genere, “Una casalinga madre di tre figli ha vinto ieri il premio Nobel per la Chimica”. Perché la storia della scienza è anche storia di generi e di discriminazioni.
Ed è una gara. A volte, come racconta l’autore, senza esclusione di colpi, addirittura “all’ultimo sangue”, con dati e risultati tenuti nascosti mentre si cerca di capire quali progressi stiano conseguendo i team di ricerca avversari. Con stati d’animo contrastanti: la preoccupazione e lo sconforto quando un gruppo rivale si arricchisce di un nuovo fondamentale collaboratore, la riconoscenza giacché spesso “la scienza dipende dalla gentilezza degli estranei […] ma anche degli amici”; i “duri colpi” quando scopri che una collega ha una relazione con un avversario nella corsa… e ti scopri paranoico. Scoperta e sensazione che l’autore racconta di aver provato spesso, altrettanto sinceramente confessando che il più delle volte non era giustificata. Nel leggere le pagine di questa autobiografia si tocca con mano il peso del “publish or perish”, una delle distorsioni sovente denunciata nel mondo accademico: le nottate a scrivere gli articoli prima di renderli pubblici a un convegno, anticipando la corsa degli altri a pubblicare i loro.
E fino alla telefonata da Stoccolma che ti comunica che la corsa l’hai vinta tu, e magari intuendo che insieme a Gunnar Oquist che te lo sta annunciando, in viva voce c’è anche Mans Ehrenberg, un nuovo membro del comitato Nobel con il quale hai avuto un alterco ma che, tra le risate generali, viene al telefono e si congratula con te: “Quel giorno capii che Mans era davvero un uomo di grande integrità”. E pensi che forse è anche grazie a scienziati così integri che il Nobel mantiene il suo prestigio, pur nelle tante discussioni che ogni anno solleva.
E nelle tante esclusioni. Perché i Nobel scientifici possono andare, ogni anno, a non più di tre scienziati: quanti ne rimangono fuori? Quanti altri lo avrebbero meritato anche solo tra coloro che hanno partecipato alla corsa alla struttura del ribosoma? Nell’esperienza e nei ricordi di Venki Ramakrishnan sono domande che pongono il problema generale e ineludibile del rapporto tra competizione e collaborazione. Una tensione che oggi, dietro il fenomenale successo che ha portato la comunità scientifica internazionale a trovare, non uno, ma diversi vaccini sperimentalmente testati e validati al fine di contrastare l’epidemia di Covid-19, leggiamo tutta risolta nel verso della collaborazione. Sicché, mette in evidenza Ramakrishnan, non è detto che una sia sempre il bene e l’altra il male: le collaborazioni possono perdersi nell’inerzia e la competizione può stimolare le persone a pensare e lavorare più duramente. Ricordando che comunque, e sempre, gli scienziati che competono usano i progressi e risultati degli altri per andare più avanti, finendo per collaborare aldilà delle intenzioni. E a farne tesoro è comunque il progresso della scienza, e nel caso della struttura del ribosoma così da comprendere come il suo funzionamento in quello dei batteri può essere disarticolato dall’azione degli antibiotici. Fondamentale.
Nella prefazione di Jennifer Doudna, l’ultimo premio Nobel per la chimica assegnato nel 2020 insieme a Emanuelle Charpentier, nonché moglie di Jamie Cate, uno degli illustri esclusi dalla lotteria di Stoccolma, correttamente si legge che il racconto di Ramakrishnan va interpretato nello spirito dell’autobiografia e non del saggio storico imparziale: altri potrebbero metterne in luce il percorso e i personaggi in maniera anche sostanzialmente diversa. Ma lo spaccato “dietro le quinte” del tragitto verso un grande traguardo scientifico si disegna, nelle tortuosità e anche di quelle caratteriali dei protagonisti, in maniera chiarissima e di sicuro interesse.
E senza dimenticare che dietro ogni svolta si può intravedere l’orizzonte del traguardo come il buio della strada senza uscita. In quest’ultimo caso, raccomanda Venki Ramakrishnan, l’unico coraggio richiesto è quello di fare le valigie, caricare tutto su un furgoncino, cambiare rotta, mettersi in strada e ricominciare tutto da capo.









