Corrispondenza 1939 - 1969 / Roberto Longhi e Giuliano Briganti: l'importanza dei maestri
Cos’è un maestro? Quando ero allieva alla Scuola Normale Superiore di Pisa nei primi anni ’90, ricordo che serpeggiava fra gli studenti più giovani, e magari più brillanti, ma anche fra i perfezionandi, già più scafati, una sorta di diffidenza verso questa parola, forse perché in un posto competitivo e gerarchico come la Scuola Normale se ne abusava, e tutti anche per il solo fatto di seguire le lezioni del tale o tal altro professore, se ne dichiaravano allievi, o meglio dicevano: “il mio maestro” con allusione araldica a genealogie, paternità e figliolanze e in lontananza cenacoli, conventicole, concorsi e cattedre.
Da allora, e pur avendo avuto, dopo il dottorato, una frequentazione sporadica degli ambienti universitari, mi pare che la definizione abbia subito una sfortuna costante; quale studente oggi si riferisce più al proprio professore come al maestro? Direi quasi nessuno. Non sono in grado di risalire in modo preciso alle cause di questa sparizione, né di affermare che sia in assoluto una cosa negativa o positiva; constato che il baronaggio come malattia universitaria, come cancrena mentale e istituzionale, è continuato anche se il termine ‘maestro’, con tutto l’appannaggio reverenziale e di proselitismo che poteva accompagnarlo, è decaduto.
I due volumi pubblicati di recente da Archinto, Giuliano Briganti, Roberto Longhi. Incontri Corrispondenza 1939-1969 a cura di Laura Laureati e Giuliano Briganti Roberto Longhi, a cura di Giovanni Agosti, sono invece una testimonianza interessante e preziosa di un rapporto che non potrebbe leggersi senza recuperare una positiva e luminosa nozione di che cosa sia un maestro.
E tanto per cominciare Longhi non fu mai professore di corso di Briganti il quale, mentre Longhi insegnava a Bologna, studiava a Roma e si laureava con Pietro Toesca nel 1940. Né Briganti vinse una cattedra grazie a lui, anzi venne chiamato a ricoprire il ruolo accademico all’università di Siena molto tardi, all’età di 55 anni, nel 1973, tre anni dopo la morte di Longhi.
La loro conoscenza precedeva le aule accademiche, era avvenuta infatti in seno alla famiglia di Giuliano, figlio di due storici dell’arte, Aldo Briganti e Clelia Urbinati, entrambi laureatisi a Bologna con Igino Supino. Aldo Briganti si era poi dedicato alla ricerca e al commercio di dipinti antichi insieme a Longhi, e Giuliano già da ragazzino era stato mandato in giro per i musei d’Europa a formarsi l’occhio e la conoscenza dal vivo.
Briganti ha dunque intrattenuto con Longhi un rapporto fin dall’inizio intessuto su un modo di operare nei confronti della storia dell’arte molto concreto: scambi di fotografie, ricerche iconografiche, indicazioni su dove si trovi questa o quell’opera d’arte, progetti per riviste, questi sono molti dei contenuti che troviamo nello scambio epistolare pubblicato da Laura Laureati, e depositato dal 2018 nel Fondo Briganti della Scuola Normale Superiore di Pisa. Se ci furono discorsi teorici – e certamente ci furono nei primi anni della guerra, quando Briganti raggiungeva Longhi nella villa fiorentina il Tasso e studiava nella sua biblioteca e in seguito quando venne fondata la rivista Paragone – non lasciarono una traccia vistosa nella corrispondenza. D’altronde come ricorda Briganti, negli interventi riuniti nel libro, a cura di Giovanni Agosti, Longhi non amava il pensiero astratto, era un cultore della realtà, della concretezza, del porsi davanti all’opere cercando di ricollocarle nella storia e nel contesto in cui sono nate.
In questo, principalmente mi pare si possa dire che consista l’essere un maestro: nell’insegnare un metodo di lavoro. Briganti, in un articolo apparso a dieci anni dalla morte di Longhi, su Repubblica del 1 giugno 1980, rievocava le ore di studio condivise: “Molti anni fa, quando lavoravo nello studio di Roberto Longhi a Firenze – erano i primi mesi della guerra e spesso una sorda preoccupazione, una sorta di ignoto e indefinibile sgomento ci distoglieva, per vie diverse, da ogni presente impegno inducendoci a cercare possibili distrazioni, inventammo un gioco che proprio un gioco non era.
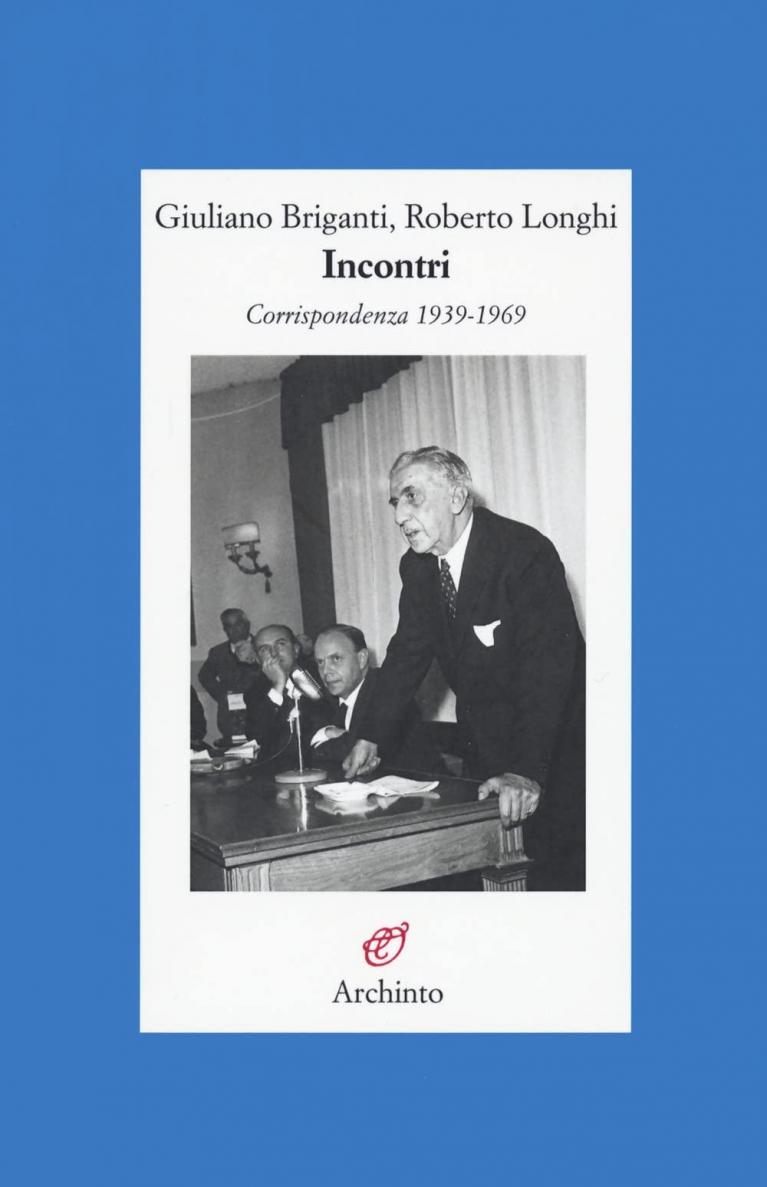
Ci mostravamo reciprocamente dei piccolissimi particolari di un dipinto o di una scultura, ricavandoli da fotografie ritagliate o in parte coperte: una mano, un dito, un occhio, la piega di un panneggio, la fronda di un albero, una nuvola, un ricciolo, sino all’estrema sfida di un’unghia o di un filo d’erba; e, analizzandoli e discutendone, dovevamo arrivare non a riconoscere l’opera per puro esercizio mnemonico, ma a «conoscerne» l’autore attraverso l’analisi dei pochi elementi a disposizione. Pochi, ma che «dovevano» essere sufficienti perché non potevano che indicare «una sola» epoca, «una sola» cultura, «una sola» scuola e «un solo» artista”.
E se vogliamo cercare una definizione più ampia e teorica la troviamo nel discorso introduttivo tenuto da Briganti ai corsi della Fondazioni Longhi dell’anno 1974-75, e riportato sempre nel libro curato da Giovanni Agosti: “Il rischio maggiore è quello di concepire le opere d’arte come punto di arrivo e non come punto di partenza, col pericolo di travisarne il significato, di adoperarle strumentalmente, di proceder addirittura in loro assenza. Ed anche qui interviene provvidenziale e categorico l’insegnamento di Longhi. Le cui opere sono lì ad avvertirci, se la si vuole intendere, che la storia dell’arte non può essere soltanto quella cosa che interessa esclusivamente chi la esercita, quella trama di sistemazioni filologiche, per altro indispensabile ma a circuito interno, che turba il sonno dei professori, accresce le nozioni e lavora alla costruzione del «grande inventario», ma è una cosa in cui è necessario travasare noi stessi e che quindi ci riguarda direttamente tutti; uno specchio in cui si riflettono i motivi più vivi e inquieti del nostro tempo”.
Travasare se stessi nella storia dell’arte significa compiere un investimento politico, civile, intellettuale ed emotivo che chiama in causa la coscienza individuale, per questo Briganti pur riconoscendosi allievo fino alla fine dei propri giorni di Longhi, rivendica gusti, scelte e campi di ricerca propri.
Come suggerisce Giovanni Agosti nella sua introduzione, sono numerose le inquietudini di Briganti e le passioni che lo portavano ad allontanarsi tanto dal padre quanto dal maestro, mai idealizzato, ma sempre presente. Ad esempio, la passione per il fantastico che s’insinua attraverso l’amato Orlando furioso e che trova prima corrispondenza nella tesi di laurea poi pubblicata con il titolo Manierismo e Pellegrino Tibaldi (1945) o con ben maggior audacia e su un terreno davvero alieno a Longhi, quello del romanticismo e del simbolismo, nel volume I pittori dell’immaginario. Arte e rivoluzione psicologica (1977).
Ripercorrere questo rapporto ha valore anche oggi, quando sono passati ormai trent’anni dalla morte di Giuliano Briganti e cinquanta da quella di Roberto Longhi, perché viviamo un momento di passaggio: fatichiamo a riconoscere autorevolezza ai padri e al tempo stesso ne patiamo l’assenza, stiamo, forse, cercando una mediazione diversa rispetto a quella figura di potere e sapere; nel frattempo potremmo prendere a esempio la libertà intellettuale e l’autonomia di pensiero che un vero maestro dovrebbe instillare nei suoi allievi, come ci testimonia Briganti in rapporto a Longhi.









