Trasformare se stessi / Vivere la filosofia: Pierre Hadot
“Tante cose sono belle a vedersi, diceva Schopenhauer, ma essere una di loro è tutt’altra cosa. La filosofia consiste nel coraggio di accettare consapevolmente il fatto di essere proprio una di loro”. Non c’è né narcisismo né megalomania in queste parole di Pierre Hadot, il filosofo francese di cui ricorre quest’anno il decimo anniversario della morte, avvenuta a Parigi il 24 aprile del 2010. C’è piuttosto l’invito a una nuova percezione del mondo, che condurrà a una revisione del proprio modo di concepire se stessi, la realtà e la vita (Pierre Hadot, La filosofia come maniera di vivere, Einaudi, 2008, p. 232).
L’idea di fondo che permea tutta la sua filosofia, ed emerge da uno studio profondo delle fonti antiche, ruota infatti attorno al condimento che il suo sapere “non consiste nell’insegnamento di una teoria astratta e meno ancora in un’esegesi di testi, ma in un’arte di vivere, in un atteggiamento concreto, in uno stile di vita determinato, che impegna tutta l’esistenza. L’atto filosofico non si situa solo nell’ordine della conoscenza, ma nell’ordine del «Sé» e dell’essere: è un progresso che ci fa essere più pienamente, che ci rende migliori. È una conversione che sconvolge la vita intera e che cambia l’essere di colui che la compie. Lo fa passare da uno stato di vita inautentica, oscurata dall’incoscienza, rosa dalla cura, dalle preoccupazioni, allo stato di vita autentica, dove l’uomo conosce la conoscenza di sé, la visione esatta del mondo, la pace e la libertà interiori” (Pierre Hadot, Esercizi spirituali e filosofia antica, 1981, tr. it. Einaudi, 1998, pp. 31-32). Questo tipo di condizione alla quale la filosofia lavora non si guadagna, dunque, studiando i testi di maestri, che certamente sono oggetto di un’attenta e meditazione e talvolta di un vero e proprio culto, ma sottoponendosi a una vasta gamma di pratiche filosofiche, che definirà esercizi spirituali “perché opera non solo del pensiero, ma di tutto lo psichismo dell’individuo” (ibid, p. 30).
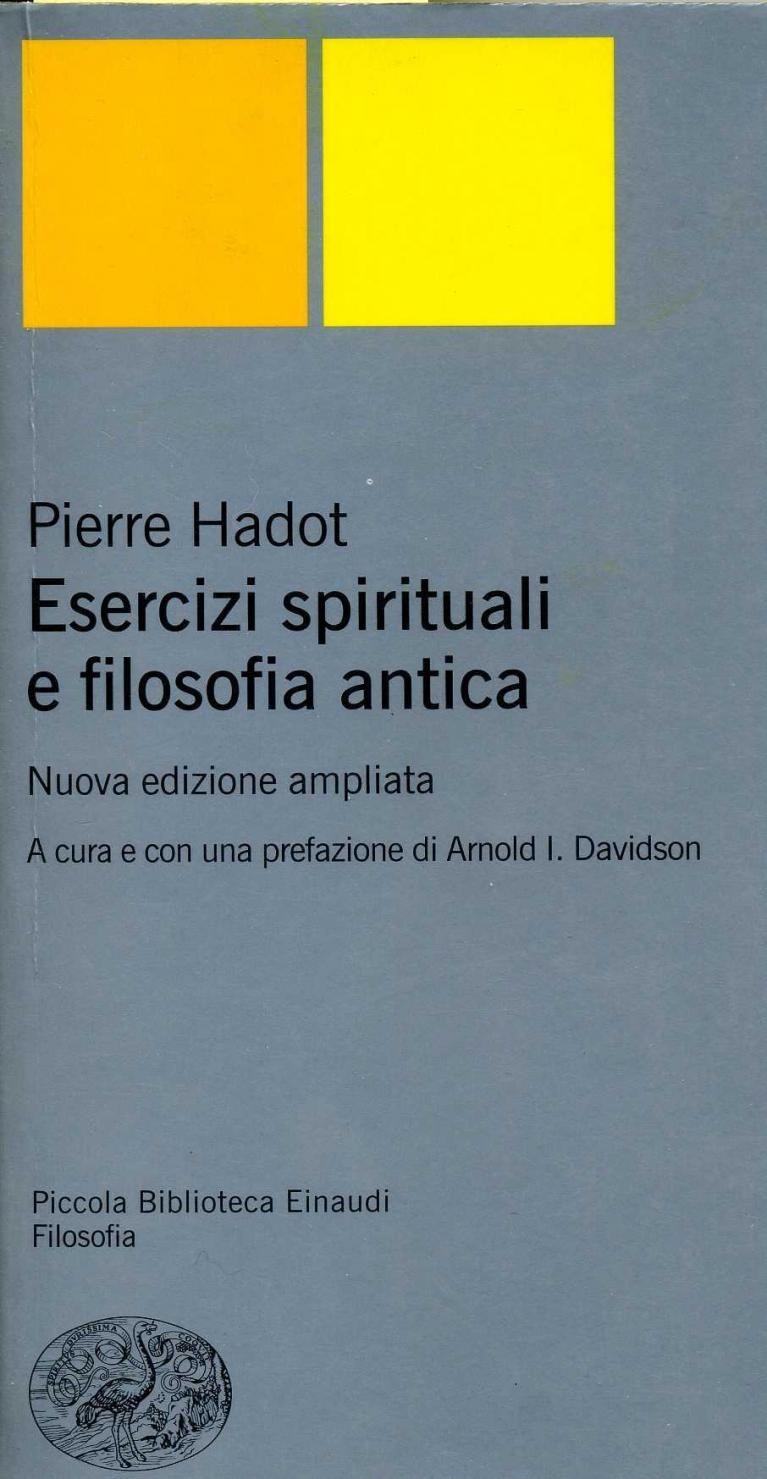
Il loro principale compito è insegnare a trascendere le abituali categorie attraverso le quali siamo soliti organizzare l’esperienza offrendo così all’individuo la possibilità di sperimentare, in forma particolarmente viva, partecipata e intensa, una diversa percezione e concezione di sé, come parte vivente del tutto che è anche un impegno etico a riorientare la propria vita alla luce di questa presa di coscienza:
“Laddove l’uomo comune ha perduto il contatto col mondo, non vede il mondo in quanto mondo, ma tratta il mondo come un mezzo per soddisfare i suoi desideri, il saggio non cessa di avere costantemente presente il tutto. Pensa e agisce in una prospettiva universale. Ha il sentimento di appartenere a un tutto che eccede i limiti dell’individualità. Nell’Antichità, questa coscienza cosmica si situava in una prospettiva diversa da quella della conoscenza scientifica dell’universo che poteva essere per esempio la ricerca dei fenomeni astronomici. La conoscenza scientifica era oggettiva e matematica, mentre la coscienza cosmica era il risultato di un esercizio spirituale che consisteva nel prendere coscienza del posto occupato dall’esistenza individuale nella grande corrente del cosmo, nella prospettiva del tutto, nella prospettiva del tutto «toti se inserens mundo» «inserendosi nella totalità del mondo» (Seneca, Lettere a Lucilio, 66, 6). Questo esercizio non si situava nello spazio assoluto della scienza esatta, ma nell’esperienza vissuta del soggetto concreto che vive e percepisce” se stesso come parte del Tutto. (P. Hadot, Esercizi spirituali e filosofia antica, p. 165)
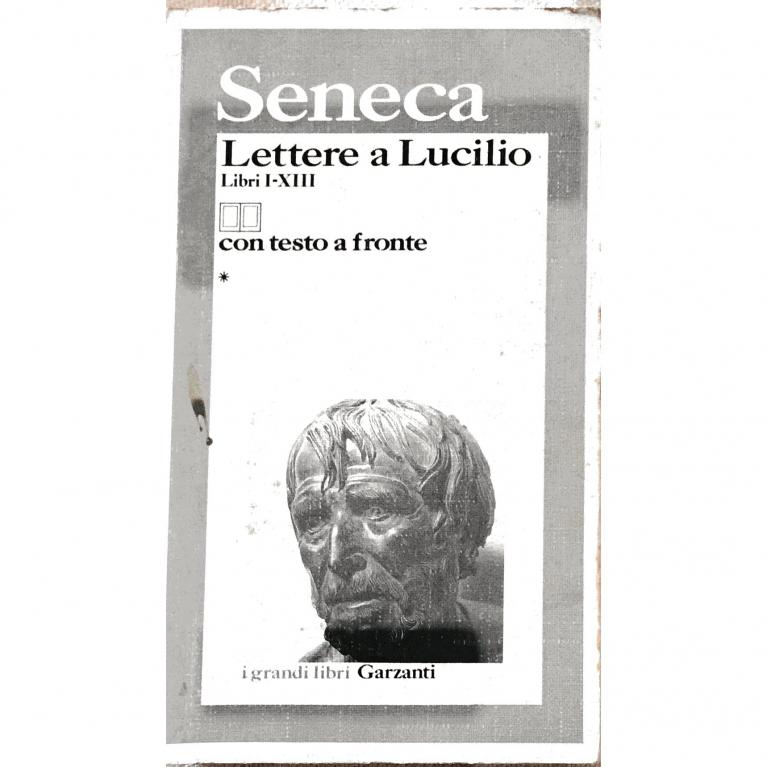
L’esercizio in questione va sotto il nome di “esercizio spirituale della fisica”, praticato in particolare dagli stoici e dagli epicurei, ma probabilmente già presente nella tradizione pitagorica (ve ne sono tracce nei Versi aurei), e viene effettuato non solo adottando uno sguardo su se stessi e sui fenomeni del mondo a partire da un punto di vista assoluto che li ingloba e li svela nella loro irriducibile interconnessione (punto di vista che accomuna, pure nelle diverse concezioni, tutte le filosofie antiche) o riflettendo sulla natura ultima di tutte le cose (la physis e l’arché che la organizza), ma sperimentando un diverso modo di percepire se stessi come espressione di tutto ciò. Ce ne offre una testimonianza biografica lo stesso Hadot:
“Era calata la notte e le stelle brillavano in un cielo immenso, fui invaso da un’angoscia insieme terrificante e soave, provocata dal sentimento della presenza al mondo, o al Tutto, e di me in questo mondo. Ero incapace di esprimere la mia esperienza, ma in seguito sentii che poteva corrispondere a domande come: chi sono?, perché sono qui? Provavo un senso di estraneità, lo stupore, la meraviglia di esserci. Nello stesso tempo percepivo di essere immerso nel mondo, di farne parte, e che il mondo si estendeva dal più piccolo filo d’erba fino alle stelle. E mi era presente, intensamente presente. Credo di essere filosofo a partire da quel momento.” (P. Hadot, La filosofia come maniera di vivere, cit. p. 9).
Hadot scoprirà poi che l’esperienza biografica che segna il suo ingresso nella filosofia va sotto il nome di “sentimento oceanico”, concetto coniato da Roman Rolland per connotare ogni autentico sentimento religioso in cui Freud, inizialmente scettico, riconoscerà la possibilità di “rovesciare i normali rapporti tra i territori della psiche, così da poter cogliere eventi profondi dell’Io e dell’Es altrimenti inaccessibili” (S. Freud Opere, vol. 11, Bollati Boringhieri, Torino, 1932, p.190) – il che è particolarmente consonante con l’idea hadotiana che questo tipo di esperienza chiami in causa l’intero psichismo dell’individuo. Uno dei principali meriti di Hadot consiste del resto nell’aver sottratto alla religione il monopolio della spiritualità rivendicandolo, in forma laica, per ogni filosofia che ricerchi un contatto con il tutto, ma anche di aver spiegato che per quanto forte ed intenso possa essere l’insight al quale si perviene quando si riesce a pervenire a questo genere di esperienze – affidate agli esercizi spirituali della filosofia antica, prima ancora che della tradizione cristiana – tocca poi all’individuo amplificarne il senso in chiave comunitaria:
“la filosofia antica è sempre una filosofia che si pratica in gruppo, che si tratti delle comunità pitagoriche, dell’amore platonico, dell’amicizia epicurea, della direzione spirituale stoica. La filosofia antica presuppone uno sforzo comune, una comunità di ricerca, di aiuto reciproco, di sostegno spirituale. Ma soprattutto i filosofi, e infine persino gli epicurei, non hanno mai rinunciato ad agire sulle città, a trasformare la società, a rendere servizio ai loro concittadini, che spesso hanno loro tributato elogi di cui testimoniano le iscrizioni. Le concezioni politiche hanno potuto essere diverse a seconda delle scuole, ma la preoccupazione di esercitare un’influenza nella città o nello Stato, sul re, sull’imperatore, è sempre rimasta costante. (…) È la stessa saggezza che si conforma alla Ragione cosmica e alla Ragione comune agli esseri umani. Questa preoccupazione di vivere al servizio della comunità degli uomini, questa preoccupazione di agire secondo giustizia, è un elemento essenziale di ogni vita filosofica. In altri termini, la vita filosofica comporta normalmente un impegno comunitario. (…) Questa è la lezione della filosofia antica: un invito per ogni uomo a trasformare se stesso. La filosofia è conversione, trasformazione della maniera di essere e del modo di vivere, ricerca della saggezza” (P. Hadot, Esercizi spirituali e filosofia antica, op. cit., p. 166).
È evidente che questa rilettura della filosofia antica, che qui posso solo accennare, modifica profondamente la concezione che ne abbiamo e mina alle sue fondamenta il pregiudizio, duro a morire, che la filosofia costituisca una forma di sapere puramente astratta, magari affascinante ma incapace di incidere concretamente sulla vita di tutti i giorni. La ricaduta esistenziale degli esercizi spirituali filosofici appare chiarissima; si pensi, solo per limitarci ad alcuni esempi, all’esame di coscienza dei pitagorici e degli stoici, svolto la sera prima di dormire per misurare e ridurre il più possibile la distanza tra il proprio stile di vita e i principi filosofici che lo ispiravano, con l’impegno a progredire nel giorno seguente; alla meditazione dello sguardo dall’alto, praticata in particolare dagli stoici per apprendere a relativizzare l’importanza dell’io rispetto al cosmo e provare a ricollocarsi, anche dal punto di vista politico, nella prospettiva del Tutto; al memento mori epicureo e stoico come esercizio per ricordarsi di vivere appieno, divenendo particolarmente presenti a se stessi e alla vita, nella consapevolezza della caducità dell’esistenza; all’esercizio di contemplazione della fisica cosmica quale paradigma esistenziale che predispone a una diversa percezione di sé nel mondo e disvela la vasta trama di relazioni che ci intessono e che ci rendono interdipendenti gli uni dagli altri, in Marco Aurelio e Seneca; allo sforzo quotidiano, comune a tutte le scuole filosofiche, di esercitarsi a condurre una vita esaminata, maggiormente consapevole e autentica, volta alla promozione della piena fioritura del proprio e dell’altrui potenziale umano, nella ricerca di un ideale di saggezza che si sa irraggiungibile ma che si considera, non di meno, irrinunciabile.
Inquadrata alla luce di queste pratiche, la filosofia palesa il suo desiderio di liberare gli individui dalle loro superstizioni, dalle loro paure e dai loro pregiudizi, per instradarli verso la possibilità di una vita più autentica perché capace non solo di interrogarsi sul proprio senso, alla luce dei concetti di verità, giustizia, collettività e cosmo, ma di creare le condizioni per un diverso modo di vivere, personale e collettivo, che incarni i valori a cui s’ispira, creando le premesse per un mondo più giusto, saggio e realizzato. La sua forza eversiva – ben nota a chi studi la vita dei suoi principali protagonisti – si attenua radicalmente nel medioevo, quando viene confinata nelle università e ridotta a mero arsenale concettuale e argomentativo al servizio della teologia, e subisce, seppur con rare ma significative eccezioni, un ulteriore ridimensionamento nella modernità, allorché si inizia a considerare filosofi pensatori, per lo più docenti universitari, che non sentono più l’esigenza di testimoniare con il proprio stile di vita la bontà delle teorie che insegnano e di cui sono riconosciuti specialisti. Questi, agli occhi di Hadot, non sono filosofi ma studiosi di filosofia, in taluni casi straordinari architetti o ingeneri del pensiero che offrono un prezioso contributo al nostro modo di pensare e intendere le cose ma che non sentono alcuna esigenza di indicare, testimoniandolo, un diverso modo di vivere. La scommessa di Hadot è che, opportunamente ripensata, la filosofia possa invece tornare ad essere intesa e praticata come una proposta di vita un po’ più consapevole, giusta, armoniosa e saggia incentrata proprio su questi esercizi che hanno lo scopo di facilitare e consolidare il cambiamento, a partire da se stessi ma pensandosi come ponte per gli altri e per un mondo a venire al quale si apre il passo. Esercitarsi ad essere all’altezza delle esperienze di verità e bellezza che si è vissuto o che si è compreso, dando vita a una maniera di vivere che resti loro consonante, è l’impegno etico al quale la filosofia di Hadot richiama, nel segno dello sforzo, comune a tutte le scuole antiche, di promuovere la piena fioritura o espressione dell’umanità, paradigmaticamente incarnata dall’ideale del saggio.
Certo il nostro tempo richiede di ripensare questo antico ideale in forme meno esemplari e superogatorie che sappiano valorizzare, rispetto all’antichità, le differenze di genere, di età e di cultura e che si arricchiscano dei contributi offerti dal sapere della contemporaneità alla comprensione dei fenomeni umani e cosmologici, come invita a fare nel corso di tutta la sua opera filosofica Romano Màdera che si concentra in particolare sulla possibilità di arricchirla alla luce del sapere della psicologia del profondo, di una pedagogia del corpo che tenga conto delle pratiche delle diverse tradizioni spirituali d’Oriente e Occidente, antiche e moderne, con l’apertura ad un orizzonte di senso mitobiografico e ai contributi più fecondi di uno sguardo sistemico sulla realtà.
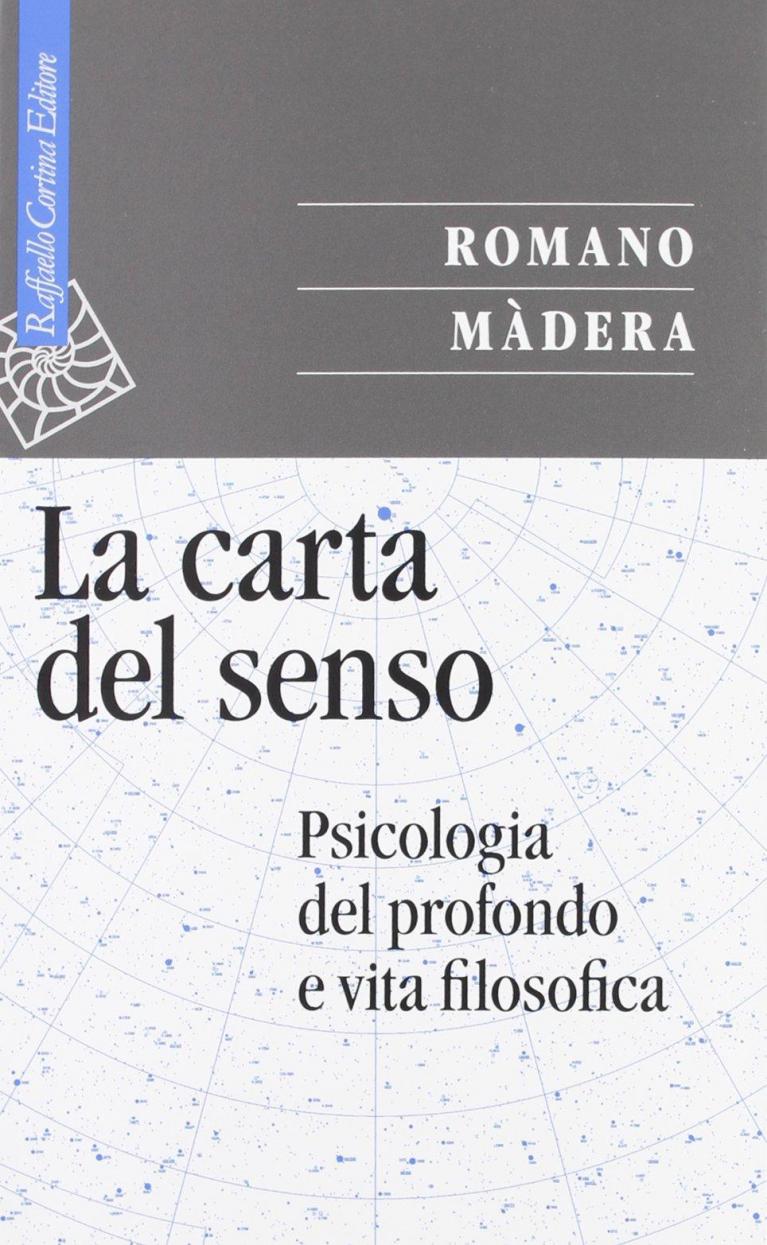
La sua prospettiva ha tra l’altro il merito di ampliare lo spettro di quello che Hadot chiama “l’intero psichismo” alla dimensione inconscia, aprendo la strada a un’ulteriore pista di trascendenza, che permette di tesaurizzarne in chiave analitica quella funzione terapeutica che la filosofia antica si riconosceva. Ad ogni modo, che si voglia ripensarla alla luce di questa proposta o meno, la possibilità di tornare a concepire la filosofia come una maniera di vivere tesa a custodire la sensazione di meraviglia per l’esistenza, a ricercare il senso delle cose e del nostro stare al mondo in una prospettiva non più egocentrica ma ecocentrica, a perseguire una vita più vera e autentica che, nell’aristotelica consapevolezza che siamo “animali sociali”, provi a realizzarsi prendendosi cura delle relazioni che la innervano, vivendole come risorse e opportunità anziché come impedimenti o limiti è ancora possibile. Essa, tuttavia, richiede una particolare forma di coraggio che è in fondo una forma di fedeltà alla vita e a se stessi:
“Tante cose sono belle a vedersi, diceva Schopenhauer, ma essere una di loro è tutt’altra cosa. La filosofia consiste nel coraggio di accettare consapevolmente il fatto di essere proprio una di loro. Alcuni esseri umani, molto semplici e comuni, come osserva Montaigne, possiedono questo coraggio ed è così che accedono alla vita filosofica. Anche quando soffrono e si trovano in una situazione disperata, riescono talvolta a considerare il fatto di esistere nel mondo come qualcosa di splendido. (…)
In definitiva, il mondo è forse splendido, spesso atroce, enigmatico. L’ammirazione può diventare stupore, stupefazione, persino terrore. Lucrezio, parlando della visione della natura rivelatagli da Epicuro, esclama: “Di fronte a questo spettacolo si coglie una sorta di piacere divino e un brivido di sgomento. Sono proprio le due componenti del nostro rapporto al mondo, insieme piacere divino e sgomento (…). Questo brivido sacro non si produce volontariamente, ma nelle rare occasioni in cui ci coglie, non dobbiamo cercare di sottrarci, perché si deve avere il coraggio di affrontare l’indicibile mistero dell’esistenza”.
Questo articolo riprende in parte e sviluppa “Gli esercizi spirituali” di Pierre Hadot pubblicato su “la Repubblica” il 23aprile 2020.









