Infanzia di Nathalie Sarraute / La battaglia delle parole
Accade spesso che qualcuno mi chieda perché scrivo libri per ragazzi. Difficile trovare una risposta per qualcosa che non è precisamente frutto di una decisione. Fra l’altro, non mi sono mai pensata come “scrittrice” e continuo a non pensarmi come tale. Sulla carta d’identità, alla voce professione ho riportato editore. Non mi è mai capitato di utilizzare per me stessa la definizione di “scrittrice”. E non per scelta: semplicemente quando accade di dovermi definire, non ci penso. Il problema, con le parole, è questo: la medesima parola appartiene a domini diversi e in questi domini fissa permessi e divieti specifici. Nel mio dominio, il termine scrittrice non è riferibile a me.
È interessante, e non facile, cercare di venire a capo del momento in cui e delle modalità con cui il proprio personale dominio delle parole ha cominciato a formarsi. Il racconto della nostra infanzia, della nostra storia, delle nostre origini nasce in un tempo e in uno spazio precedenti a noi. E noi ci ritroviamo in esso ben prima di saper parlare. Quando cominciamo ad articolare qualche sillaba, l’inizio della storia è già stato raccontato.
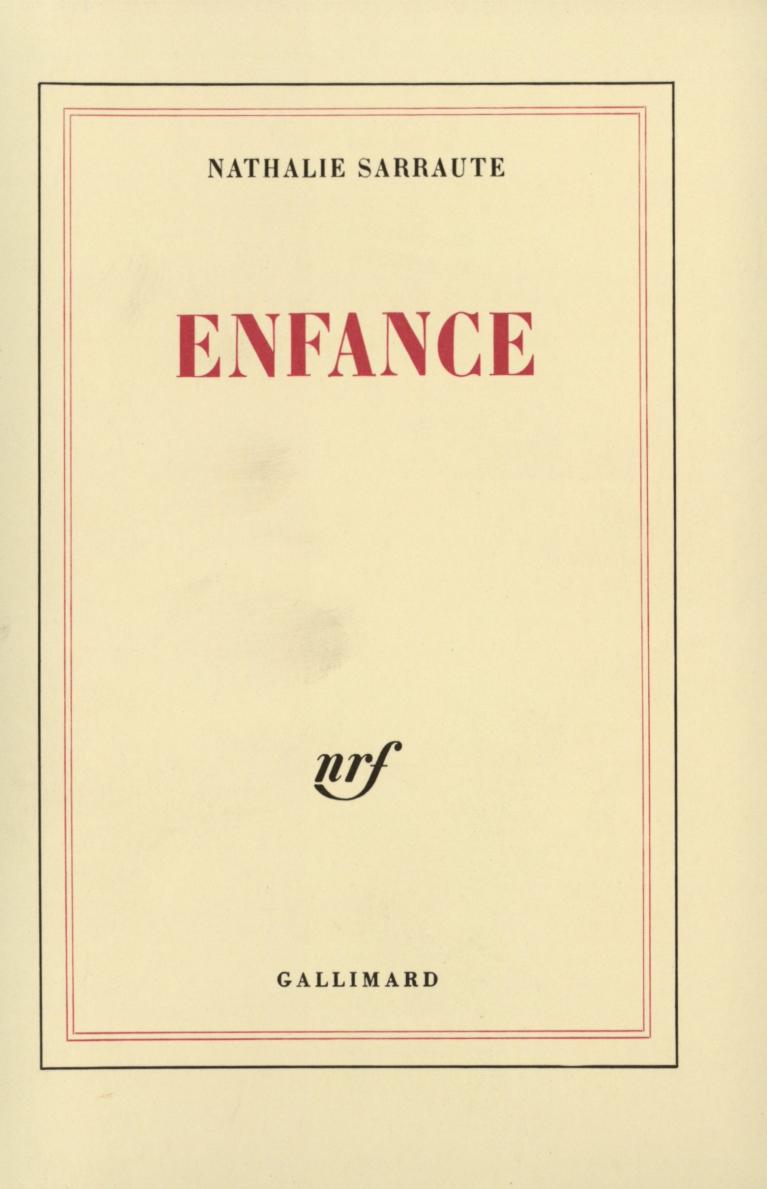
Ricordo che il professor Vittorio Spinazzola, all’università, ci ripeteva che nella prima pagina di un romanzo si può leggere tutto quello che verrà poi: in quella sequenza di parole, come in una matrice, è contenuto tutto lo sviluppo della storia. Un romanzo non è molto diverso da una identità: entrambi si costruiscono attraverso una narrazione. Diverso è il grado di complessità: il flusso verbale che accompagna lo sviluppo dell’identità è scoordinato, caotico, polifonico, contraddittorio. Nel romanzo, al contrario, presiede all’affabulazione una sola volontà, quella dell’autore.
Le parole, i racconti che accompagnano la nostra venuta al mondo hanno il potere di determinare il corso della nostra vita, almeno fino a quando la nostra lingua, in uno sforzo titanico di autodeterminazione, non comincia a conformare questa narrazione a regole sue proprie.
Infanzia di Nathalie Sarraute costituisce in questo senso un romanzo esemplare: qui il racconto dell’infanzia coincide con quello delle parole che l’hanno accompagnata. O, meglio, la possibilità stessa di creare un racconto relativamente alla biografia infantile consiste per l’autrice nel recuperare la memoria delle parole altrui attraverso cui l’infanzia si è costruita. Parole di adulti, che hanno canonizzato per sempre atti, istanti, incontri, scoperte, conflitti, determinandone il senso ultimo, stigmatizzandone la sostanza vitale, a volte oscurandone la molteplice verità, illuminandone il fondo tenebroso e annientandone la tridimensionalità fino a ridurre ogni complessità a uno scenario piatto su cui si agitano grottesche maschere di tragedia.
Dunque, il progressivo definirsi dell’identità, che costituisce il nocciolo della storia di ogni infanzia, coincide per la Sarraute con lo svelamento, la presa di coscienza dell’inganno di cui è portatrice la lingua adulta, le parole messe in opera dal nucleo familiare per edificare il castello dell’identità e “la storia ufficiale” che ne racconta le tappe. In questa singolare – perché invisibile e, paradossalmente, amorosa – prigione della lingua, l’infante sta in ascolto e apprende. Le voci che parlano di lui, intorno a lui, presto prendono a discorrere anche dentro di lui quando tutto intorno è silenzio.
Ogni sua acquisizione, esperienza, sentimento, verità dovranno passare attraverso quella silenziosa corte di giustizia che abita la sua mente e in cui, incessantemente, si combatte l’ardua battaglia dei significati. Una battaglia sanguinosa, dato che al contrario di quanto si pensa, le parole sono questione di vita o di morte. E senza il combattimento di questa battaglia non si dà possibilità di discorso autobiografico, non si dà possibilità di linguaggio.
Il romanzo della Sarraute prende le mosse dal serrato dialogo fra due voci. Abitano il medesimo corpo: l’una è freddamente analitica, in costante polemica, crudelmente lucida su ogni debolezza, emozione, sbandamento; l’altra, è esitante, dubbiosa, paziente, nuda, scoperta, integra. È questa seconda voce che si accolla l’ingrato compito di ascendere il calvario della memoria infantile, ripercorrendone le dolorose stazioni, e a ogni stazione, le frasi dei principali attori così come furono pronunciate. È a questa voce che si deve la discesa agli inferi della verità, lo svelamento della storia “non ufficiale”, l’abbandono della lingua materna. La prima voce, con impassibile cadenza di giudice, è lì unicamente a sorvegliare che nessuna imprecisione, distrazione, reticenza, invalidi agli occhi della legge gli atti che trascrivono i termini di tale ricerca. Ricerca che, infatti, ha un prezzo: la costruzione di una storia propria, di una lingua propria è, per colmo di ironia, il frutto di una negazione, si può costituire nello spazio angusto di un rifiuto, di un divieto che permarrà, peraltro, intatto e insanabile. La Sarraute riporta con precisione la frase che le precluse per sempre il possesso di una casa e, nel contempo, la sua appartenenza ad essa.
La battaglia delle parole fra gli adulti e il bambino è, ovviamente, impari. I “grandi” padroneggiano con maestria le parole, ne sono avvolti, protetti come da una invisibile, ma insuperabile corazza. Infatti è con l’indifferenza, la leggerezza e la sicurezza di divinità che lasciano cadere le frasi più terribili: “Non si fa” “Che disgrazia, non avere la madre” “Questa non è la tua casa” “Ti hanno abbandonato”.

“Era la prima volta che venivi così presa dentro una parola?” interroga la prima voce, alludendo a una di queste affermazioni. “Non ricordo sia mai successo prima” è la risposta. “Ma quante volte più tardi sono evasa con terrore dalle parole che ti piombano addosso e ti imprigionano.”
Intorno a ognuna di queste frasi, le due voci intessono un dialogo ininterrotto: indagano i momenti in cui sono state dette, il carattere e il ruolo di chi le ha pronunciate, le ragioni, addirittura le buone intenzioni che hanno spinto a formularle. Ma il dominio della parola adulta è ambiguo, destinato a far franare le ipotesi del più acuto investigatore. Una volta pronunciate, queste frasi sono state immediatamente dimenticate. Permangono unicamente nella memoria del bambino, tracciate a lettere di fuoco, a sancire punizioni, condanne, destini. È nell’aula silenziosa della sua mente che assumono il loro significato: quello negato, taciuto, non detto, ma più autentico. Sono frasi straordinariamente simili a quelle che si incontrano nelle fiabe: le maledizioni, i verdetti, le ingiunzioni di padri e matrigne dal cuore di pietra, serve maneggione, fate vendicative, sorellastre perfide e fratelli malvagi.
Nel dominio infantile la parola è magica. Nella memoria dell’infante, il momento dell’uscita dal silenzio è ancora vicino: la meravigliosa metamorfosi che permette al pensiero di convertirsi in sostanza sonora e quindi in realtà. La chiave che consente l’accesso al mondo. A tal punto è potente l’impatto della parola sulla psiche infantile, che il bambino pensa siano le parole, vere e proprie formule magiche, a realizzare le aspettative e soddisfare i desideri. Dunque, alle parole il bambino presta un interesse appassionato, un’attenzione totale: sa che la sua vita dipende da esse. La conquista di ogni parola nuova coincide con la conquista di un brano di realtà. Le parole e le cose sono vicine, si toccano. Entrambe hanno statuto di verità.
Dunque il bambino ascolta gli adulti parlare, affascinato. Crede a tutto quello che dicono. Ha più fiducia in quello che sente che in quello che vede. La parola è il Verbo.
Nel volume di memorie Ai miei figli, Pavel Florenskij scrive a proposito dei tabù verbali della propria infanzia: “I bambini hanno un istinto infallibile, un fiuto da segugio per distinguere ciò che è decoroso da ciò che non lo è. Quella tra il conveniente e lo sconveniente è una demarcazione assoluta, e fare qualcosa di sconveniente è peggio che morire. Ancora peggio, poi, che fare, è dire qualcosa di sconveniente. Una brutta cosa, un brutto discorso, un gesto sconveniente, una parola sconveniente: è questa la scala dell’inammissibile. Non c’è nulla di peggio, di più vergognoso, di più annichilente e irreversibile di una parola sconveniente, se non pensarla. Nemmeno nel buio della notte, con la testa nascosta sotto le coltri, puoi osar pensare qualcosa di simile, altrimenti verrai schiacciato sotto qualche imperativo assoluto violato, brucerai e morirai di vergogna; anche solo l’idea che, sbadatamente, si potesse pensare una tale parola ti faceva tremare, e per un attimo il cuore smetteva di battere.”
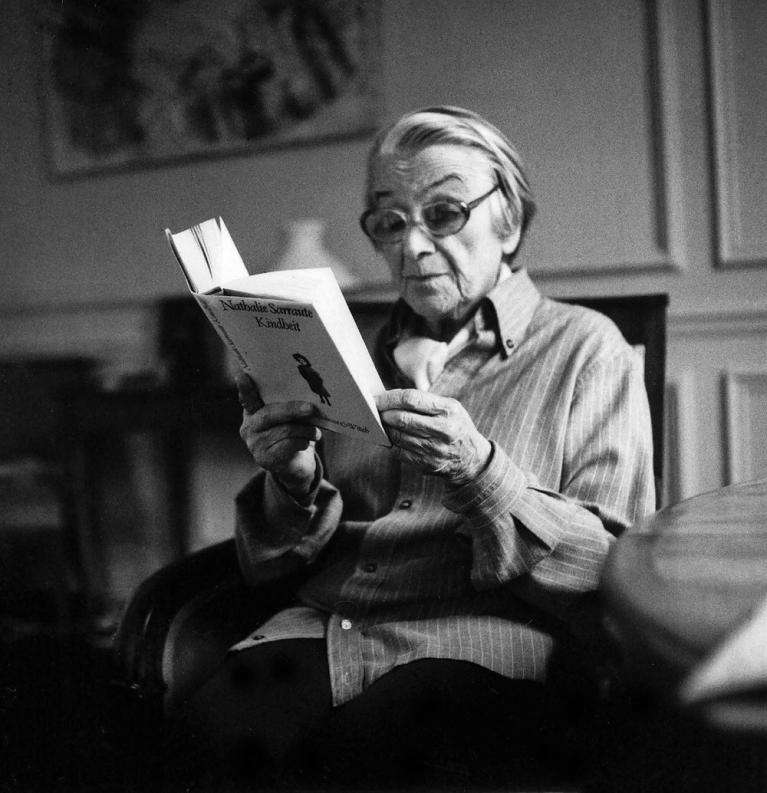
Sì, la battaglia dei significati fra adulti e bambini è impari. Ma il germe della lingua individuale è nelle parole che sorgono nel buio della notte. È lì, nella solitudine del pensiero, che si rivela la loro natura trasgressiva. Nella mente vanno a comporre frasi inattese, stupefacenti, inammissibili, che sfuggono a ogni controllo e creano nuove configurazioni di significato. Il momento in cui ciò accade è traumatico: nel libro della Sarraute è indicato con precisione.
“Mamma non è così bella. Adesso che questa idea è insediata in me, sloggiarla non dipende più dalla mia volontà. Posso obbligarmi a relegarla in secondo piano, a rimpiazzarla con un’altra idea, ma solo temporaneamente… è sempre lì, rannicchiata in un angolino, pronta a farsi avanti in qualsiasi momento, a spazzar via tutto davanti a sé, a occupare l’intero spazio. Si direbbe che respingerla, comprimerla troppo aumenti ancora la sua forza di propulsione. È la prova, il segno di quel che sono: un bambino che non ama la madre.”
Le parole, qui, sono ancora percepite come magiche, estranee: non cercate, non volute, capricciose, diaboliche, si sono insinuate da fuori nel pensiero: “Il male era in me. Il male mi aveva scelta perché trovava in me l’alimento di cui necessitava. Non avrebbe mai potuto sopravvivere in uno spirito sano e puro di bambino come quello che possedevano gli altri bambini.”
Sarà l’apprendimento della scrittura, più tardi, a liberare Nathalie dal tormento della colpa per quella fioritura di parole segrete, di idee personali. Sarà la scrittura a spingerla verso il dominio dell’autonomia: “comando la mia mano e lei mi ubbidisce sempre meglio”. Con la scrittura, la parola diviene gesto, atto: smette di accompagnarsi al ritmo del respiro, di essere una emissione spontanea, casuale, incontrollata. Per assumere corpo, essere vista, letta, la parola deve piegarsi all’esercizio e alla volontà della mano. La parola sarà un possesso, una cosa di chi la scrive.
A questo punto, la lingua subisce una frattura decisiva. Il dominio degli adulti sarà l’oralità. Quello di Nathalie, la scrittura. In esso la bambina parla la lingua dei libri, della letteratura, della matematica, quella del teatro e delle poesie recitate ad alta voce: una lingua limpida, nitida, segnata dalla bellezza, latrice di un ordine necessario e soprattutto giusta, veritiera. Con questa lingua le verrà chiesto di dar forma al suo pensiero: comporrà temi che lasceranno gli adulti senza parole. A questa lingua, la bambina associa il dispiegarsi della vita vera, diversa da quella configurata dalla lingua degli adulti, imprevedibile, ingannevole, crudele, casuale, transitoria.
Nel dominio di Nathalie, le parole somigliano a quelle magiche vissute nella prima infanzia. Parole che generano incantamento, precise e affilate come rasoi, così dense di significati, da esplodere altissime come fuochi d’artificio.
Quelle parole questione di vita o di morte cui gli infanti prestano un’attenzione spasmodica, un interesse appassionato e delle quali la Sarraute in un passo dice: “ … non ne ho perduto la minima briciola: quale bambino la perderebbe?”
Accade spesso che qualcuno mi chieda cosa renda un testo adatto alla lettura di un bambino. A questa domanda penso di sapere rispondere: un uso di ogni singola parola rigoroso, non casuale, appassionatamente attento, profondamente veritiero, onesto, limpido, vivo. Una disciplina delle parole, “non solo inerente alla scrittura, ma a tutta la vita intellettuale”, come scrisse Flannery O’Connor, in un libro di saggi sulla scrittura. “Una mente sgombra da falsa emozione, falso sentimento ed egocentrismo.”
Articolo uscito sul numero 16 della rivista «Hamelin. Storie, figure, pedagogia», anno 2006.









