Johan Chapoutot / Come il nazismo ha creato il moderno manager
Nazismo e management di Johan Chapoutot è un libro spinoso, urticante, ma indispensabile per capire le lunghe radici del tempo presente. Non capita spesso nella saggistica storica. Un precedente illustre è Modernità e Olocausto di Zygmunt Bauman, libro che ha stentato molto a divenire un luogo culturale. Non perché quel libro sia non compiuto, ma perché mettere in questione il senso comune è sempre un’impresa complicata e destinata all’insuccesso.
Mi spiego meglio.
Quando nel 1989 Zygmunt Bauman pubblica Modernità e Olocausto, il libro si salva perché Bauman ha ormai raggiunto una certa rispettabilità, ma non contribuisce a rovesciare significativamente il senso comune. Per questo, a differenza di altri suoi testi diventati “manifesto del nostro tempo” veri e propri hashtag, quel titolo non riesce a compiere quel salto.
Dove stava lo scandalo o l’imbarazzo suscitato da quel libro? Stava nel descrivere un tema e nel non dare un nome, ma obbligare il suo lettore a rivedere complessivamente il modo in cui era stato archiviato un passato. Dire che l’olocausto non era finito nel 1945, ma che ciò che lo aveva reso possibile non solo era sopravvissuto a quell’evento, ma costituiva un tratto essenziale della modernità e delle sue inquietudini, dopo il 1945, a meno di non sorvegliare, costituiva il centro della questione.
Significativamente non trovava un nome, ma indicava un problema; rovesciava radicalmente un senso comune, ma non individuava una terapia per uscirne. Chiedeva che si prendesse in carico un problema non risolto. Forse, anche se in forma non dispiegata, affermava che quel problema era ancora nel nostro tempo presente.
Il profilo, dunque, non era partire da quel passato per capire i residui agenti nel presente, ma scavare nel presente, cogliere le lunghe radici di quel presente nel passato, scavare in quel passato e poi tornare a mettere sul tavolo i risultati di quell’indagine nel nostro presente. Allora, a parte alcune voci, quella provocazione rimase senza eco.
Chapoutot nel suo Nazismo e management, più o meno trent’anni dopo Modernità e Olocausto, riapre quel capitolo.
Come lo fa?
Individuando un protagonista dello stesso tipo di passaggio, ricostruendo e invitando a riflettere sulla polivalenza del linguaggio che utilizza e riconducendo quella polivalenza a una asetticità di funzioni, ovvero “lavorando sulla forza deideogizzante” di quel linguaggio, culturalmente e politicamente connotato, ma che si accredita come «neutro». In questo caso trasformando l’ideologia in una tecnica e dando alle componenti dell’ideologia, ora trasformata in tecnica, un connotato di universalità.
“Decisamente estranei e stranamente vicini, quasi nostri contemporanei: così ci sembrano i criminali nazisti, di cui un ricercatore in storia, specialista di quel periodo, osserva la vita e le azioni, legge gli scritti, ricostruisce l’universo mentale e il percorso”.
Così esordisce Chapoutot. Dopodiché in poco meno di 100 pagine – caso estremamente raro per un saggio storico – mette a fuoco il nucleo strutturale di un tema che questo piccolo libro ha il merito di illuminare e che apre un fronte di indagine sui paradigmi culturali del nostro tempo ora.
Per farlo, Chapoutot affronta rapidamente prima una figura tecnica legata all’organizzazione economica, Herbert Backe, per poi indagare l’universo culturale del protagonista Reinhardt Höhn.
Il tema è il vocabolario che entrambi usano. Un vocabolario che ci è «familiare», e con cui, quindi, si tratta di fare i conti (appunto come ciò a cui alludeva Bauman con Moderntà e Olocausto).
Herbert Backe, dal 1936 è l’esperto di agricoltura dell’amministrazione del Piano quadriennale diretto da Hermann Göring. In quella veste nella primavera redige un vademecum sul comportamento da assumere nel territorio russo oggetto della prossima azione militare dell’esercito.
In quel testo, osserva Chapoutot ci sono parole immediatamente ascrivibili al vocabolario nazista, ma ci sono anche termini che sono sopravvissuti a quel tempo e «sono scivolati» in quelli del nostro tempo. Scrive Chapoutot:
Herbert Backe esige «efficienza» dai suoi agenti: «L’importante è agire», «prendere le decisioni rapidamente», «senza perdersi in scrupoli burocratici» («keine Aktenwirtschaft»). «Non parlate, agite», senza «protestare o lagnarvi nei confronti degli organi direttivi» («nach oben»). Gli organi direttivi stabiliscono un «obiettivo» (Endziel) che gli agenti devono raggiungere senza perdite di tempo, senza richieste di strumenti supplementari, senza affliggersi o abbattersi di fronte alla difficoltà del compito. Quel che conta è che la missione sia compiuta, poco importa il modo. Backe raccomanda la «massima elasticità nei metodi» adottati. Questi «metodi sono lasciati alla valutazione di ciascuno». In termini militari questa concezione del lavoro ha un nome, coniato nel XIX secolo: Auftragstaktik, tattica di missione, basata sull’obiettivo. All’ufficiale viene assegnata una missione: spetta a lui portarla a termine nei modi che preferisce e che ha a disposizione, purché l’obiettivo sia raggiunto”.
La parola su cui lavora Chapoutot è appunto tattica di missione che aggiorna per noi in una parola che anche noi usiamo, o che fa parte del vocabolario culturale e mentale di questo nostro tempo: «elasticità». Dopo di che scrive: “si sarebbe potuto dire anche «flessibilità», «iniziativa», o «agilità», «efficienza», «obiettivo», «missione»: eccoci su un terreno conosciuto”.
Già un terreno conosciuto.
Come si forma, quale profilo culturale, ma soprattutto antropologico-politico contiene (più che nascondere) questa parola? Perché il tema, come insiste giustamente Chapoutot, non sta nel vocabolario, ma nella visione-mondo a cui quel vocabolario rimanda. Il problema non è se le parole sono malate, ma rispetto a quale costrutto progettuale (ovvero a quale fine) esse rispondono o sono funzionali.
Il punto di partenza, perciò, non è l’ideologia in sé, ma come questa si struttura.
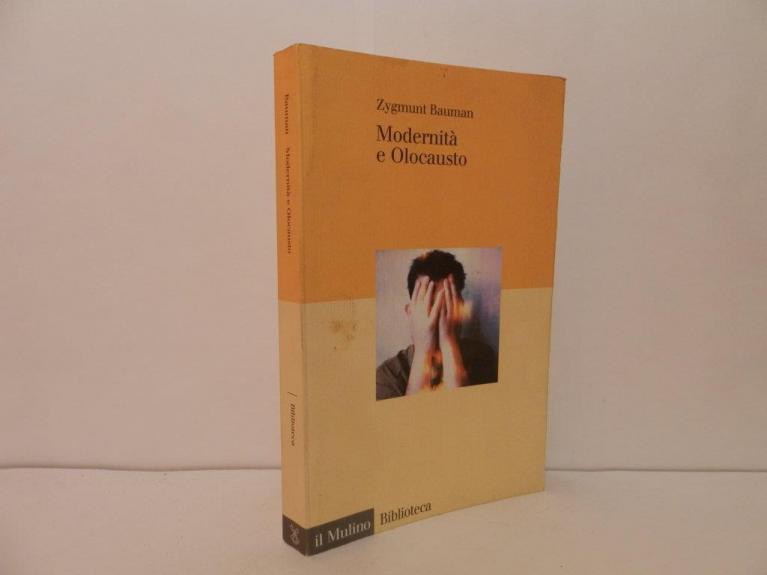
Il tema è la responsabilizzazione dal basso, nella azione del funzionario che agisce, prima ancora che obbedire, e che agisce perché investito della responsabilità che un progetto sia realizzato. Come scrive nel 1943 Walter Labs, giovane giurista che segue le pratiche di sterminio messe in atto dalle SS in Urss, “il centro di gravità dell’amministrazione sia collocato ai livelli inferiori, grazie al grande margine di libertà che viene concesso alle scelte e alle iniziative dell’individuo”. Perché la logica è portare a termine la missione, eseguire il compito” Un profilo che contemporaneamente esprime la realizzazione di un progetto e la responsabilità di conseguirlo, ma la deresponsabilizzazione sugli «effetti collaterali», un aspetto questo che Bauman in Modernità e Olocausto ha sottolineato nelle pratiche di possesso del corpo degli altri dell’esperimento Milgram (appunto uno dei dati che rimangono in eredità nel comportamento dopo il 1945).
Il secondo concetto su cui lavora Chapoutot è il rapporto tra “partito” e “movimento” e contemporaneamente tra “Stato” e “gruppo”, laddove, sorprendentemente ma convincentemente invita a riflettere sulla natura antistatale del nazismo. “Con nostro sommo stupore – scrive Chapoutot – i nazisti si rivelano degli anti-statalisti convinti”.
La fonte testuale in cui Chapoutot individua il nocciolo di questo passaggio è nella posizione anti Carl Schmitt proposta da Reinhardt Höhn (1904-2000) il vero protagonista di questo suo libro. Reinhardt Höhn è un giurista di diritto pubblico, a lungo militante dell’Ordine del Giovane Tedesco (Jungdeutscher Orden), un’organizzazione antisemita e anticomunista vicina al partito nazista, partito a cui aderisce nel maggio 1933, per poi entrare nelle SS nel 1934, e quindi nella SD, nominato colonnello e infine generale delle SS nel 1944.
Personaggio altamente interessante, Reinhardt Höhn, sia nelle sue funzioni di teorico del diritto nella Germania nazista, sia, e soprattutto, come direttore della scuola di formazione per dirigenti “Bad Harzburg”, in Alta Sassonia che fonda nel 1954 e che costruisce la classe dirigente industriale, ma anche del nuovo esercito della RFT tra anni ’50 e anni ’80.
Questo rende il caso di Reinhardt Höhn altamente significativo. Non solo a proposito della continuità dello Stato tra fascismi e democrazie politiche post-1945 – un aspetto su cui ha insistito Claudio Pavone nel caso italiano, ma che non ha risparmiato tutti i sistemi politici di transizione, appunto la Germania, ma anche la Francia: che cos’è Maurice Papon se non, appunto, un caso di continuità dello Stato? – ma anche sui principi culturali con cui si pensa la costruzione della politica e della partecipazione. Quel modello di partecipazione ha come presupposto non solo l’appartenenza a un gruppo ma la capacità di essere partecipi attivi della comunità di cui si è geneticamente parte.
La parola “attivi” è polisemica, precisa Chapoutot. Riguarda l’appartenenza, ma anche la capacità di generare azione: “non basta avere il sangue giusto e il giusto colore della pelle, occorre anche essere pienamente utilizzabili come produttori e riproduttori”. Per questo essere ariani è condizione necessaria, ma non sufficiente. Si tratta, anche, di non essere “malati ereditari” (400.000 sterilizzazioni forzate tra il 1933 e il 1945) oppure non essere disabili (200.000 i morti fino al 1945 nel quadro dell’operazione T4).
La parola “attivi” chiede una partecipazione alla costruzione della società, e quella partecipazione è possibile solo motivando “dal basso”. Per questo una parola chiave, accanto a partecipazione e a forza è “gioia”. Lemma fondamentale in tutti gli esperimenti totalitari (l’Unione sovietica dei piani quinquennali costruirà la figura di Stakhanov e definirà il mito coniugando gioia del lavoro e realizzazione “dal basso” del progetto economico ricorrendo sostanzialmente allo stesso paradigma) e che Reinhardt Höhn definisce appunto come “entusiasmo dal basso” non solo in riferimento agli obiettivi da raggiungere, ma all’entusiasmo e alla partecipazione richiesti per conseguirli, ovvero la «tattica di missione».
È questo modello che si ripresenta nel profilo formativo del metodo “Bad Harzburg” che Chapoutot descrive dettagliatamente nel settimo capitolo di Nazismo e management. Ovvero: obbedire per realizzare obiettivi stabiliti dall’alto e di cui ci si assume la responsabilità dell’esecuzione nel conseguimento dell’obiettivo.
Reinhardt Höhn lo teorizza nel testo che illustra il profilo didattico con cui agisce la scuola di formazione per dirigenti e che pubblica nel 1970 con il titolo Verwaltung heute : Autoritäre Führung oder modernes Management, laddove scrive:
I superiori non prendono nessuna decisione che rientri nella sfera di attività dei loro collaboratori. Si limitano ai propri compiti di management, consistenti essenzialmente nel fissare obiettivi, dare informazioni, coordinare e controllare […] La gerarchia, che si basava sul dare ordini, diventa ora una gerarchia di responsabilità […] La delega di responsabilità non comporta quindi una dissoluzione della gerarchia, ma un cambiamento della sua funzione e del suo significato [il corsivo è mio].
Uno spirito di coinvolgimento nell’impresa (ma anche in tutte le strutture gerarchizzate collettive, tra cui l’esercito) che a lungo caratterizza il modello d’impresa nel secondo dopoguerra, modello che viaggia esclusivamente in direzione della struttura gerarchica, dall’alto verso il basso, senza la presenza della componente di feedback.
Percorso che inizia a essere rimesso in discussione nella seconda metà degli anni ’70 dove la comunicazione, diretta in duplice direzione (top‐down e bottom‐up), assume una nuova funzione: quella di motivare gli individui consentendo il raggiungimento degli obiettivi aziendali e la cui ultima evoluzione nei sistemi organizzativi, e quindi anche nel ruolo della comunicazione, si ha con la diffusione della tecnica giapponese del Total Quality Management. Ovvero il modello Toyota, laddove la forza di quel modello non è nel rendere responsabili dell’esecuzione i livelli bassi della produzione, ma nel coinvolgere l’esperienza anche dei livelli bassi nella definizione delle strategie per proporre identificazione e, dunque, dare motivazione alla partecipazione del progetto di impresa.
Il che propone esplicitamente la messa in discussione di quel modello di comando. Non un’inversione, ma una sua ristrutturazione strutturale e, forse, anche l’uscita definitiva da un modello gerarchico rigido. Perché la fine o l’abbandono di quel modello, presume la consapevolezza e la presa d’atto della sua «non neutralità», presupposto e conseguenza del confronto consapevole con la sua matrice.
È il profilo che fa di Nazismo e management di Chapoutot, come di Modernità e Olocausto di Bauman, un saggio di storiografia civile e non solo un saggio di storia: sarà possibile questa volta aprire un laboratorio di discussione che non faccia solo finta?









