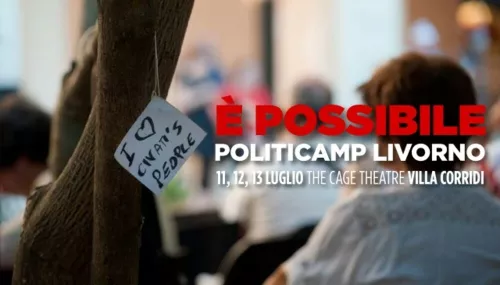PolitiCamp. Manca
Questo testo è stato letto da Stefano Bartezzaghi a Livorno, la mattina del 13 luglio 2014, nel corso del PolitiCamp "È possibile" convocato da Giuseppe Civati.
Introduzione
Vi dico il titolo del mio intervento, che è il mio primo, e plausibilmente ultimo, intervento in una manifestazione politica: «Manca». Non nel senso che il titolo non c'è, ma nel senso che il titolo è proprio quello: «Manca». Quando diciamo «a destra e a manca», manca significa «sinistra», da cui l'aggettivo «mancino». Deriva dal latino «mancus», una strana parola formata dalla radice di «manus», mano, e dal suffisso «-cus» che in latino denotava difetti fisici. La sinistra è la mano che, «normalmente», è la più debole.
Fuori dalla politica essere destri è una buona cosa, essere sinistri no; come aggettivo «sinistro» è un sinonimo di torvo, bieco, pauroso; come sostantivo è sinonimo di incidente, disgrazia. Sono doppi sensi, di quelli che servono solo in enigmistica. C'è un altro doppio senso, ancora più casuale, e abbina la mano «manca» all'omonima voce del verbo «mancare», un verbo molto comune ma anche un termine tecnico della psicoanalisi dove la mancanza è contemporaneamente assenza e desiderio, «the black want» di una poesia di Samuel Beckett intitolata «Cascando».
«Manca» è la parola che mi è immediatamente risuonata in testa quando ho ricevuto l'invito di venire qui a dire quel che penso del linguaggio della sinistra. La sinistra manca a sé stessa e al Paese perché manca di parola. Può apparire paradossale, è leggendaria la nostra capacità di effusione verbale: i documenti interminabili, le discussioni, le mozioni senza emozione, quindi mozioni non d'affetto. Quando poi il tempo stringe e si dice: «giungiamo a una sintesi», la sintesi è magari un documento di venti pagine. Questo accade da sempre, è un tratto importante del nostro genoma.
La bad company
Quello che invece è accaduto soltanto nello scorso ventennio è stata una distrazione generale: chi è stato distratto dall'infinito entertainment incominciato alla fine degli anni Settanta; chi invece si è incantato davanti al mondo che cambiava e ha pensato che si potesse andare avanti con le modalità di prima, fatte appunto di parole, convinzione di essere migliori, cinghie di trasmissione e così via. Nella semiosfera in cui si sono saldate le due distrazioni è successo che il senso comune, specialmente quello dei cittadini più giovani, non è stato più di sinistra, come lo era stato prima, quasi naturalmente e spontaneamente.
Sul piano linguistico e della comunicazione, che è quello che mi compete di più, è sorto ed è divenuto dominante, per esempio, un senso comune impaziente nei confronti del «linguaggio politicamente corretto». Mentre già i talkshow si riempivano di insulti sessisti e spensierati, «vaffanculo» e «non hai le palle», è passata l'idea che vigesse, piuttosto, l'egemonia del politicamente corretto. Il vocabolario davvero dominante era invece quello della destra, accettato e anzi assunto senza capacità critica dalla maggioranza dei massmedia.
Da «fannulloni» a «froci», passando però anche per termini compassionevoli come «poveri» o apparentemente neutri come «gente» e «popolo». È questa una lingua che non si dà preoccupazioni di precisione e tassonomia, ma divide la società secondo grossolane linee di forza e fronti di scontro fra un «noi» sempre mutevole (noi gente di buon senso, noi contribuenti tartassati, noi maschi, noi mariti, noi che lavoriamo) e un «loro» sempre generico. «Quegli altri»: la sinistra diventata la bad company dell'Italia. Il gioco ha funzionato benissimo.

Trasparenza e doppiezze
Per interromperlo si è pensato che occorresse opporre due pratiche virtuose: «parlare chiaro» e «trasparenza». Un tic verbale molto diffuso, specialmente a sinistra, è costituito da certe formule preliminari o incidentali: voglio essere molto chiaro, lo dico con sincerità, facciamo chiarezza. La politica non è filosofia, non può assumerne nel suo discorso tutte le articolazioni ma deve arrivare a una sintesi vera e assertiva, al punto in cui il sì è un sì e il no è un no, e il resto è del demonio. Ma dire «parlo chiaro» non è una pratica di chiarezza, di per sé. La chiarezza è poi sempre la semplificazione di quell'articolazione di discorso, quindi ha al fondo almeno un sospetto di insincerità. La trasparenza, a questo proposito, rischia di rendere evidente la presenza di un doppio fondo, di un «ma anche» di quei giochi di tacco-e-punta a cui fanno presto ad attaccarsi gli autori di satira.
Una tipica pratica di trasparenza: lo streaming. Io parlo a voi, che avete un certo grado di competenza e appartenenza a un partito o a un area o anche meglio a un campo – chiamiamolo così – ma nello stesso tempo lo streaming mi fa parlare anche ad altri: possono essere cittadini, elettori di sinistra o di destra, giornalisti, osservatori, più o meno benevoli, appunto autori di satira.
Le pratiche di trasparenza ci obbligano a riflettere sul fenomeno della doppia platea, che è poi il double coding su cui la massmediologia ha incominciato a lavorare negli anni Settanta. Teniamo d'occhio questa parola: doppio, double. È la classica accusa che si faceva al Pci dai tempi di Togliatti e al movimento comunista internazionale almeno dai tempi di Orwell. Una frase famosa di Pierluigi Bersani, dell'anno scorso: «Siamo arrivati primi ma non abbiamo vinto».
È fattualmente vera, ma ha lo stesso significato se ascoltata da un funzionario del Pd o da un cittadino, elettore democratico o no che sia? Un'altra frase, molto più recente, di Gianni Cuperlo: «Abbiamo perso il congresso ma anche no». Anche qui, non discuto il merito della frase. Ai democratici della minoranza che lo stavano ad ascoltare in sala diceva qualcosa. Fuori dalla riunione, alla seconda platea, diceva altro.
A pensarci bene quella della doppia platea è la versione ipermoderna del vecchio paradosso nenniano: piazze piene, urne vuote. Dobbiamo sapere che la platea è sempre doppia, parliamo sempre a chi è già d'accordo e anche a tutti gli altri. Ma se, come conseguenza, facciamo un discorso a due facce (una rivolta ai nostri, una rivolta agli altri) diventiamo doppi noi stessi. Chi governa bene e con istinto felice la fenomenologia della doppia platea – i nomi sono superflui – si rivolge sempre, invariabilmente, alla platea più ampia. Impiega quella stretta e prossima come cornice al suo discorso ma non dice neanche una frase abbia significati diversi per le due platee.
Poi la potremo chiamare trasparenza anche se la parabola degli streaming grillini dimostra con chiarezza che le pratiche di trasparenza hanno sempre lo stesso effetto. Non fanno che spostare altrove la necessaria comunicazione riservata fra addetti e, contemporaneamente, incrementano la foia dei retroscenisti e le occasioni e i dispositivi semiotici e tecnologici con cui si esercita. Fuorionda, candid camera, intercettazioni lecite e illecite, teppismi telefonici, microspie, interviste a bruciapelo e a inconscio aperto, labioletture, biglietti fotografati a Montecitorio con teleobiettivi... Tutti altrettanti buchi della serratura: si vede che la porta non è poi tanto trasparente.

La depurazione del linguaggio
Un'altra cosa che si sente sempre dire è che occorre restituire alle parole il loro senso. È un'affermazione che suona bene, ma andrei cauto anche qui. Innanzitutto, a quali parole?
Ci sono le parole-carezza, come esuberi, esodati, ristrutturazione, tagli agli sprechi, scivoli, contrazioni, sacrifici.... Sono tutti eufemismi, e richiedono una certa manutenzione, perché col tempo l'eufemismo perde i suoi poteri carezzevoli e finisce per irritare la pelle. «Casino» negli anni Sessanta e Settanta era una parolaccia e le mamme allungavano sberle.
Ma negli anni Cinquanta era un garbato eufemismo per evitare termini osceni come «bordello» e «lupanare». Anche «vu cumprà» era nato come nomignolo ironico e affettuoso, negli anni Ottanta, quando i primi venditori africani venivano chiamati tutti «marocchini», con intenzioni spregiative: e c'erano «marocchini» del Senegal, «marocchini» del Ghana e persino marocchini del Marocco. Oggi abbiamo anche gli «esuberi» per intendere i licenziandi e si vede come la parola tenda alla mitologia di Roland Barthes: tenda cioè a dare una connotazione tipicamente ideologica e borghese di «dato di fatto naturale» a ciò che è tutt'altro che naturale. Sei finito oltre al limite massimo, non ci si può fare niente: anche perché ce lo chiede l'Europa, certo.
Ci sono poi le parole-bandiera. Quando vengono sventolate noi sentiamo suonare l'inno e i nostri piedi che vogliono mettersi a marciare: «stabilità», «crescita», «governabilità», «rappresentanza»; ma anche «libertà», «famiglia», «sicurezza», persino «giustizia» e «democrazia». Parole spesso semplici, e apparentemente chiare, disponibili per la totalità della platea larga: come suoni. Come senso, sono spesso non così astratte e generiche, e sono ancora meno rassicuranti.
Ci sono le parole-nebbia: riforme, senza dire quali, cambiamento, senza dire in che direzione, tutti i tecnicismi bocconiani della parentesi-Monti. E infine ci sono le parole-ringhio, le parole-sputo, le parole-sfregio. Il turpiloquio, il nomignolo satirico da «Mattarellum» a «psiconano», ma anche ieri «rottamazione» e oggi «frenatori». Connotano disinvoltura nell'uso della lingua e rottura di tabù e possono avere l'effetto di far perdere il controllo all'avversario, per esempio in un talkshow, o di metterlo in cattiva luce, suscitando una risata nella platea.
È un discorso che si potrebbe fare a lungo, e analiticamente. Ma io ho il sospetto che non sia troppo chiaro a dove porti e qui mi pare più urgente puntualizzarlo nel metodo.
Criticare, decostruire e demistificare gli usi lessicali altrui ed evitare di commettere in proprio le medesime scorrettezze è una questione di igiene. Io penso che averla sollevata non abbia mai portato un voto, così come nessuno ci ritiene eleganti se ci laviamo le mani prima di mangiare. La correttezza linguistica e politica non può essere che un presupposto e non un merito, qualcosa che fa parte della formazione del personale politico, ma anche del cittadino, come accade a scuola (o dovrebbe accadere) con ortografia e sintassi.

Le parole sono importanti?
C'è un film famoso, Palombella Rossa, in cui Nanni Moretti impersona un dirigente comunista e pallanuotista che ha perso la memoria dopo un incidente stradale. È un film di 25 anni fa, è uscito nel 1989. In questo film c'è una giornalista che ripete parole come «trend» e non ricordo quali altre, lui la schiaffeggia urlando «Ma come parla? Le parole sono importanti! Chi parla male pensa male!». Aggiungerei alla catena sillogistica una seconda premessa andreottiana: «chi pensa male fa peccato ma ci indovina».
Detto questo, personalmente non mi sento in grado di giudicare né quanto i miei simili parlino male, né tantomeno quanto male pensino. La denuncia di Moretti aveva nobili intenzioni che non mi sfuggono ma ha contribuito a caratterizzare la sinistra, e proprio quella che si ritiene più «critica», in due modi che la svantaggiano parecchio. Come tribunale autoeletto dei migliori e come agenzia per la produzione e la distribuzione di tabu.
Noi siamo quelli che non dicono «trend», noi siamo quelli che non vedono la televisione commerciale, noi siamo quelli che non. A sinistra sono state usate molte volte espressioni altrui come cartine di tornasole, infrazioni a una catechesi senza dei. Aha, hai detto inciucio? Aha, hai scritto centrosinistra con il trattino? Fare così non è stato solo un errore tattico, peraltro grosso: impaccia il discorso e non ci fa comunicare con le persone lontane dalla politica, che nel migliore dei casi si intimoriscono e con noi hanno paura di «sbagliare a parlare».
È stato però, e soprattutto, un errore di fondo, un grave errore di posizionamento e di filosofia politica, perché non esiste né può esistere il partito politico, la parte politica o il campo politico di quelli che «pensano bene» e infatti «parlano bene», segno sicuro del fatto che «pensano bene». Si chiamerebbero «benpensanti», questi, e dovremmo conoscerli bene. Conoscerli, per tenerci alla larga da loro.
Noi però sappiamo che questa idea di sinistra come ricerca intransigente della purezza non è presente solo nella caricatura che di noi fanno i nostri avversari. Noi sappiamo che il politicamente corretto come negazione e come generazione di tabu è parte del nostro patrimonio genetico. Noi sappiamo che si è partiti contro l'oppressione e a volte si è finiti a favore dello snobismo. Con uno di quegli scambi di consonanti che sono la forma più tipica dei lapsus verbali la centralità è passata dai lavori ai valori. Valori che non nomino, proprio perché mi sono molto cari e penso che a nominarli si consumino. Occorre trasmetterli, sì: nella pratica.
Io allora propongo un'operazione radicale di ingegneria genetica: l'istantanea abrogazione dei nostri tabu linguistici. Non significa dire pane al pane e negro al negro. Quello che mi interessa è che ognuno curi la propria igiene verbale per sé e che non pensi che le parole siano di per sé sostanze. Formano e convogliano una visione del mondo, ma o quella appare chiara e convincente per quel che le parole dicono o è vano stare poi a parlare delle parole anziché delle cose.
Le parole sono importanti? Sì, d'accordo, Moretti: ma sino a un certo punto.

Quel che (ch'è) manca
Ma dato che non voglio diventare io quello che procede solo per obiezioni e negazioni, voglio concludere dicendo «cosa è che manca», ovvero «cosa è che è manca», cosa è la sinistra, per come la vedo io e nel campo che mi compete.
Manca un senso maturo della libertà espressiva di ognuno e di quanto sia proficua la diversità dei codici. Il politicamente corretto è criticabile anche perché pensa a Babele come una iattura, e rimpiange un linguaggio adamitico, edenico, uguale per tutti che non è mai – dico mai – esistito fuori dell'Antico Testamento e della Torah. C'è una sinistra che pare alla ricerca della lingua perfetta, magari quella degli angeli. Sono compagni che sbagliano, qui sono proprio sicuro di me. In un mondo in cui se c'è un obbligo sociale è quello di trasgredire, o almeno fingere di farlo, lavorare alla costruzione di nuovi tabu è saggio e proficuo quanto aprire una bottega di maniscalco in un autogrill.
Manca una considerazione adeguata dei valori. Non è bello e non è di alcun vantaggio esibirli. Si fa bling bling, e possono sembrare anche ricchezza indebitamente accumulata, quei valori indossati. Ognuno, immagino, cerca di essere quello che in modo melenso si definisce «una bella persona». Ma pensare di esserlo già e dirlo è un comportamento da damerini e la politica è lavoro, non è salotto e passerella. Quindi occorre lavorare perché i «valori» non siano solo le parole che li nominano, ma siano la tensione a raggiungerli e a costruirli nel reale.
Manca la pienezza delle parole, le abbiamo svuotate anche noi e anche per troppo affetto o per affetto troppo maldestro. Affezioniamoci di meno alle nostre parole, viaggeranno più leggere e sicure nel mondo.
Manca produrre senso comune, che non è luogo comune. Il senso comune è consenso. Che non sia tollerabile che nei nostri mari affondino barconi carichi di persone mi pare stia diventando senso comune, dopo gli anni delle più ipocrite e criminali politiche di immigrazione. Questo per fare un esempio positivo. Un altro esempio potrebbe riguardare i diritti civili, in tema di famiglie o in tema di morte assistita.
Mi illudo che, con il permesso del Vaticano, qualcosa stia già capitando e proprio in termini di coscienza nazionale: la politica arriverà anche qui, e anche qui buona ultima. Che la crisi economica sia lontana dalla soluzione, che abbia spesso fondamenti strutturali e non contingenti, pure questo mi sembra senso comune, un vero sapere diffuso che può anche generare disperazione sociale. Non di senso comune mi pare invece il legame fra il tasso italiano di disoccupazione giovanile e la riforma costituzionale del Senato, e anzi vorrei che qualcuno, se lo vede, lo mostrasse a me.
L'espressione «senso comune» fa paura? Le esigenze della propaganda richiedono sorpresa e stupore. Ma le esigenze della politica tengono conto anche della banalità del vivere, delle cose che sanno tutti, dei sentimenti diffusi: con maggiore pazienza e minore visibilità devono cercare di farli crescere nella direzione che pare la migliore. Questo è il consenso. Con la cultura, per esempio, è vero che non si mangia: la politica mangia pochissimo con la cultura, non è come con gli appalti e la spesa sanitaria. Ma senza cultura, senza formazione, senza capacità di approfondimento, di critica e persino di espressione fra poco a non mangiare sarà la Nazione. Su questo il consenso non c'è, ed è urgente che se ne crei il sentimento.
Manca, infine, e spero per poco, la costruzione di un'identità politica collettiva che possa generare messaggi politici nuovi, nuovi nel senso di aggiornati e adeguati al nostro tempo, e che non sia invece essa stessa generata da messaggi di propaganda, come quelle formazioni politiche che vengono chiamate sintomaticamente «cartelli».
L'ultimo desiderio
La campagna elettorale è il sintomo nevrotico e compulsivo della politica italiana. Si dice che siamo sempre in campagna elettorale e non è tanto esagerato. Il desiderio è un'altra cosa. Quando il cielo era coperto gli astrologi non potevano vedere le stelle, in latino sidera. Allora de/sideravano, distoglievano lo sguardo da ciò che a loro mancava. La parola desiderio viene proprio da lì.
C'è e ci sarà sempre qualcosa che manca, c'è ci sarà sempre qualcosa che è manca, che è sinistra.
Fra cieli stellati sopra e leggi morali tenute ben dentro possiamo trovare sia le parole per dirlo, il famoso qualcosa, sia i modi per costruirlo e farlo esistere.