Speciale
Chi l’ha detto che il futuro non è prevedibile? / Kurt Vonnegut, Il grande tiratore
Continua il nostro speciale Ritorno al futuro. L'idea è quella di rileggere libri del passato che offrano una prospettiva capace di illuminare il momento che viviamo oggi. Per leggere gli altri contributi cliccare sul nome dello speciale a sinistra sopra il titolo in questa stessa pagina.
Chi l’ha detto che il futuro non è prevedibile? C’è chi ne è capace. Kurt Vonnegut, ad esempio. A sessant’anni, nel 1982, pubblicò un libro che è bene rileggere oggi, anche perché, dopo essere stato tradotto nel 1984 da Bompiani, ricompare in questi giorni per i tipi di Feltrinelli, editore che si è distinto nella benemerita opera di ristampa di uno dei più grandi scrittori americani della generazione nata tra le due guerre. Il romanzo s’intitola Il grande tiratore (traduzione di Pier Francesco Paolini, pp. 222, € 17) e contiene: l’ossessione americana per le armi; la storia di un aspirante pittore, figlio di milionari americani, che va a Vienna per iscriversi all’Accademia di Belle Arti e diventa amico di Adolf Hitler; la descrizione di una città dell’Ohio, che sembra ritagliata sull’oggi trumpista; poliziotti maneschi che picchiano gli arrestati e li mettono alla berlina; un giovane “neutro”, aspirante commediografo e farmacista di professione; un’esplosione nucleare; e altre cose ancora. I romanzi di Vonnegut sono bauli pieni di robe incredibili, raccontate in modo scorciato, rapido, illusionistico e mirabolante. Sono per lo più privi di dialoghi e in genere la voce narrante, che dice io, è un personaggio improbabile, uno spostato, quasi uno scherzo di natura, eppure perfettamente realistico. Come faccia a imbastire storie così, è un mistero, dal momento che vi immette comicità e sarcasmo a piene mani, e volge tutto in tragedia, fermandosi però un millimetro prima della caduta finale. Tutti i suoi libri contengono storie ultime, o più spesso post-ultime. Qualcosa d’impossibile; o meglio, qualcosa che riesce solo a lui. Per intenderci, Vonnegut mette in scena il protagonista, Rudy Waltz, autore di una strampalata commedia che ha vinto un premio; il suo testo sarà rappresentato per una sera soltanto a New York.
Rudy, voce narrante, ci riassume la trama, mentre utilizza la “forma commedia” per raccontare alcuni episodi della sua esistenza, come il litigio tra il fratello e la sua seconda moglie nel momento in cui si lasciano a causa sua. Pagine di dialoghi da pura commedia americana, finzioni nella finzione, dato che non è detto che Rudy fosse davvero presente quando avvenivano, ma come commediografo li ricostruisce alla perfezione. Sono piccoli gioielli narrativi che dimostrano come Vonnegut sappia tenere in pugno le sue scombinate storie dando loro un senso ulteriore grazie alla manipolazione dei generi, che tuttavia mette alla berlina di continuo pur tenendoli in così seria considerazione. Il che senza essere uno di quei narratori postmoderni che ci hanno intrattenuto negli ultimi trent’anni. Lui se ne frega delle etichette, poiché lui è solo Kurt Vonnegut, uno che ha scritto il più bel romanzo sulla Seconda guerra mondiale ibridandolo con un romanzo di fantascienza senza perdere il buon umore: Mattatoio 5.
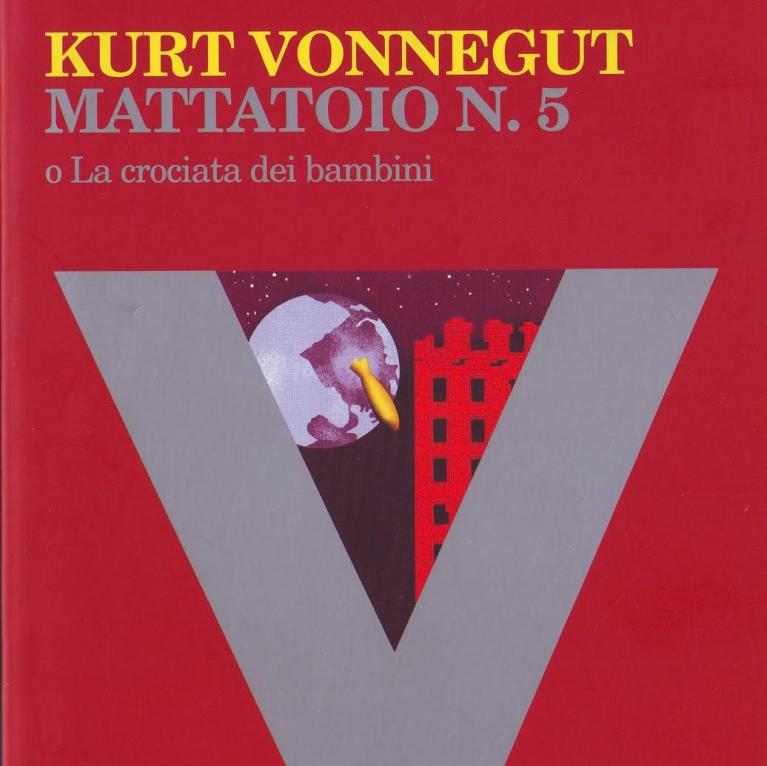
Ma torniamo al Grande tiratore. Rudy è figlio di un ricco rampollo, Otto Waltz, uomo convinto di possedere un enorme talento artistico, in realtà è solo un istrione scombinato e folle. Otto è respinto dall’Accademia viennese; lì fa la conoscenza di un altro bocciato, tal Adolf Hitler, con cui entra in relazione e a cui acquista un quadretto che resterà appeso nella sua camera nuziale nei decenni a seguire. Tornato in America, in seguito alla vittoria elettorale e alla conquista del potere di Hitler, diventa un fervente nazista, erige uno studio bizzarro dove esercitare la sua arte dipingendo, senza finirlo, solo un quadro. Nel frattempo ha comperato un arsenale di armi da fuoco di un nobile decaduto, e l’ha allestito nella propria casa. Sarà proprio questa dotazione di armi da fuoco che userà il figlio, al fine di diventare grazie a un solo e mortale colpo “il Grande Tiratore” della città di Midland City. Riassumere la trama di un libro di Vonnegut è come arrampicarsi sugli specchi, perché i suoi libri sono un succedersi di trame riassunte dal narratore stesso, in cui quello che importa non è quanto si dice – anche quello naturalmente – ma come lo si dice. Il come è l’indefinibile stile di Vonnegut, una mescolanza di stoltezza, barcollamenti e inevitabili destini. Come se le storie della tragedia greca fossero raccontate da un narratore alticcio e assai compiaciuto d’esserlo.
Il destino è la musa discreta di questo scrittore che si diverte a ibridare i generi e a mescolare le carte in modo tale che tutto torna in modo inoppugnabile, eppure altamente risibile. La natura profonda dei suoi protagonisti è quella di essere dei “lebbrosi sociali”. Sono loro che permettono con la loro logica rovesciata, con lo slapstick mentale delle loro vicende, di mettere a nudo la natura truffaldina della società in cui vivono. Tutto falso, tutto vero: tutto falsamente vero. Sono quelli che in una loro bella antologia Gianni Celati e Daniele Benati hanno definito “i solitari americani”. Invece di distanziarsi dalla società in cui vivono, invece di diventare dei solitari, appunto, i suoi personaggi principali sono malati di socialità, o almeno così sembrano, perché la maggior parte di loro si traveste per restare dentro quella società che non fa che espellerli.
Rudy ha sparato con il suo fucile un solo colpo, che è andato a trapassare la testa di un’onesta casalinga madre di due figlie e in attesa di un terzo nella parte opposta di Midland City. Così diventa il Grande Tiratore, una leggenda vivente e un insieme reietto patentato. La ricchezza, come in ogni storia americana che si rispetti, si accumula con facilità e altrettanto facilmente svanisce. Dalla grande casa al tugurio di periferia, con il ritmo inarrestabile della fiaba dove ogni cosa succede all’altra con rapidità: dalle stelle alle stalle, letteralmente. L’editore ha stampigliato sulla quarta di copertina la frase finale del romanzo: “Volete sapere una cosa? Viviamo ancora nel Medioevo. I Secoli Bui non sono finiti”. Un monito che con il suo abituale sarcasmo Vonnegut regala ai suoi lettori. Quando se n’è andato dodici anni fa non c’era ancora Donald Trump, personaggio che sembra uscito dalle sue pagine tanto è stereotipato, imprevedibile e bizzarro, e insieme orrendo. Possiede, come molti personaggi dello scrittore americano, una natura da cartone animato, se non fosse che si tratta del presidente del più importante – per il momento – paese al mondo. Niente di più imprevisto e, dal punto di vista di Vonnegut, di altrettanto prevedibile, come mostra anche Un pezzo da galera (1979), che racconta la Casa Bianca di Richard Nixon nell’epoca del Watergate.
Perché bisogna leggere Vonnegut? Perché è divertente, perché fa pensare, perché t’incanta con la sua raffica di coincidenze e paradossi, perché ci fa vedere che la realtà è una nostra assoluta invenzione, una credenza, come dicono gli psicologi, cui tendiamo a conformarci senza accorgerci che l’abbiamo generata noi. L’assurdo è la musa dello scrittore americano, un assurdo, come mostrano le ultime vicende di quel paese, sempre possibile e reale. Sogno o son desto?, viene spesso da chiedersi mentre si leggono le fulminanti pagine di questo libro. Possibile che questo accada? Possibile! Anche se sono solo romanzi, hanno tuttavia il vantaggio di descriverci la realtà qualche ora (o giorno o mese) prima che noi iniziamo a viverla. Spaesamento e realismo, paradosso e verità. Tutto è inafferrabile come la storia dell’ex militare ricopertosi di gloria nella Seconda guerra mondiale, figlio esemplare di Midland City, che va a cercare la sua Shangri-la in Nepal e lì muore ed è sepolto, per diventare poi l’inatteso protagonista della commedia di Rudy Waltz. Incroci del destino che compongono la tessitura di un libro che non smette mai di sorprenderti. Nel sottofondo della narrativa di Kurt Vomnnegut c’è un mood depressivo, latente, insistito, mai svaporato, sempre nebulizzato come uno spray. Una nuvoletta che incombe sui suoi narratori, quei solitari americani incongrui e incomprensibili votati al disastro finale, Rudy e il fratello, altra creatura incongrua, sono rifugiati a Haiti dove hanno investito i loro capitali in un albergo. Rudy infarcisce il racconto con deliziose ricette sperimentate nel suo rifugio haitiano, prima di consegnarci la cronaca del ritorno nella città natale dove è accaduta un’esplosione nucleare: una bomba atomica che ha lasciato inalterati gli edifici e ucciso le persone. Sotterrate queste in un cratere prontamente ricoperto di terra, Rudy può rivedere la città della sua personale tragedia, amata e odiata, in un tour che sembra mimare quello del turismo attuale, dove milioni di persone visitano ogni anno, non rovine romane e greche, bensì mirabolanti città occidentali per fare shopping: il mondo è finito e non ce ne siamo ancora accorti. Con Kurt Vonnegut il divertimento è assicurato, la risata pure, anche se è spesso si tratta di un riso nero e altamente amaro.









