Un libro di fotografie di Ramak Fazel / Silicon Valley – No _ Code Life
Cos’è la Silicon Valley? Dove si trova, come vivono, chi sono davvero gli abitanti di una zona fantasma, difficilmente circoscrivibile sulle mappe? Ramak Fazel ha cercato di mostrarlo, in un lavoro crudamente documentativo sviluppato tra il 2019 e il 2020 (proprio poco prima che esplodesse l’allarme pandemia) nell’arco di sei settimane, nel libro Silicon Valley – No_Code Life.
“Loro sanno tutto di noi, ma noi cosa sappiamo sulla vita nella Silicon Valley?”, è stata la domanda scatenante durante una cena avvenuta nel 2016 in un ristorante in Piazza Duomo a Milano tra quelli che sarebbero diventati i fondatori del progetto “Tod’s No_Code”, inaugurato nel 2019, che vuole appunto sistematizzare varie discipline, integrando le nuove tecnologie con l’artigianato italiano, per portare a galla i temi salienti della nostra contemporaneità.
Per questo motivo hanno subito coinvolto Ramak Fazel, nato nel 1965, ingegnere meccanico e fotografo cresciuto tra Teheran, Utah e Indiana.
Fazel, come si legge nella breve nota biografica dedicatagli all’inizio dell’elegante e voluminoso libro edito da Rizzoli New York e in Italia da Mondadori Electa, “lavora dentro, intorno e qualche volta contro le tradizioni della fotografia e dell’installazione.” Questa caratteristica della sua ricerca è particolarmente evidente in questo lavoro. Proviamo a capire perché.
Volendo partire proprio dall’inizio, il sottotitolo del progetto Silicon Valley – No_Code Life è “Visual Essay by Ramak Fazel”. Un saggio visivo.
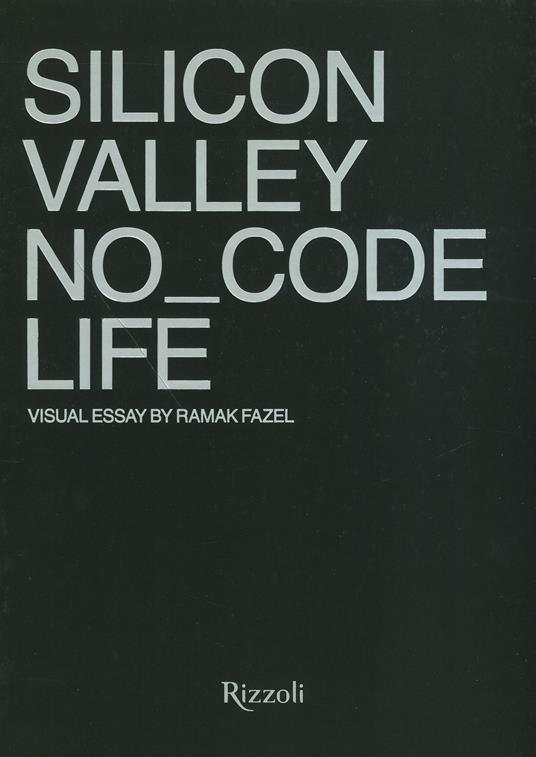
Un saggio che usa le immagini approderà al proprio intento di documentazione e di ricerca con un excursus narrativo quanto possibile obiettivo, seppur non privo di uno sguardo autoriale sul tema preso in esame, per condurre l’occhio di chi lo “legge” sì verso una meta prescelta, ma senza lasciare spazio a un pathos eccessivamente invasivo e fuorviante.
Prendiamo ad esempio una fotografia in cui ci si imbatte dopo una trentina di pagine (le immagini nel libro non hanno titolo, bensì sono accompagnate solo da qualche riga di didascalia) raffigurante una scena immobile in prospettiva accidentale in cui un grosso bus nero, fortemente illuminato dal flash insieme a una buona porzione di strada, è parcheggiato a fianco di un teatro con una signorile facciata rosa e di fronte al quale si vedono un’insegna a neon spenti “Broadway” e un cartello che dice, o meglio chiede: “How much can you save?”.

Per quanto ci siano alcuni elementi sufficienti per creare un prima, un dopo e un perché di questa immagine, la didascalia è indispensabile a capire il giusto contesto. Infatti, viene spiegato che quel particolare bus è uno dei mezzi messi a disposizione per i lavoratori dei tech campus del sud della Valle, e nei quali sono stati installati numerosi comfort per motivarli a lavorare durante il viaggio.
Solo con questo processo l’immagine riesce a dare il La per aprire delle parentesi informative efficaci sulla vita della Silicon Valley.
In questo lavoro Ramak Fazel ha fatto due importanti scelte tecniche per approfondire il suo soggetto, ovvero l’uso di una Rolleiflex analogica con pellicola a colori, e il flash.
La Rolleiflex è la famosa una macchina fotografica biottica col mirino “a pozzetto” che consente di inquadrare guardando dall’alto che si vede anche in un celebre autoritratto di Vivian Maier, nel caso di Fazel caricata con una pellicola detta “6x6” o “120”, ovvero con i frame del negativo di forma quadrata, di circa sei centimetri per lato.
Le immagini del progetto sono infatti tutte quadrate, formato per qualche tempo accantonato nella storia della fotografia in favore di quello rettangolare classico in proporzione 2:3 ma tornato molto in voga negli ultimi anni con Instagram, nato per l’appunto in un’azienda della Silicon Valley.
I soggetti prediletti sono luoghi e persone rappresentati in scene letteralmente congelate, estratte dal loro spazio-tempo e come analizzati su un vetrino al microscopio, sotto la luce spietata dell’occhio che guarda soltanto e rivela.

Vediamo così interni di locali spesso arredati coi simboli degli States e dei progressi della ricerca tecnologica compiuti nella Valle, come il primo sistema Apple che si intravede dietro una cliente al Buck’s Restaurant; oppure entriamo in negozi di tecnologia come B8ta o ancora nella caffetteria e nel campo da beach volley di Googleplex.
Capita di trovarsi anche nelle stanze private dei più importanti ricercatori nel campo high-tech, come Anjan Katta, magari in disordine e senza che ci venga rivolto lo sguardo, intento invece alla lettura, potendo entrare in contatto con lui quasi restando invisibili, potere raramente conferito al fotografo e alla fotografia.

Si entra e si esce con ritmica cadenza da innumerevoli luoghi, incluse lavanderie a gettoni, aule in cui si formano i futuri ricercatori o cucine comuni di gruppi di lavoro ricevendo input pressoché unidirezionali su un paio di temi correlati: ricerca tecnologica e progresso economico. Arrivando di fronte a una residenza a San José scopriremo così che in un solo anno il valore delle case è cresciuto di 100 dollari all’ora; o, di fronte a un edificio costruito sulla riva di un fiume, che la necessità di nuovi spazi lavorativi ha spinto l’edilizia fino ai margini delle paludi bonificate.

Capita però anche di incontrarsi faccia a faccia con gli abitanti della Silicon Valley, magari in posa di fronte a noi nei loro habitat. Ingegneri, hacker, manager, CEO, o personaggi legati ai nomi che popolano il nostro immaginario e la nostra quotidianità, come gli ex vicini di casa di Steve Jobs e Steve Wozniak. In poltrona, a cavallo, seduti in un pub o scesi da un giro con la tuta alare, le persone ritratte includono raramente bambini o anziani: il lavoro di Fazel si focalizza sulla fascia lavoratrice, su chi mette in moto i meccanismi di cui veniamo mano a mano a conoscenza, e che può creare o trarre profitto dall’ambiente in cui ci si addentra di pagina in pagina.

Formalmente i ritratti e i paesaggi urbani risultano razionali e quasi sempre “bruciati”, cioè con porzioni di dettagli assenti per l’uso massiccio del flash.
Il flash, infatti, notoriamente annulla le ombre appiattendo il soggetto ed eliminando ogni scala di valore tra i piani. Rende inoltre difficile la percezione della temperatura colore, così da venire proiettati in un quadro senza parete e senza struttura che lo sorregga, esattamente come appaiono le persone immobilizzate in varie, apparentemente insignificanti azioni.
Ogni cosa, dal fanale dell’automobile all’occhio semichiuso dell’uomo che gioca all’autoscontro, è soggetto senza predicato, racchiuso in un istante senza che sia davvero fondamentale la vitalità dentro il gesto: ogni intenzione motoria è intuita e prevista senza il bisogno di ricamarci sopra nient’altro.
Anche nell’immagine che raffigura un gruppo di giovani in cerchio mentre chiacchierano di fronte a un edificio anonimo che riporta soltanto il numero 3350 e in mezzo alle auto parcheggiate, troppo illuminati dalla doppia azione del flash e della forte luce del sole, si assiste a una scena pressoché insignificante, brutalmente rappresentata, con la quale è impossibile far scattare un qualunque movimento emotivo o di interesse profondo. Eppure stiamo guardando parlare tra loro i membri dell’Hacker Dojo, situato al 3350 della Thomas Road di Santa Clara, che, come riporta la didascalia, possono potenzialmente formulare idee rivoluzionarie in qualsiasi situazione, magari proprio nel momento in cui è stata scattata la fotografia.

Strutturare la propria ricerca con l’uso del flash non è una novità, sono stati in molti a usarlo dedicandogli determinati connotati poetici, non sempre simili tra loro: facciamo l’esempio di Ren Hang, il fotografo cinese che ritraeva i suoi amici in crude ma metaforiche immagini di nudo, spesso in posa con animali come pesci o pavoni; o Nan Goldin, che invece mette a fuoco scene di vita underground statunitense.
Il flash non è una condanna definitiva, può lasciare spazio a dei varchi interpretativi altrimenti difficili da ottenere: la crudezza di sguardo che comporta è l’anticamera dell’obiettività, di un’impassibilità necessaria per il fine comunicativo cercato.
Nel caso del lavoro di Ramak Fazel, questo espediente tecnico appare particolarmente coerente con ciò cui ci si trova man mano di fronte: un luogo in cui ogni destino appare avviato verso un unico fine professionale e tematico, in cui ci si chiede se siano contemplati una biblioteca o un museo d’arte moderna e che in definitiva appare già di per sé fuori dal tempo e dallo spazio. Il linguaggio usato da Fazel per generare le proprie immagini, con uno stile quasi da “buona la prima”, ricalca proprio questa impressione di alienazione geografica e culturale.
Come gli ultimi fotogrammi di un film che si chiude nel silenzio, il viaggio nella Silicon Valley in cui ci conduce Fazel tra aziende e manager, hacker, ingegneri, supermercati indiani, autostrade, meccanici, chiese e università, ha una coda che sfocia nel paesaggio naturale, negli spazi aperti. Poche ultime immagini ritraggono distese di erba secca e sterpaglia, in cui si stagliano alberi spogli e ritorti, illuminati sempre da un flash impietoso, ancora più invasivo in giornate in cui il sole è del tutto assente. Il finale è dunque lasciato aperto, potrebbe iniziare un altro viaggio, un’altra indagine; ci si può chiedere se anche in quell’area di mondo – quando non è illuminata dal flash – si alternino le stagioni, se sia un fenomeno notato da qualcuno, se qualcuno popoli anche queste ultime zone ritratte. Non c’è didascalia che accompagni queste visioni in chiusura, solo un unico indizio che chiude il cerchio prima di aprirne un secondo: nell’ultima fotografia si vede in lontananza un soggetto apparso tra le prime immagini del libro, “The Dish”, l’enorme antenna radio di Stanford. La Silicon Valley porge così i suoi saluti; la firma di un impero deve dominare gli orizzonti più vasti prima di lasciarci voltare le spalle.









