Pensiero tragico / Critchley, A lezione dagli antichi
Monica Guerritore, l'attrice che ha rappresentato il mondo del teatro agli Stati generali indetti dal premier Conte nel giugno 2020, ha confessato il suo sogno teatrale: “Penso a una mise en espace di Antigone, Medea, delle Troiane, con gli attori in tunica, all'imbrunire, al grande teatro classico che potrebbe ridare nuova vita anche ai piccoli paesi. Tra l'altro questo tipo di rappresentazioni, basate sulla forma oratoria, permette di evitare il contatto”.
È il prototipo di teatro che rischia di trionfare in questi mesi, a causa del distanziamento sociale che privilegia i monologhi e a un vuoto di idee che spinge i programmatori a chiamare attori famosi per recitare testi famosi, anche se la sale sono svuotate dalle misure anti-Covid e sarebbe davvero possibile e utile correre qualche "rischio culturale", fuori dalle logiche del puro mercato e del consenso a tutti i costi.
Con ogni probabilità Simon Crichtley, mentre cercava di “Comprendere il mondo in cui viviamo attraverso la tragedia greca” (così recita il sottotitolo del suo saggio A lezione dagli antichi, Mondadori, 2020) non aveva in mente un allestimento estetizzante, neoclassico, imbalsamato dei testi di Eschilo, Sofocle, Euripide, anche se è molto lontano dalle letture dionisiache dell'antico.
Crichtley è un filosofo britannico con un certo sense of humour: nel Libro dei filosofi morti (Garzanti, 2009) metteva a confronto le ultime parole dei grandi pensatori con la loro visione del mondo. In questo saggio (che nell'originale si intitola Tragedy, the Greeks, and Us) ha ricapitolato un'ampia gamma di studi sulla tragedia greca, più filosofici che filologici, per capire che cosa continui ad appassionarci, oggi, in questi testi vecchi di 2500 anni, nonostante la sentenza con cui George Steiner aveva decretato La morte della tragedia (Garzanti, 2005), ovvero l'impossibilità del tragico nella modernità.
A lezione dagli antichi non prende la scorciatoia dei “greci nostri contemporanei”, come Jan Kott in Mangiare Dio (un classico riproposto nel 2017 da Abscondita), dove lo studioso polacco riporta sistematicamente l'antico al moderno. Non si confronta nemmeno, a parte un paio di riferimenti, con le messinscene contemporanee, come fa Dionysus Since 69: Greek Tragedy at the Dawn of the Third Millennium (curato nel 2004 da Edith Hall, Fiona Macintosh e Amanda Wrigley), dove è centrale il recupero della dimensione rituale, a partire dall'epocale allestimento delle Baccanti di Richard Schechner a New York nel 1969 (due testi che peraltro non vengono citati).
I brevi capitoli si confrontano piuttosto con le letture filosofiche, stratificate e contraddittorie, della tragedia, inseguendo un dibattito che è partito con Platone e non è ancora terminato. I terreni di scontro sono diversi e tutti di notevole interesse e spesso di grande attualità.
Il primo riguarda la prospettiva con cui si guarda alla nascita della tragedia. C'è chi, come Nietzsche e Platone, va all'indietro, alla ricerca dell'origine, trovandola nel rito o nel mito. C'è invece chi è più interessato alla dimensione etica e politica che si sviluppa con la tragedia, come Jean-Pierre Vernant e Pierre Vidal-Naquet. Crichtley si pone su questa linea, tracciata anche da un altro autore che non menziona, il tedesco Christian Meier (L’arte politica della tragedia greca, Einaudi, 1988, e Atene, Garzanti, 1996). In questa visione, il teatro e la tragedia sono incardinati nella vita della città e dei problemi, individuali e collettivi, dei suoi abitanti.
Una seconda linea di faglia riguarda il rapporto – o meglio la guerra – tra il teatro e la filosofia. La terza e la quarta parte del saggio sono dedicate alla visione della tragedia di Platone e di Aristotele. Per affermare la superiorità della filosofia sul pericoloso concorrente, l'aristocratico Platone è costretto a utilizzare la sua stessa forma, il dialogo, quasi a volerlo sconfiggere con le sue stesse armi. Aristotele, quando ormai la battaglia della filosofia sul teatro è stata vinta (e quando la democrazia ateniese è ormai un ricordo), potrà utilizzare la forma monologica. Ma la sua benevolenza nei confronti del teatro rispetto alla durissima critica platonica, per Crichtley è dovuta soprattutto alla magnanimità del vincitore.
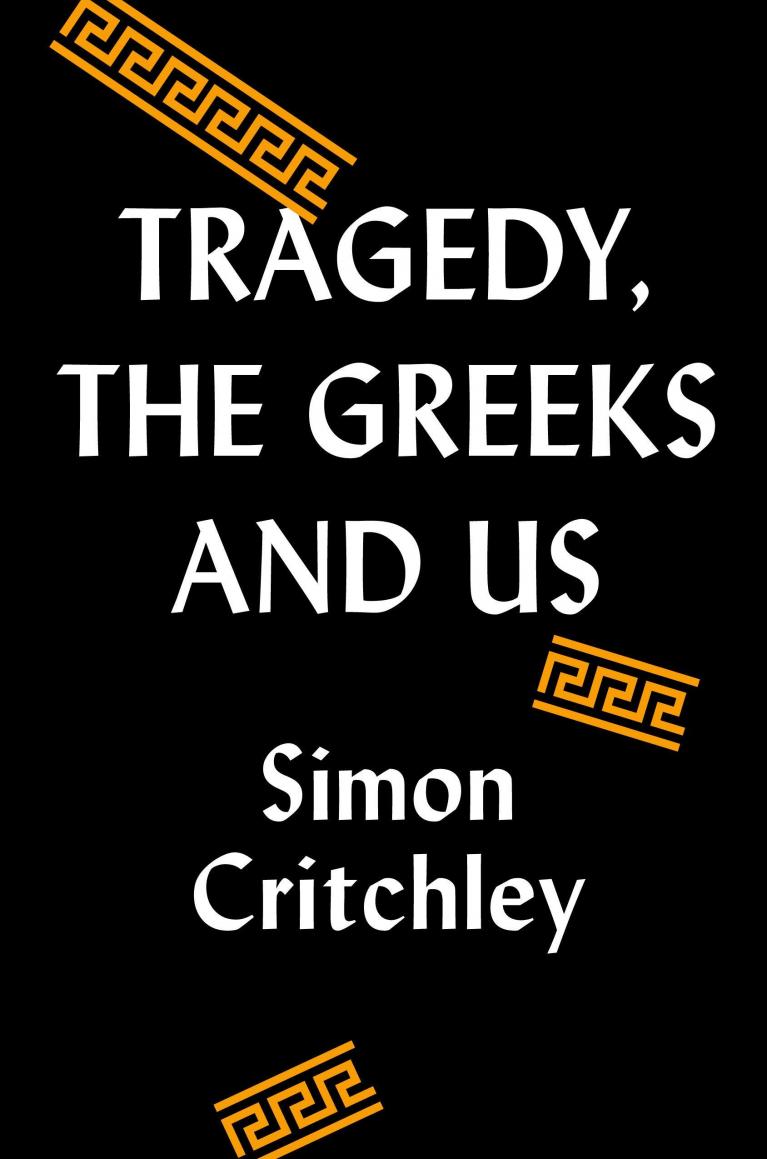
Quando Aristotele scrive la Poetica, il teatro non è più quell'esperienza collettiva potenzialmente destabilizzante, in quanto contiene in sé anche i contrasti irriducibili sul piano dell'etica, della politica, della giustizia. Ormai è solo emozione e stupore, spettacolo. Il vero potere sta altrove. Non ha più senso polemizzare contro la “teatrocrazia”, come faceva Platone anticipando le critiche alla “società dello spettacolo”.
Nonostante Platone e Aristotele, in questa battaglia Crichtley si schiera dalla parte del teatro. O meglio, riscopre il tragico come modalità di esperienza e forma di pensiero anti-filosofico. Il monologo del trattato filosofico appiana le contraddizioni, costruisce un sistema, ordina e in fondo rassicura. La tragedia (e il teatro) riescono invece a esprimere l'energia contraddittoria della vita, nelle sue varie dimensioni: a cominciare dalla giustizia, dove si scontrano principi inconciliabili. Nell'Orestea, Díke (la “giustizia”) è dalla parte delle Furie o da quella di Oreste? Dobbiamo seguire il nómos (la “legge”) degli uomini, come Creonte, o quella degli dei, come Antigone? Nelle Supplici, krátos (il “potere”) è nelle mani del re o in quelle del popolo?
Il teatro rende fluido il confine tra il presente e il passato, tra l'umano e il divino, tra l'uomo e la macchina (o il deus ex machina caro a Euripide), ma anche quello tra i sessi. Euripide irritava il maschilismo di Platone e Aristotele scegliendo come protagoniste “donne di carattere” come Fedra o Medea, per non parlare dello scandaloso travestimento del macho Penteo quando vuole spiare i riti dionisiaci. Ma la tragedia rende permeabile anche il limite tra spazio privato e spazio pubblico: la sola presenza di Antigone davanti alla reggia, sulla piazza di Tebe, era già un doppio scandalo. In questa ambiguità, nella capacità di far emergere il perturbante, il pensiero tragico trascende quello filosofico, che al confronto appare rassicurante. I tragici sanno che la vita è “uno scenario di subbuglio e di rabbia intriso di dolore” (p. 23).
Dietro questa dialettica, ne emerge un'altra. Il teatro (e le Grandi Dionisie, con gli agoni tragici) nasce insieme alla democrazia, e al tempo stesso contribuisce a costruire cittadini consapevoli, in grado di discutere e deliberare su problematiche complesse dal punto di vista etico e politico. Il legame tra teatro e democrazia era ben chiaro all'antidemocratico Platone, che nella Repubblica e nelle Leggi vagheggiava una Repubblica governata dai filosofi, dalla quale gli attori (e i poeti) dovevano essere banditi.
Per Platone, la “teatrocrazia” era troppo vicina alla democrazia diretta, all'“uno vale uno” delle assemblee digitali che di fatto azzerano il parere degli esperti e instaurano la dittatura del dilettante, portando alla degenerazione della democrazia in tirannide, attraverso quello che oggi definiremmo populismo e che per gli antichi greci era demagogia, la creazione del consenso attraverso la manipolazione emotiva. Ma soprattutto – con il sovversivo e provocatorio Euripide – la tragedia azzera sistematicamente tutti i dogmi, ovvero i “valori” sani che avrebbero ispirato il saggio Eschilo (entro certi limiti, a ben guardare).
Per Platone, la degenerazione della democrazia è effetto e causa della spettacolarizzazione del teatro. La sua soluzione è una sorta di “governo dei tecnici”, ovvero i filosofi, gli esperti. Sono problemi che la cultura occidentale si porta dentro da allora. L'argomentata polemica di Francesco Pallante, fin dal titolo Contro la democrazia diretta (Einaudi, 2020), spiega che la soluzione adottata dalle moderne forme politiche è stata la democrazia rappresentativa, che consente (o consentiva) di trovare una mediazione tra i diversi interessi espressi dalla polis, attraverso la forma partito e gli organi intermedi della società (associazioni, sindacati, eccetera).
Ma il conflitto, argomenta Massimo Cacciari in Il lavoro dello spirito (Adelphi, 2020), è ancora più profondo. Sulla scia di Max Weber, è la dialettica tra due forme di “lavoro spirituale”. Da un lato si è imposto il “lavoro scientifico”, che regola il mondo del lavoro, delle professioni, della tecnica, e ha imposto l'ordine dell'economia e della finanza: appare dotato di una dinamica autonoma, in una una “rivoluzione permanente”, ma al tempo stesso appare sempre più frammentato, specialistico, e dunque irriducibile a una scala di valori unitaria. Dall'altro c'è – o ci sarebbe – il “lavoro politico”, che dovrebbe essere in grado, attraverso la forma della rappresentanza, di “conferire un ordine alla contingenza, di organizzare con metodo le contraddizioni, che minacciano di esplodere, riconoscendo i limiti che reciprocamente si impongono l'una all'altra le due forme fondamentali di geistige Arbeit” (p. 87). Ma, commenta Cacciari, preoccupato e disilluso come Platone, la crisi della rappresentanza (di cui è banale elencare le cause) “si accompagna al dilagare dell'idea della possibile identificazione tra Governo e pubblica opinione. Il riconoscimento della complessità sociale, che sta a fondamento del politeismo democratico, scompare nel mito del Popolo. E il Popolo esige im-mediatamente il Capo, ovvero esige che questo proclami: sono il tuo Capo e perciò ti seguo” (p. 89).
Se non si riduce a effetto speciale, la tragedia dovrebbe essere in grado di rendere evidente la complessità in cui siamo immersi. “Considerare gli eventi politici tragicamente significa sempre riconoscere la nostra complicità nel disastro che abbiamo davanti. Noi siamo il pubblico nel teatro della guerra, e abbiamo anche noi la nostra parte di responsabilità. Grazie alla tragedia possiamo allora trovarci nella situazione di comprendere una situazione di guerra, di violenza e di dolore, anziché limitarci alle condanne o a riempirci la bocca di vuoti appelli alla pace” (p. 23).
Per aiutarci a capire il mondo in cui viviamo, ci è ancora necessario un “pensiero teatrale”, o meglio, la polifonia dei diversi pensieri e delle diverse poetiche teatrali. Basti pensare al percorso di intellettuali (prima ancora che teatranti) come, in Italia, Luca Ronconi, Giuliano Scabia, Mimmo Cuticchio, Romeo Castellucci, Pippo Delbono, le Albe, Motus, Emma Dante, Armando Punzo o Antonio Latella.









