
L’impostore di Giancarlo Alfano / Mentire, imbrogliare e raggirare
Prima ancora che l’uomo facesse la sua comparsa, gli impostori già vagavano per la terra e il cielo nella forma perfetta degli dei. Competizione, sopraffazione, libidine, potere, puro gioco, segreto, c’era già tutto, al massimo grado di perizia e raffinatezza. Poi i superni si devono essere stancati di riservare tanta sublime arte alla propria consorteria in fin dei conti ristretta e hanno cercato un altro pubblico e nuove vittime. E così, come per tutto, è iniziata la decadenza, il piccolo cabotaggio. Sono arrivati gli umani. Che, manco a dirlo, non ci hanno messo niente a imitarli. Così potevano pensare di essere simili a loro, se non uguali. Anche l’illusione è facile. Ciò non toglie, però, che qualche fulgido esemplare sia comparso qua e là, anche se soprattutto sotto forma di personaggio mitico o letterario. Giancarlo Alfano ha provato, con ottimi risultati, a rintracciarne i caratteri salienti e a seguirne il mutevole percorso nei tempi moderni nel suo ultimo libro, Fenomenologia dell’impostore. Essere un altro nella letteratura moderna (Salerno editrice, 2021, p. 225), ibridando “la teoria della letteratura coi modelli della sociologia, … questioni letterarie e antropologiche, … la retorica e l’esperienza teatrale”.
Impresa ardua, che doveva per forza passare per esempi fondativi e paradigmatici. Ovviamente, dato che, andando bene a vedere, fare la storia dell’impostore sarebbe stato come fare la storia praticamente di tutta la letteratura: e non solo perché già da prima di Manganelli è risaputo che la letteratura è menzogna, ma perché di menzogne, inganni, maschere, sostituzioni, infingimenti, doppiezze praticamente parla sempre. Tutto il resto è scipito, sembra, a dispetto di quanto sostiene Carrère nel suo ultimo libro (Yoga, Adelphi, 2021): che quanto a lui la letteratura è “il luogo in cui non si mente”, da rispettare, sempre per lui (e pochi altri, come il buon J.J. Rousseau: uno dei primi paladini della sincerità e della trasparenza a oltranza, che Alfano smonta con grande acume, sulla scorta di Starobinski), come un “imperativo assoluto”, silenzi e omissioni a parte. Una buona campionatura”, è stata quindi per Alfano indispensabile, da Boccaccio a Shakespeare a Molière a Rousseau a Thomas Mann a Carrère a Cercas, sviluppata in un percorso mai slegato dal contesto di emergenza all’“incrocio tra struttura sociale e struttura narrativa. Tanto più che una fenomenologia si trattava di disegnare, per quanto articolata sull’asse storico, dato che l’“l’impostura [… è sempre] embricata nel suo spazio-tempo”, nelle sue credenze e convenzioni.
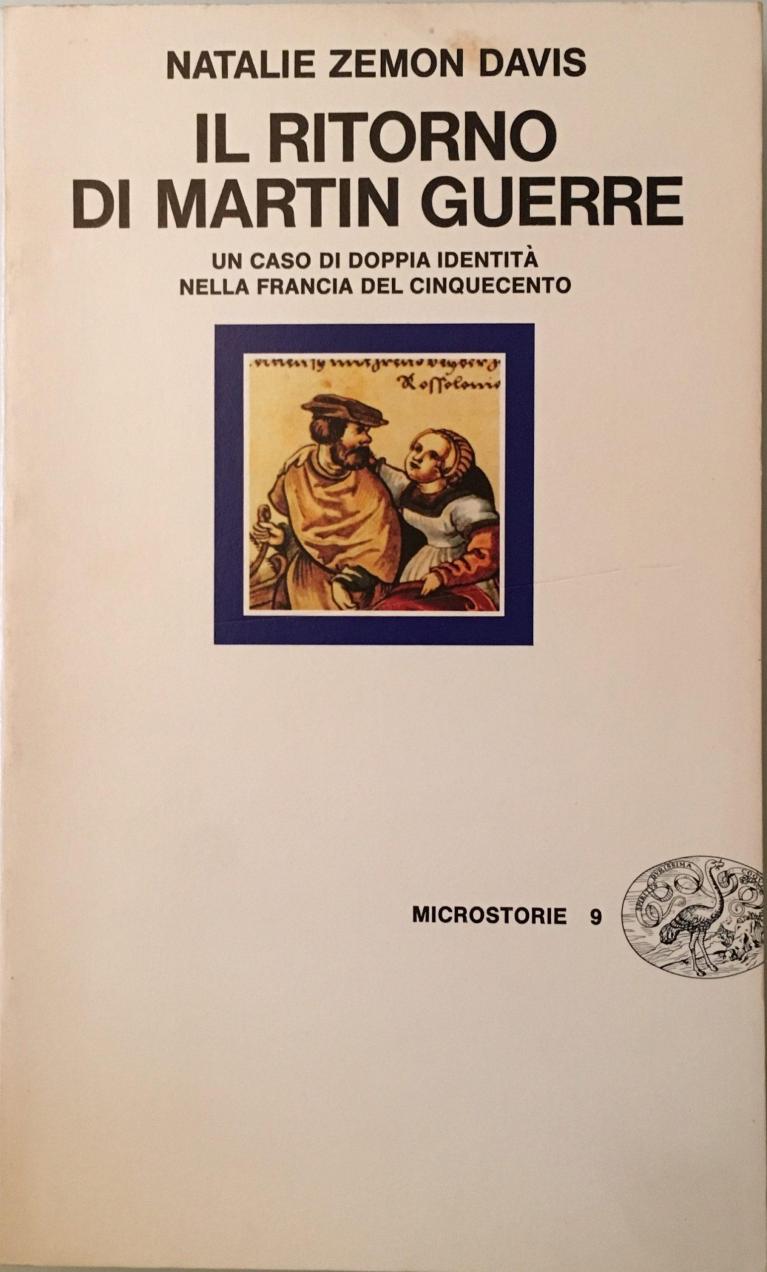
Il libro si apre con la cinquecentesca storia, esemplare e “fondazionale”, di Martin Guerre, sparito da casa un bel giorno e tornato dopo anni tra mille dubbi sulla sua identità, confermata in un primo tempo dalla moglie e da alcuni conoscenti, finché non è comparso un altro Martin, quello vero, che però ha dovuto a sua volta provare di esserlo: una vicenda storica riportata in auge da N. Zemon Davis in un libro ora purtroppo fuori mercato, ripresa e variata da tanti autori anche cinematografici (Il ritorno di Martin Guerre, di Daniel Vigne, e Sommersby, di Jon Amiel), che serve ad Alfano per tracciare un primo perimetro di massima della figura dell’impostore. Poi però, per iniziare davvero il suo percorso storico, Alfano torna indietro di due secoli, a Boccaccio, come aveva fatto anche Guido Almansi nel suo qui non citato Bugiardi. La verità in maschera (Marsilio, 1996), ad analizzare quella che può essere considerata la prima grande figura moderna dell’impostore, quella di Ser Cepparello, nella straordinaria novella che apre il Decameron, e non a caso. Alfano, come farà per tutte le tappe successive di questa sua indagine delle “nascite dell’individuo” moderno, lega l’emergenza di questa figura e le sue prime caratteristiche salienti, a dei grandi cambiamenti avvenuti nel periodo precedente, relativi alla storia culturale e delle mentalità: in questo caso, sulla scorta di Michel Foucault che sarà, accanto a Erving Goffman, uno dei punti di riferimento di molte delle riflessioni successive, all’affermazione della pratica (e teoria) della confessione che favorisce lo sguardo su di sé, una prima mappa dell’interiorità e una prima definizione dell’identità individuale.

L’impostore è uno che si spaccia per un altro e a volte fa di tutto per diventarlo davvero, come il sedicente Martin Guerre, rinunciando in tal modo a se stesso, con una dinamica però complementare a quella di tutti coloro che se stessi cercano di restarlo a dispetto delle circostanze e del tempo mutevoli: entrambi soggetti al divenire e alla metamorfosi, che si affannano attorno a un fine che si sposta con loro come l’orizzonte, quello dell’identità, negata o affermata che sia.
Godendo del vantaggio di un’identità fittizia, l’impostore può sfoggiare la leggerezza del funambolo e l’estro dell’improvvisazione, ma porta anche il peso del ruolo, la gabbia della necessità di adeguarsi all’immagine che lui stesso si è costruito magari con disinvoltura, ma che le sue vittime pian piano consolidano attorno a lui come una prigione sempre più solida e stretta. Da una parte gioca con l’identità, ne evidenzia i limiti e le porosità, la dipendenza dal riconoscimento degli altri, che è manipolabile anche quando si tratta di congiunti prossimi, fungendo così da critica, a volte esplicita ma più spesso implicita, cioè a sua volta mascherata, della sua definizione e importanza soggettiva e sociale: funzionando come un meccanismo di decostruzione insomma che “mostra come noi fabbrichiamo npoi stessi quotidianamente” (C. Arnaud, Qui dit je en nous?, Grasset, 206, cit. da Alfano); ma dall’altro, da questa centralità dell’identità è costretto a dipendere e a erigerla a perno della sua deviazione, restandone così ostaggio, perché per quanto si faccia beffe delle convenzioni sociali che la garantiscono, le deve rispettare per essere riconosciuto nella diversa identità che ha assunto, perché gli altri lo accettino per quello che dice di essere.
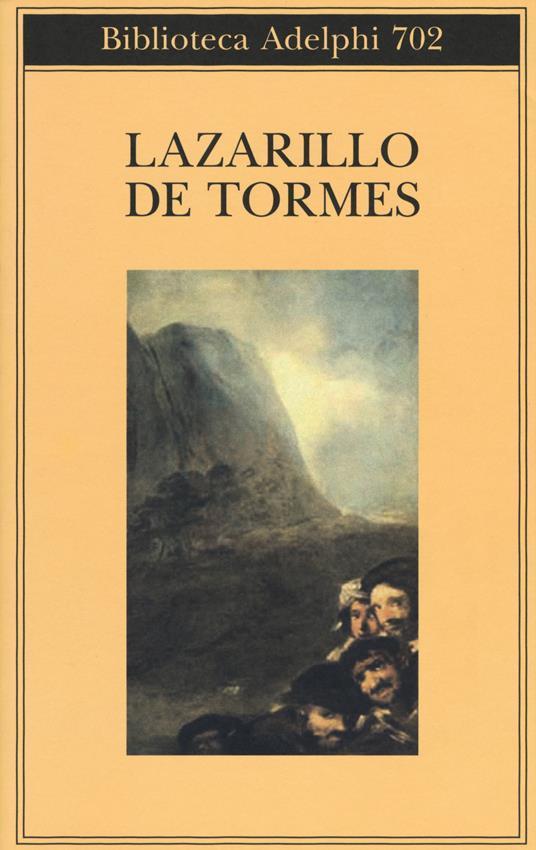
Ancor di più se usurpa un’identità reale, perché deve rispettarne le caratteristiche talvolta fino ai minimi dettagli, che lo imbrigliano, lui che faceva della fluidità il proprio presupposto e metodo, come una rigida corazza, se non addirittura come una vergine di Norimberga, che deve indossare ogni istante per non tradirsi e per non essere smascherato. Denuncia l’identità come recitazione di una parte dettata dalla società, per ritrovarsi costretto a recitarne un’altra di sua invenzione, magari divertente all’inizio, ma alla lunga ben più faticosa, perché sempre sotto forzato controllo, senza possibilità di rilassarsi e di concedersi l’abbandono e la smemoratezza che punteggiano i giorni dei suoi turlupinati interlocutori; mentre se viceversa di identità cambia spesso, diventa succube del cambiamento, schiavo di un’estenuante, interminabile metamorfosi. (anche se in certe sue incarnazioni letterarie viene spesso evidenziato il camaleontico virtuosismo, come nell’impostore trionfante del racconto The confidence-man di Melville preso in esame da Alfano, che “produce innanzitutto credenza: e lo fa esercitando la finzione”).
Non è un lavoro semplice, a volerlo fare bene (a volerlo fare bene, nessun lavoro lo è), ed è per questo che necessita di conoscenze, tirocinio e esercizio costante.
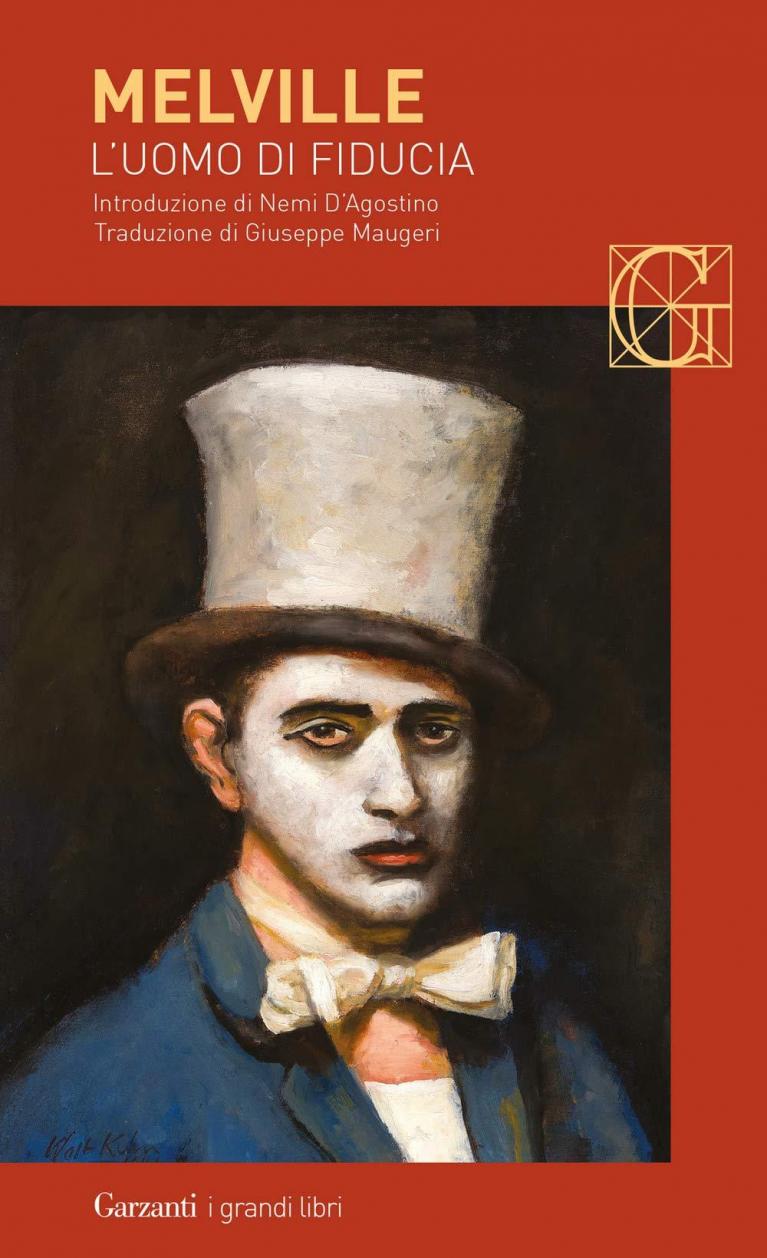
Diventare impostore a tutto tondo, se così si può dire, e non in modo episodico, è un’arte (l’“ottava arte”, la chiama a più riprese Alfano), che richiede competenze e persino una scuola, a qualsiasi livello sociale la si voglia esercitare. E così Alfano, rifacendosi alla straordinaria raccolta di testi e documenti curata in modo mirabile da Piero Camporesi, Il libro dei vagabondi, (Einaudi, 1973), prima si sofferma sulla “scuola dell’impostura” dei simulatori e truffatori medievali che è facile immaginare dura e selettiva, e sull’esperienza sempre precaria del picaro che ha avuto la sua più alta incarnazione in Lazarillo de Tormes (Adelphi, 2019), anche perché ne va della libera sopravvivenza; ma non dimentica poi anche i ceti superiori, che quasi nello stesso periodo, per districarsi nella vita di corte sempre più rigida e ricca di competizione e trabocchetti, trovano nel capolavoro di Baldassar Castiglione, Il Libro del Cortegiano, una bibbia che verrà studiata in tutta Europa da generazioni di nobili e di funzionari, con i suoi “aggiornamenti” apportati dai manuali gesuiti e secenteschi sulla “dissimulazione onesta”. Si tratta sempre e comunque di subordinati, tuttavia, sia che si arrabattino ai margini della società, sia che ambiscano a scalarne i vertici, perché anche qui l’impostura nasce da uno stato di inferiorità e di bisogno (fosse pure quello “affettivo”, di Otello); l’impostore non è mai chi sta veramente in alto, ma chi aspira a innalzarsi: chi cerca di giocare le regole perché non le può dettare; chi rischia di aggirare la legge perché qualcuno l’ha già in pugno. Per questo bisogna armarsi.
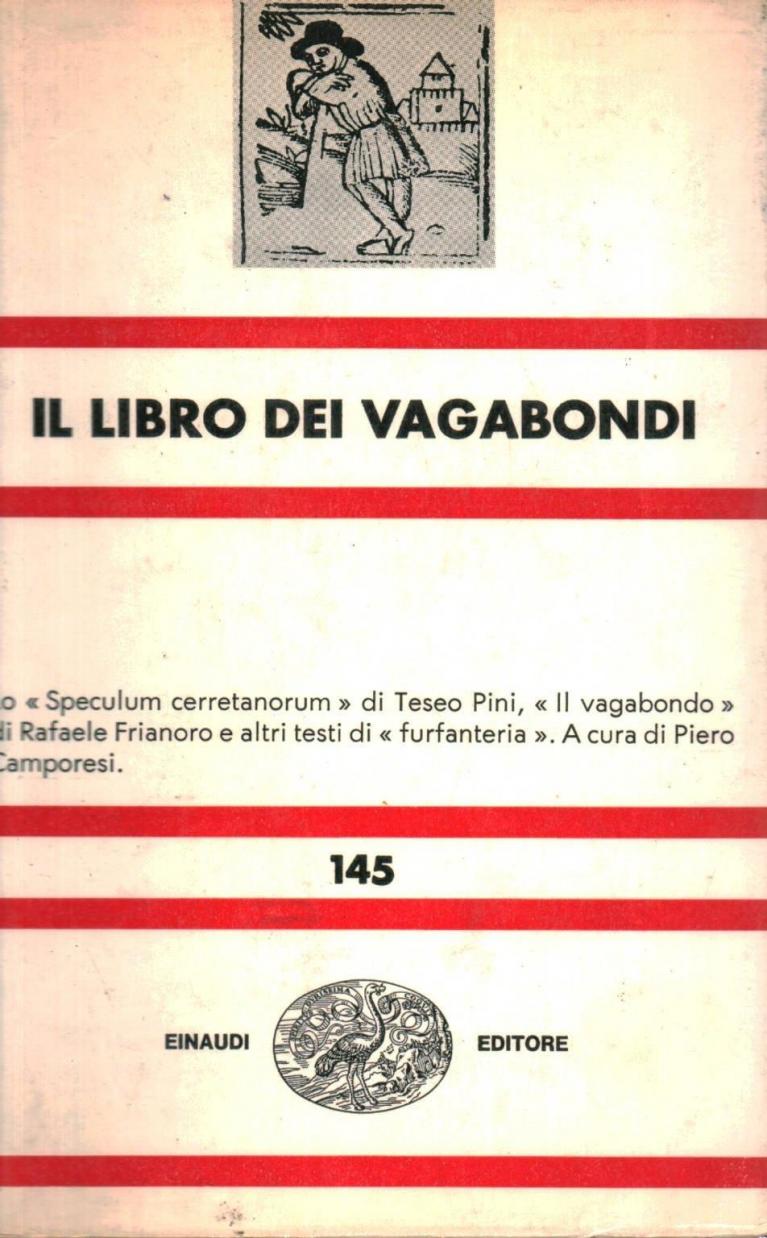
L’imbroglione “naturale”, il burlone per qualità innate o per bonarietà di carattere, non va molto lontano se non affina doti e capacità di osservazione con studio e esercizio. Il fenotipo spontaneo resta chiuso in una dimensione circoscritta, domestica o locale; improvvisato e di bassa lega, è destinato a un veloce smascheramento e vituperio, alla ritorsione della derisione sulla sua persona e alla condanna. Il suo repertorio non si discosta mai, in fondo, dalle piccole furbizie quotidiane che sono l’appannaggio, il parco giochi e la riserva indiana, dell’uomo comune (ma anche a volte la sua ultima risorsa) che, truffando i suoi simili e venendone incessantemente truffato, finisce forse per contribuire alla redazione di una brillantissima enciclopedia della miseria, di cui però saranno gli altri a godere. Il professionista e l’artista invece, come ci insegnano tante storie inventate (orali, scritte, rappresentate e filmate) e reali, sono ammirati e spesso la fanno franca in misura del loro successo, perché più questo cresce più essi sono in grado di cambiare le regole e di imporre le proprie, o quanto meno di piegare a proprio vantaggio quelle vigenti, con il plauso delle folle. Doppio salto mortale con atterraggio in piedi. Viva il comandante! Viva il presidente! (Poi verranno smascherati e puniti, si sa, presto o tardi, per la buona pace delle coscienze sensibili; quasi sempre.)
Quello che si impara, comunque, tra i secoli XVI e XVIII, è a difendersi, a conoscere se stessi e gli altri, introiettandoli e insieme proiettando l’immagine di sé che pensa che loro si aspettino: è in questo periodo infatti che, assieme a quello dell’individuo moderno si ha “l’atto di nascita dell’impostore”, secondo le parole di Valentin Groebner citato da Alfano. Questa duplice azione apre lo spazio a una nuova dimensione dove ritagliarsi uno spazio proprio, quello della propria interiorità come ultimo baluardo di difesa dall’invasione, più ancora che dall’invadenza degli altri. Baluardo sempre più fragile man mano che ci avviciniamo ai nostri giorni, come è noto. Finto baluardo. Ennesima impostura.
Quello dell’impostore è un doppio movimento, di potere e di difesa. Difesa dagli altri impostori (da tutti gli altri, che lo sono perlopiù senza saperlo, al riparo dei ruoli sociali che ne garantiscono la legittimità e accettabilità), che diventa sopraffazione (sui pochi o i tanti, a seconda di capacità, opportunità e ambiente di azione: forza, comunque; potere).
D’altra parte è impossibile non essere impostori davanti a se stessi, prima ancora che davanti agli altri, perché per non mentire bisognerebbe conoscere la verità. Ma quale? Il problema, che acquista sempre maggior rilievo negli ultimi due secoli, sta qui: di quale verità parlo e di quale me stesso parlo, quando parlo di verità? A rigore non si dovrebbe parlare nemmeno di menzogna, allora… Si tratta di verità relative a questo o quel nostro ritenerci noi stessi, rispetto a ciò che sappiamo o ignoriamo, e al tempo, al ricordo o alla rimozione o all’omissione eccetera. Parole.
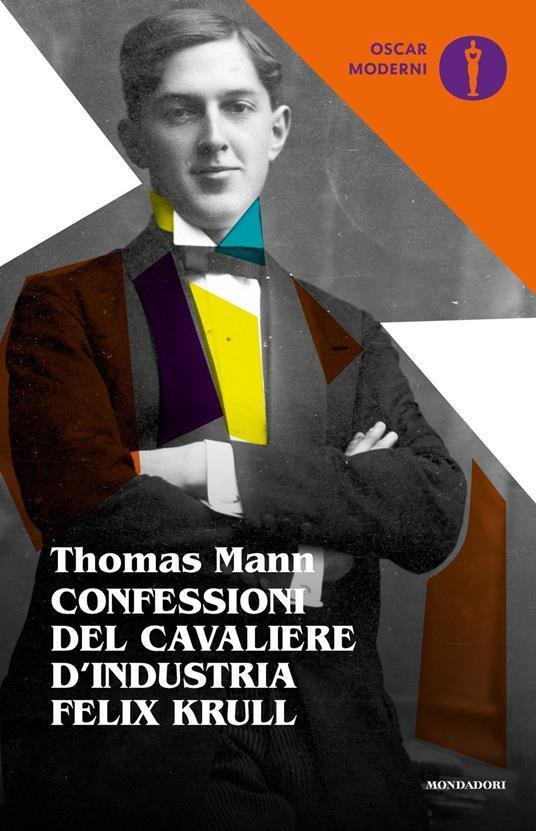
Mento, indosso (assumo, faccio mia) una maschera, che è mia sempre al posto di altre, non perché la voglio assumere ma perché non posso evitare di farlo sin dal primo momento in cui sono guardato; ancor prima di sapere di essere guardato, e anche prima di sapere che quello che mi guarda sono io (come insegnano Freud, Lacan, Pirandello, Pessoa, Goffman, zio Giacomo, l’amico Witold…).
Il discrimine tra l’impostore “vero” e l’uomo comune sarebbe allora l’assunzione volontaria di un ruolo e una maschera che non corrispondono a quelli che i parametri socio-culturali vigenti esigerebbero nei comportamenti pubblici e riguardo alle aspettative personali, cioè a ciò che un individuo è indotto a esigere da se stesso.
Far coincidere il soggetto da truffare con se stesso svelandogli le sue caratteristiche, più che nascondendo la propria identità, cioè l’opposto di quanto avveniva nell’antico regime, è la nuova strategia dell’impostore nell’epoca del capitalismo, il quale, confermando “ciò in cui i suoi interlocutori credono” conferma anche la loro identità soggettiva, come fa l’“uomo di fiducia” dell’omonimo racconto di Melville.
Solo la condivisione di qualcosa di esterno (consuetudine, legge, regole ...) permette di fissarsi per un po’, e per un certo numero di soggetti, in un’identità ritenuta vera e autentica. Subito, però, riparte il ritornello dell’altro che ci soggioga e inganna, della necessaria riservatezza, del segreto che dovrebbe appartenerci e fondarci in quanto individui separati che sanno chi sono e si ritagliano uno spazio inaccessibile e invisibile per non essere presi nella rete e ingannati. Ma questa invisibilità è anche la nostra condanna.
Allo stesso modo, anche chi di noi che per affermarsi in quanto individuo si rifugia nella propria interiorità e la scandaglia fino a attingere una piena trasparenza e a coincidere con se stesso senza distanza né differenza, alla fine si ritrova così prossimo a sé che non (si) vede più niente. Così al buio che brancola e afferra il primo sostegno che capita, per orientarsi, per non perdersi o cadere. La sua sicurezza si ribalta in esposizione e fragilità. La sua indipendenza in assoluta dipendenza. Ed è proprio allora che arriva a soccorrerlo, a soccorrerci, con il volto aperto e suadente così simile al nostro, l’impostore.
A meno che, sull’esempio dell’impostore ma senza la volontà di ingannare, anche noi non ci adattiamo alla continua, incerta, euforica ma anche faticosa e ansiogena, altalenante, metamorfosi dei ruoli che rappresentiamo di fronte a noi stessi e agli altri, lasciandoci alle spalle, come una pelle di serpente, benigno o maligno si vedrà, le nostre pretese di identità e trasparenza, di sapere chi e cosa siamo e di tenerlo fermo, accada quel che accada.









