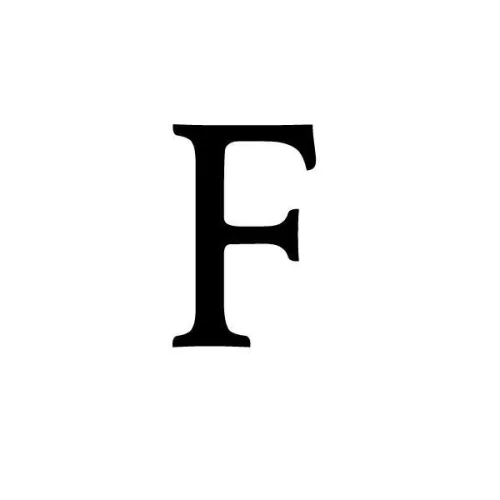Speciale
Crinale tosco-emiliano / Fnide
(Kaputt)
Fnide, nel mio dialetto, sta apparentemente per finito, terminato, con una minima differenza grafica e fonetica rispetto all’italiano.
Sul crinale tosco emiliano lato Emilia, esposizione nord verso la Pianura Padana: a mille metri d’altezza un paese che fino agli anni del boom economico era indietro di cinquant’anni.
In quegli anni, tra le conseguenze non cercate delle lunghe vacanze estive ogni anno c’era l’incontro con un altro mondo e un’altra pagina della storia. In quegli anni, lontano dai luccichii della città, incredibilmente si potevano avvertire i sentori profondi dell’epoca preindustriale.
Fnide è parola che sarebbe sbagliato ridurre semplicemente all’aggettivo finito, terminato; in realtà il suo significato va altrove.
Una sera ricordo l’espressione pronunciata da mio padre quando, con una pietà conclusiva, riassumeva a mia madre l’incontro inaspettato con un amico ammalato: “l’homme l’è fnide...”.
È più o meno quello che Primo Levi ci racconta nel quarto capitolo di Se questo è un uomo, quando un internato lo apostrofa con “Du Jude kaputt. Du schnell Krematorium fertig (Tu ebreo spacciato. Tu presto crematorio, finito”). Oppure nel decimo capitolo quando il kapò Alex lo introduce verso il Dottor Pannwitz, che lo avrebbe esaminato sulle sue conoscenze di chimica: “…un italiano in Lager da tre mesi soltanto già mezzo kaputt”.
Sì, in questo significato fnide è molto vicino alla parola tedesca kaputt la cui etimologia Curzio Malaparte racconta (nel libro omonimo) in una conversazione con la principessa tedesca Louise von Hohenzollern:
“Lei conosce l'origine della parola kaputt? È una parola che proviene dall'ebraico koppâroth, che vuol dire vittima... Il destino del popolo tedesco è di trasformarsi in koppâroth, in vittima, in kaputt”.
Ma la parola fnide oggi può raccontare anche qualcosa di molto diverso, più vicino alla concretezza dei nostri giorni, alla nostra economia, al mondo dei consumi in cui siamo avvolti. Quel mondo che la crisi susseguente all’epidemia di Covid 19 forse ci ha fatto finalmente percepire in modo differente in tutte le sue fragilità. Lo abbiamo percepito non come analisi razionale, non come educazione all’ambiente, ma avvertendolo nella pancia, sulla pelle.
Fnide è la parola che meglio può sostituire un’altra che nel mio dialetto non esiste e che in italiano suona come rifiuto. Non c’è perché semplicemente non era prevista una realtà qualsiasi che potesse diventare rifiuto, non esisteva come realtà, non ne esisteva il concetto e con questo la necessità di dargli un nome.
L’economia circolare lassù era espressione sconosciuta, tantomeno paradigma teorico con cui costruire un modello di sviluppo sostenibile. Fino agli anni del boom economico, l’economia circolare era semplicemente l’unico orizzonte esistenziale praticato, era scelta culturale “innata”.
Quando qualcosa – un attrezzo di legno, un tessuto, uno scarto agrario o alimentare – l’era fnide, quel qualcosa non diventava mai rifiuto perché non poteva diventarlo. Due le possibilità: o veniva bruciato come combustibile, oppure interrato come futuro concime; ancora un’utilità, per se stessi o per chi sarebbe venuto.
Fnide – e non rifiuto – presupponeva perciò anche il restare in qualche modo nel circolo perenne della vita, in coerenza con la seconda legge della termodinamica – quella per cui in un sistema isolato il lavoro utile avviene solo lungo il decadimento dell’energia, fino alla fine.
Così era nella sostanza, anche se nessuno in quegli anni e su quei monti aveva mai sentito parlare di economia circolare, di sviluppo sostenibile, né tantomeno di termodinamica.