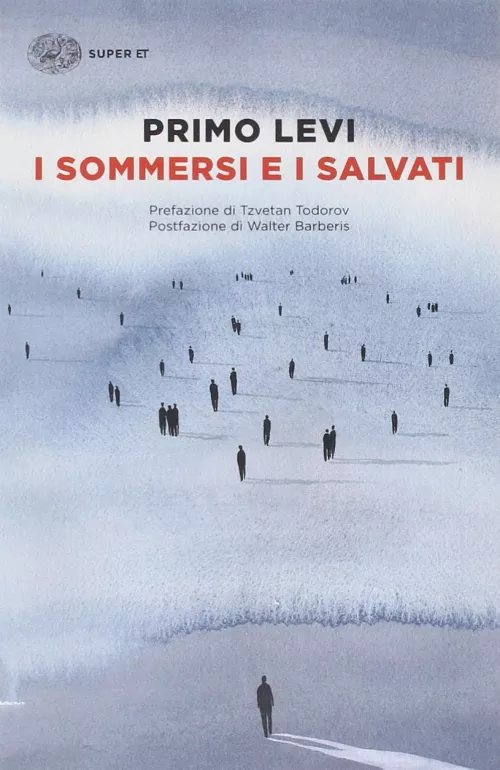Frammento d'aria
L’espressione “ritornare in patria” suona agli orecchi degli italiani altisonante e forse anche sotto una veste un po’ ironica; in fondo il termine “patria” non denota niente di effettivo, rimane un termine astratto, fuori dal linguaggio comunemente parlato. Per gli italiani, ormai lo sappiamo, i padri è come se non ci fossero mai stati, sicuramente non c’erano più negli anni ottanta quando Primo Levi scriveva I sommersi e i salvati, non ci sono certo oggi nel momento in cui usare anche espressioni come “andare all’estero” risuona del tutto arcaico, fuori tempo, quasi imbarazzante per chi ha l’occasione di ascoltarlo.
Negli anni trenta però era tutto diverso e a testimoniarlo sono proprio gli ebrei. Di fronte alla minaccia hitleriana la maggior parte di loro decise di rimanere tra i confini di quella parte di terra dove sentivano di essere nati, convinti che fosse la cosa più giusta da fare. Di fronte a questa constatazione non si può non rimanere ogni volta sconcertati. Non si può infatti rinunciare a chiedersi perché non abbiano assecondato il loro essere il popolo del libro, un popolo capace di errare, di disperdersi nel ricordo di un Tempio ormai definitivamente distrutto. Invece sono rimasti lì, a morire, e non certo per la patria, a morire e basta.
Il motivo per cui Primo Levi afferma che il termine patria non ha equivalenti nelle altre lingue non è del tutto chiaro. Se rimaniamo ad esempio nel cuore di quegli anni trenta, in Germania, il termine patria, Vaterland, si distingue dall’italiano unicamente perché usa i nomi di padre e di terra componendoli tra di loro, riferimenti che invece il termine italiano lascia solo sottendere per sovrapposizione tra l’origine etimologica greca e quella latina. Al contrario Primo Levi è molto chiaro nel sottolineare come gli ebrei rimasero nella terra che pensavano fosse quella dei padri non solo perché vi erano nati, ne parlavano la lingua, ne avevano adottato i costumi e la cultura, ne pagavano i tributi e osservavano le leggi, vi rimanevano prima di tutto perché per quella terra avevano combattuto. Gli amici e i parenti sepolti nei cimiteri di guerra ne erano l’evidente testimonianza. Così, se si doveva morire, lo si doveva fare in patria, era soltanto rimanendo al proprio posto che ognuno avrebbe dichiarato la propria disponibilità a morire per la patria. Certo, erano espressioni in ossequio alla retorica corrente, ma non solo; la terra dei padri chiama effettivamente a sé la morte, il sacrificio della vita per dare vita. Il seme del padre feconda rendendo il padre assente allo stesso atto generativo di cui è parte. Per questo il padre non ha scelta, deve limitarsi ad attendere la restituzione che quell’atto di privazione di sé impone, non può che farsi il centro vuoto di una legge retributiva. Ecco perché, sebbene si sia chiamati a morire per la madre patria, è in nome dell’incombere della presenza fantasmatica del padre che si definisce la vera potenza del nomos della terra.
Il popolo ebraico incarna esattamente l’ossimoro di questo tratto comune della storia umana. Gli ebrei, pur avendo perduto la terra, hanno mantenuto presente il fantasma del padre e hanno pensato di conseguenza che ogni terra potesse diventare anche la terra del padre. È sulla base di quest’atto di fiducia che sono stati spietatamente sterminati. Sterminati privandoli proprio della loro morte, di quella morte per il padre che lascia sempre in eredità una terra, almeno quella all’interno della quale poter essere seppelliti. Loro invece sono stati bruciati via, spazzati via come se sulla scena della storia non fossero mai apparsi. La shoah è stata così anche la rivelazione del profondo inganno che soggiace al legame costitutivo tra il padre e la terra, legame che decreta il sacrificio come qualcosa d’inevitabile: per i figli non ci può essere alcuna salvezza. Nessun angelo arriverà a salvare Isacco dal pugnale sollevato dalla mano del padre. Combattere e morire per la terra del padre si rivela ogni volta ineluttabile: unica vera eredità.
La parola Vaterland d’altronde è un termine neutro. Il legame tra il padre e la terra è ciò che in nome della sopravvivenza di un concreto spazio di vita neutralizza la vita. Eppure la lingua tedesca per dire patria presenta anche il termine femminile di Heimat. Un termine intraducibile che si lascia attraversare da dinamiche affettive, concettualmente inafferrabili, ma i cui effetti possono essere accolti proprio in dissonanza con quel legame costitutivo tra padre e terra che la parola Vaterland esprime. Dissonanza che forse possiamo ugualmente trovare in quella sovrapposizione che i termini terra e padre mantengono anche nella parola italiana, se riusciamo a percepire come tra il padre e la terra vi sia un frammezzo d’aria che non li fa mai combaciare perfettamente. In questo modo scorgeremmo una vitalità inaspettata proprio nella componente astratta che Primo Levi riconosce criticamente alla parola “patria”. Se così fosse potrebbe allora essere proprio tale termine a far risuonare la necessaria frattura tra nomos e terra. Per la madre patria non saremmo più chiamati solo a morire, quanto piuttosto a vivere, a mantenere vivo il desiderio della vita. Scopriremmo che il legame con la patria non risiede principalmente nel rapporto tra il padre e la terra, ma in quello tra la madre e l’aria. E forse anche noi italiani potremmo imparare ad amare la patria, chiamarla ad alta voce, sentirla finalmente nostra e al contempo guardarla perdersi nell’aria.