I fantasmi nella notte di Danilo Kiš
A distanza di oltre dieci anni dalla pubblicazione di Homo poeticus. Saggi e interviste (Adelphi, 2009), il lettore italiano può tornare a rileggere il fiero e sovversivo Danilo Kiš grazie a due nuovi libri: Poesie (a cura di Margherita Carbonaro e Slavo Serc, Edizioni Finis Terrae 2022), e L’ultimo bastione del buon senso (a cura di Federica Arnoldi, Luca Mignola e Alfredo Zucchi, con traduzione di Anita Vuco, Ostranenie, Wojtek edizioni 2022). Un libro di poesie e un libro di saggi che re-illuminano, a scorci, la figura dell’autore serbo (Subotica 1935 – Parigi 1989), uno degli scrittori più potenti e rivoluzionari della seconda metà del secolo scorso, che dal lucido rifiuto dei regimi totalitari e dall’empatia commossa per i destini delle vittime costruisce la scrittura come forma di superbo scongiuro della morte: «La realtà è l’erba che cresce e i piedi che la calpestano» (LC, p. 78), ma anche come forma di domanda infantile e imperdonabile: «Signore, mi saprebbe dire dov’è la strada degli ippocastani? Non ne sa niente?» (DP, p. 13).
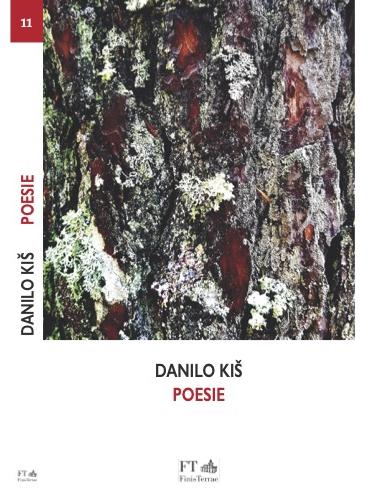
Poesie
Il corpus poetico di Danilo Kiš comprende soltanto trentacinque testi. Tredici di questi rimasero inediti durante la vita dell’autore; i restanti furono pubblicati su riviste come «Susreti», «Književne novine», «Vidici». La maggior parte delle poesie fu scritta fra il 1953 e il 1966. Ma Kiš tornò regolarmente, anche se sporadicamente, alla scrittura in versi, fino agli ultimi anni di vita.
Dalle poesie emerge un universo reale/surreale dove le analogie, innescando metafore a grappolo, sono una scheggia scagliata nell’ingranaggio dell’immaginazione, come accade in questi versi di Immondezzaio: «Rose / rose meravigliosamente intonate all’immondezzaio come alla poesia / rose che cominciano a puzzare come persone / rose su cui si posano le mosche / rose che le mani umide di una fiorista hanno avvolto in carta sottile e frusciante / rose in vasi di cristallo come pesci rossi... ».
L’intento principale di Kiš è sfuggire all’ovvietà dei principi, storici e filosofici, grazie alla potenza della parola, tenendosi ben lontano da quella che lui chiama “terrificante coerenza”. Rileggiamo Natura morta con pesce: «Radiografia di una candela: coste di animale. / Candelabro: argentea cattedrale. // Buccia profumata, giallo di un limone. / Salato a morte spira uno storione //. Sulla porcellana fegato sanguinante. / Un bianco piatto sbadigliante. // Come liquido caucciù cola il formaggio. / Di mele scarlatte biblico miraggio. // La stanza-sosia nello specchio ondeggia. // Una falena la fiamma della candela corteggia». Qui, beffarda ironia e perfezione formale costruiscono una vanitas tagliente come una lama, suggestiva per i suoi funerei riflessi. “La stanza-sosia nello specchio ondeggia” appare, in modo evidente, come una dichiarazione di poetica: la scrittura è rifrazione e somiglianza ma sempre dentro un universo che ondeggia, increspato come un mare che non offre appigli sicuri. Essere poeta, per Kiš, è non fare e non chiedere favori: è mettersi di traverso, come pietra d’inciampo. Dire poeticamente contro il mondo infame, finché la verità arriva a straziarlo, e a straziare anche se stessi.
Datata pochi mesi prima della sua morte, ecco l’ultima poesia: «Alla notizia della morte della signora M. T. Che lavoro ben fatto, Morte, che successo, / abbattere una simile fortezza! / Divorare tanta carne, / triturare tante ossa / in così poco tempo. / Impiegare tanta energia, / in fretta, lo spazio di una sigaretta. / Che lavoro è stato per te, Morte, / che dimostrazione di forza. / Come se non ti avessimo preso / in parola.)». L’autore non rinuncia, neppure alle soglie della sua vita terrena, alla sua essenza beffarda. Per Kiš il tragico è sempre anche tragicomico, grottesco. Le poesie, oggi raccolte in questo unico volume, tradotte da Carbonaro e Serc grazie anche ai suggerimenti di Domenico Brancale e Anna Ruchat, lo svelano con sconcertante, ingenua chiarezza.
Se è evidente che il “genere poetico” non è la misura ideale per il talento narrativo e barocco di Kiš, è altrettanto vero che che lo scrittore serbo è e sarà poeta fino alla radice del suo essere: «In effetti la poesia, la letteratura (e metto il segno di uguale fra queste due parole, come faceva Pasternàk) sono, per noi e per voi allo stesso modo, i nostri sogni barbari e i vostri sogni, i nostri amori e i vostri amori, i nostri ricordi e i vostri, il nostro quotidiano e il vostro, la nostra infanzia infelice e la vostra (anche quella infelice), la nostra ossessione di morte e la vostra (identica, spero)» HP, p.16).
In una delle poesie più asciutte e descrittive, Barattoli, la sua ossessione di morte appare definitiva, congelata nella “natura morta” di una prosa poetica da cui è assente ogni ritorno alla vita: «Bossoli /sparati verso il sole / verso il tramonto // Conchiglie gettate / che la pioggia erode //pesci puzzolenti / con cuori di limone // Tutto questo / pelle e ossa / sarà mangiato via dall’erba // l’erba è avida / soprattutto sulle tombe e sui / letamai». Una delle caratteristiche più evidenti della sua poesia è l’attenzione alla trasfigurazione in oggetti, sentimenti, persone. In Poesia scrive: «Preso d’amore, come gli altri, tutto / il mio unico, incommensurabile Io //, ma per strada mi sorprenderà il lutto / che un giorno tutti porterà all’oblio. // Quando lo slancio folle della giovinezza / si trasformerà in nuda (nuda) amarezza // e intorno nessun tetto o veggenza, solo quel che porti della tua esistenza».
Da questi versi, che come altri evocano l’amore e il lutto dell’amore, emerge un’immagine: “nessun tetto o veggenza”: lo scrittore non cerca né la consolazione di un nido protettivo né quella di una fantasia mistica. Per lui conta soltanto il presente, in questo caso il dolore che lo strazia. Kiš, in sostanza, non cerca nella poesia liriche indeterminatezze ma certezze etiche raffigurate per immagini paradossali: «anche se la poesia forse non “nobilita i sensi”, è comunque utile: dà un senso alla vanità dell’esistenza» (HP, p.16).
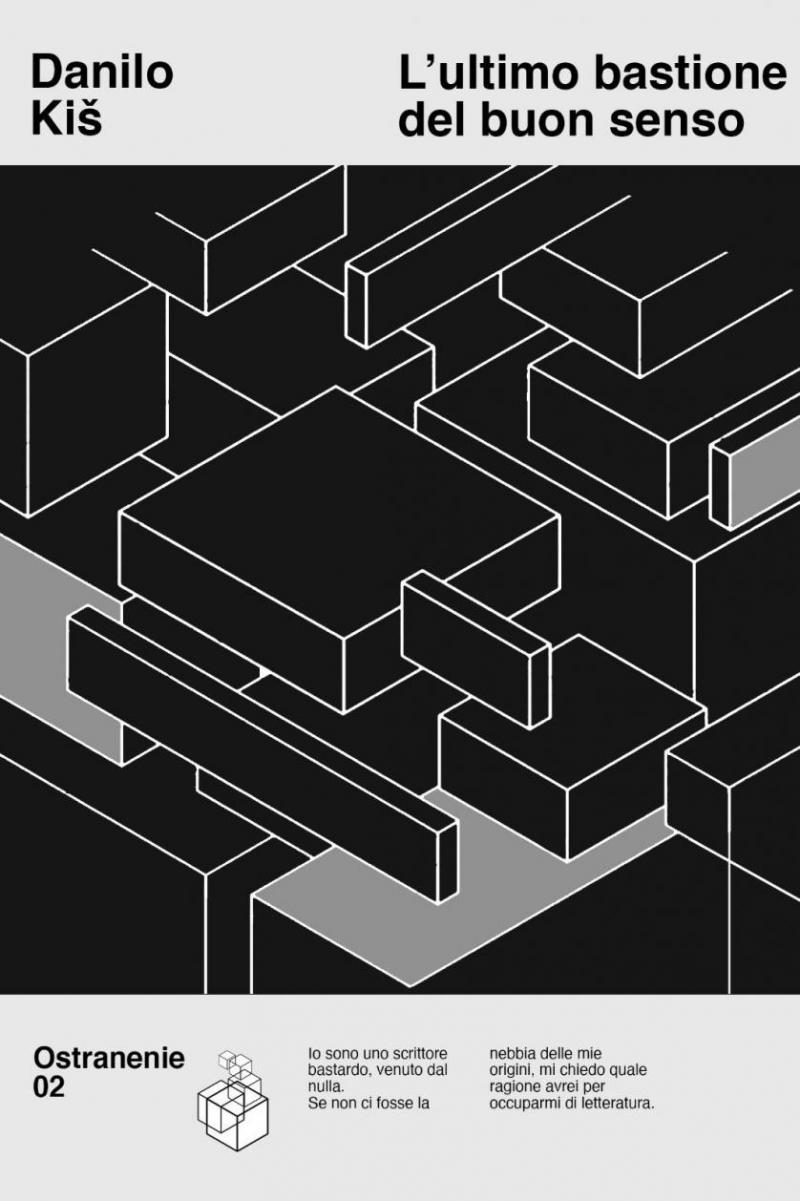
L’ultimo bastione del buon senso
Il libro si compone di tre sezioni diverse: “Saggi”, “Discorsi”, “Dal Magazzino”. La voce dell’autore, come scrivono i curatori, “oscilla costantemente tra testimonianza privata, invenzione e riflessione teorica”, come accade quasi sempre nella sua opera, dove la strategia tecnica si accompagna alla posizione etica del soggetto di fronte alla Storia. L’ultimo bastione del buon senso (Ostranenie, Wojtek, Pomigliano d'Arco 2022) è una miscellanea di saggi giovanili (ma non solo) e di pungenti ritratti critici dove è piacevole ritrovare, all’interno di uno scritto letterario o di un polemico pamphlet, posizioni che saranno poi assunte con fiera determinazione dall’autore di Enciclopedia dei morti e Giardino, cenere.
«Chi sono? Una persona che osserva, non abbiatene a male. Osservo ciò che si può vedere a occhio nudo, e che tuttavia le persone stentano a vedere... E osservo parecchie cose, a volte con stupore. Vedo, ad esempio, come un’intera nazione di scrittori si lasci ingannare. Come i surrealisti, ai loro tempi, divennero cantori molto realisti di Stalin, proprio loro, gli esploratori dell’universo dell’inconscio, dei sogni! E osservo come anche colui che ha accusato i chierici di tradimento ha tradito a sua volta. Quante persone hanno preso questa scorciatoia intellettuale, senza dire una parola, come San Sartre, Santa Simone e compagnia bella. Senza prudenza intellettuale. Osservo anche come chi aveva ragione – Camus – non ha ottenuto né ragione né soddisfazione, perché sapeva e perché ha detto le cose al momento sbagliato. Questa mancanza di cautela, questa ingenuità, lo ammetto, supera la mia comprensione. L’accettazione senza mea culpa» (UBBS, p.18).
Kiš non potrebbe essere più chiaro nel ribadire con fermezza la propria posizione di osservatore non neutro ma inconciliato, nel suo fiutare le verità delle cose e degli uomini nel flusso torbido della Storia. La letteratura non è mai lasciata “tranquilla” dallo scrittore serbo: gli è necessario sommuoverla, turbarla e ri-trovare nel passato le radici che rendono necessario il presente come ossessione di rivolta permanente. Parlando di Baudelaire, osserva: «...Sotto la sua influenza diretta farà sbocciare il genio fulmineo del giovane Rimbaud; libererà Verlaine dai giardini di marmo parnassiani, contribuendo alla sua evoluzione verso la sensualità sottile e verso il misticismo poetico; condurrà Mallarmé nella sfera della poesia pura e del soprannaturale; dalla sua opera, se non da un’unica poesia, si svilupperà una scuola di rinnovata sensibilità – il simbolismo – così come molti altri movimenti e poeti, fino ad arrivare al surrealismo e alle pagine di Henri Michaux.
Come dice Valéry, l’opera di Baudelaire forse non avrebbe esercitato una così forte influenza sulla storia della poesia se si fosse limitata a I fiori del male… Ma la poesia di Baudelaire è circondata e accompagnata, suffragata da un insieme di opere teoriche, di ricerche estetiche e formali, di materiale esemplificativo, di interrogativi che rappresentano i percorsi più profondi e raffinati che la poesia abbia mai intrapreso, proprio come sostiene Valéry». (UBBS, pp 46-47).
Le coeur mis à nu di Baudelaire è la via necessaria della letteratura, per Danilo Kiš. Sincera è la sua ammirazione per scrittori mitici e bizzarri, come Nabokov e Borges, ma è un’ammirazione “critica”, non scevra da un certo scetticismo. Kiš preferisce, agli stratagemmi borgesiani (che peraltro lo intrigano e che userà nelle sue narrazioni), la romantica esistenza dello scrittore-testimone. «Perché cos’altro sarebbe uno scrittore oggi, che cosa sono io, se non un cavaliere errante, un vagabondo dotato di una fantasia sfrenata, un lettore appassionato, un uomo che, anche a costo di risultare ridicolo, è al servizio dell’ideale della giustizia?» (UBBS, p. 89).
Mezza cosa da dire
Essere scrittore, per Danilo Kiš, in poesia come in prosa, non è essere un professionista della letteratura ma un “poeta” che sigilla i propri temi con luttuosa fierezza. «Questo binario morto, ripeto, uccise le nostre ultime illusioni» (GC, p.55); «Giacevano nel profondo sonno dei morti» (EM, p.95). Un vero scrittore si occupa esclusivamente di tematiche ossessive, in una specie di trance poetica: stabilisce analogie nuove, reinventa polifonie, medita un libro che obbedisca alle leggi del caso e a quelle dell’ordine, pur consapevole di fallire. «Fallire ancora e fallire meglio» ci insegna Beckett.
Per Kiš essere scrittore significa elaborare con strategie originali la propria rovina/follia, e adeguarsi costruendo il personale “infinito” della sua scrittura. «Ma quello che mi atterriva (la consapevolezza non genera consolazione) e accresce ancor più il mio tremito interiore, era la coscienza che la mia follia era in fondo lucidità e che per guarire – perché questo tremito continuo è cosa insopportabile – avevo bisogno proprio della follia, della demenza, dell’oblio» (CL, p.156). Essere adeguati alla propria lucidità è fare ciò che a noi, proprio e solo a noi, è consentito fare.
Ogni artista non ha molte cose da dire: forse ne ha una, e talvolta mezza. Ma deve sapere tutto di questa mezza cosa, di questo mezzo tono. Deve diventare maestro di cerimonia di quell’unico segreto di cui è messaggero. Dopo, si tratta di inezie: tecniche, scritture, variazioni, messe a punto. Ma il tema è stato dato. La litania è quella. E poi, che nessuno la ascolti o che tutti la applaudano: non cambia e non cambierà nulla.
«Dedicare tutta la vita a due-tre magnifici libri (parlo, ovviamente, di Joyce) a costo di privazioni e di incomprensioni, nel desiderio di restituire dignità alla letteratura, con l’intento di liberarla da ogni schema e da ogni visione banale, e di elevare l’intera vita umana, materiale e morale, fisica e metafisica, al livello di una realtà parallela – parallela, quindi in concorrenza rispetto a quella empirica – in ciò risiede lo sforzo gigantesco compiuto da Joyce, più importante come tentativo che come risultato. Eppure, Joyce ha affrontato questo progetto (intendo soprattutto l’Ulisse) pienamente consapevole del fatto che il palinsesto non può essere cancellato dalla pergamena: mezzo cieco, continuava a vedere tutti gli strati e non gli restava altra scelta che accettarlo e, alla fine, fare di esso, consapevolmente, lo sfondo, la base su cui scrivere: il concetto omerico è rimasto sotto la densa scrittura joyciana, visibile e presente; efficace» (UBBS, p.113).
Ma la scrittura non è anche brulichio pericoloso, vertigine, odore, ferita, una prosa che comincia là dove il messaggio finisce di esistere, diventando enigma poetico?
«Quando non c’è la luna, nella giungla il buio è più fitto che in ogni altro posto della terra. Regna un’oscurità assoluta. Non si vede una stella. Anche di giorno non sempre si vede il sole. Eppure sotto le volte delle liane e del fogliame vivono molte specie animali che non si trovano in nessun’altra parte del nostro pianeta. Di notte c’è silenzio nella giungla. Eppure brulica la vita. Funeste scintille rossastre, verdi, gialle lampeggiano incessantemente nell’oscurità assoluta. Di notte inizia il tempo delle zanne e degli artigli. Il tempo delle tragedie». (PK p.71)
Le tenebre “traversate da funeste scintille” e la notte come “tempo delle tragedie” sono l’essenza del suo complesso pensiero immaginale. La “notte” è la psicosi, i lager, i massacri, i soprusi, i delitti pubblici e privati. Le “scintille” sono la confusa e imperfetta libertà che di quella notte viene a capo con i soprassalti delle sue verità. L’io, da sempre in stato di trance, cataloga le disintegrazioni, ripudia i sette giorni canonici della creazione, inventa nuove cosmogenesi della memoria. Se Rimbaud diceva di strappare per pochi lettori insonni i suoi taccuini di dannato, Kiš non è da meno.
Se essere scrittore è violare un potere che costringe al silenzio e popolare la mente di fantasmi resuscitati dall’oblio, se scrivere è nutrire i vivi ri-emersi con l’energia inesauribile dei morti sommersi, allora Danilo Kiš vìola ogni potere con le onde della sua prosa, fluttuante tra memorie, visioni, lampi, flussi, ceneri, sogni. «A un altro livello dello stesso sogno, fuggivo rosso di vergogna e non riuscivo a volare ma cadevo lungamente, lungamente, in un profondo abisso, leggero come se volassi; sapevo che laggiù mi attendevano l’urto e il fuoco, e volevo godere il più a lungo possibile, godere magari della bellezza di quella caduta vertiginosa, tanto una volta in fondo mi sveglierò, giacché tutto questo non è vero, non mi sono ancora svegliato del tutto, sto sognando, sto sognando, come poco fa. Sto sognando. Di colpo la mia leggera caduta all’inferno, una caduta così simile a un volo, cessa; mi rendo conto che sto sognando e verifico su quale fianco sono coricato» (GC. p. 176).
Si potrebbe definire il sogno con questa intensità se lo stato di veglia non fosse tenace ombra, efferato sopruso, crudele violenza, e solo nella sua trasfigurazione in sonno/sogno trovasse il magico accordo che rende la vita acuta e struggente meraviglia? Il regno terreno di Kiš, che è “discarica” e “caos” come lui stesso lo definisce, non rappresenta la notte da illuminare ma la notte nella quale restare in compagnia dei propri e degli altrui fantasmi, come un balordo Don Chisciotte: «In effetti nel Don Chisciotte, tutti i grandi accadimenti avvengono di notte, sotto il velo delle tenebre. La notte conferisce alle cose un fascino particolare: anche l’uomo più lucido fatica a distinguere l’ombra e l’illusione dalla realtà... Egli la sceglie come sfondo dei momenti più dolorosi o più romantici vissuti dai suoi sensi. La risata di Cervantes riecheggia da una simile oscurità. Se volessimo trovate un’atmosfera corrispondente in Rabelais e contrapporla al notturno di Cervantes, allora dovremmo notare che Rabelais ride alla luce del sole, sotto i suoi raggi roventi, senza uno straccio d’ombra; la risata echeggia empia, faunesca, pagana» (UBBS, p.39).
Fino all’ultimo Kiš non vuole rinunciare all’atto di raccontarsi: «...e poi l’incapacità di privarmi di quel piacere di narrare che allo scrittore dà l’ingannevole impressione di creare il mondo, e di conseguenza, come si suol dire, di cambiarlo» (TBD. p.41). A quell’atto, denso e allusivo, di testimoniare raccontando, Danilo Kiš dedica la vita intera cercando di sognare l’impossibile, anche in mancanza dell’orario ferroviario universale vagheggiato dalla fantasia del padre, sperando che, almeno nei personaggi dei suoi racconti, quel sogno non smetta di morire e possa superbamente vivere, non triturato dal vile e crudele esistere.
Leggi anche:
Danilo Kiš, Gli scrittori-delatori
Alfredo Zucchi, Danilo Kiš, La lezione di anatomia
Massimo Rizzante, Homo poeticus, malgrado tutto
Massimi Rizzante, Sull’arte della composizione di Danilo Kiš
Libri dell’autore:
1.Giardino, cenere (GC), Adelphi, 1986.
2.Enciclopedia dei morti (EM), ivi, 1988.
3.Clessidra (CL), ivi, 1990.
4. Dolori precoci (DP), ivi, 1995.
5. Una tomba per Boris Davidovic (TBD), ivi, 2005.
6. Homo poeticus (HP), ivi, 2009.
7. Il liuto e le cicatrici (LC), ivi, 2014.
8. L’ultimo bastione del buon senso (UBBS), Wajtek edizioni, Napoli 2022.
9. Poesie (PK), Finis Terrae, Ibis, Pavia 2022.









