Speciale
Il corpo vivo del malato
Nel libro a più voci Che cos’è la psichiatria (1967), pubblicato da Einaudi nel 1973 e ristampato nel 2024 per le edizioni Baldini & Castoldi in occasione del centenario dalla nascita di Franco Basaglia, l’autore scrive: «Le diagnosi psichiatriche hanno assunto (...) un valore ormai categoriale, nel senso che corrispondono ad un etichettamento, ad una stigmatizzazione del malato, oltre i quali non c’è più possibilità d’azione o di approccio. Nel momento in cui lo psichiatra si trova faccia a faccia con il suo interlocutore (il “malato mentale”) sa di poter contare su un bagaglio di conoscenze tecniche con le quali – partendo dai sintomi – sarà in grado di ricostruire il fantasma di una malattia; avendo, tuttavia, la netta percezione che – non appena ne avrà formulata la diagnosi – l’uomo sfuggirà ai suoi occhi, perché definitivamente codificato in un ruolo che ne sancisce soprattutto un nuovo status sociale». (p. 26).
A distanza di cinquant’anni dalla pubblicazione del libro, queste frasi echeggiano nitide e chiare come e più di allora, e presuppongono una netta posizione politica nei confronti della malattia psichica e dell’operatore psichiatrico: finalmente si può parlare a voce alta (e scriverlo in saggi e libri) della libertà dell’individuo malato e non del potere esercitato sulla sua presunta pericolosità. Cos’è accaduto, da allora, nello sviluppo concreto della psichiatria? I servizi territoriali hanno mancato al loro ruolo di prevenzione sociale, perché impoveriti delle necessarie risorse. I servizi ospedalieri, a fronte della costante richiesta di ricoveri, hanno progressivamente accentuato la loro valenza istituzionale, trasformandosi in luoghi temporanei di reclusione. Ciò che sarebbe dovuto accadere – diminuzione di autorità del potere medico, differenziazione dei saperi in campo sociale, attenzione alla fenomenologia umana delle relazioni – è accaduto sì, ma per lampi isolati, grazie a operatori che volevano inventare, con i malati, episodi di reciproca liberazione: gruppi di autoaiuto, gruppi per auditori di voci, gruppi di scrittura creativa, e altre attività, sono stati non la colonna vertebrale di qualsiasi servizio pubblico ma le eccezioni (talvolta le illusioni) di singole volontà terapeutiche. Si è prodotta una dispersione di atti di libertà all’interno di un tessuto di potere meno vistosamente autoritario, ma non per questo meno presente, dove l’esclusione era sempre il fattore dominante. Quella che, negli anni Settanta, Ronald Laing definiva la “vulnerabilità ontologica” del malato psichiatrico (un concetto ricco di umana e filosofica compassione), è, se vogliamo ampliare lo sguardo a livelli sociali e politici, non solo la ferita individuale del soggetto scisso, la sua maggiore predisposizione a soffrire vissuti distruttivi, ma un complesso “frattale” di influssi interni ed esterni che segregano il malato dentro le mura di un carcere intessuto tanto di traumi psichici quanto di violenze esterne, dove la solitudine della psiche è inestricabile dalla condizione di abbandono in cui è gettato il corpo fisico.
Prima della vita e dell’opera di Basaglia c’era un sistema di certezze dato per scontato: il sistema politico di una istituzione totale, legittimata da un pensiero pseudoscientifico che affondava le sue radici proprio nell’abuso istituzionale, nel distacco del malato dalla comunità degli umani (la celebre “nave dei folli”, immortalata dall’opera di Sebastian Brant). Che cos’è la psichiatria è il punto di partenza per un percorso di smantellamento del potere psichiatrico: questa impresa, non chimerica, occuperà, teoricamente e praticamente, la breve vita di Franco Basaglia. La struttura del volume è già, in parte, la trasformazione della forma totale del libro nei segni frastagliati di discorsi a più voci, attraversati da diverse soggettività: degenti, infermieri, psichiatri. La riflessione sul potere psichiatrico sgretola linguaggi, mura, protocolli, saperi. Libera, dolorosamente, i corpi e le menti dei malati. Che cos’è la psichiatria restituisce delle vite incarcerate a una nuova speranza di libertà. Non descrive gli stati dell’anima: sgretola, con sovversiva e minuziosa intelligenza, le mura che la imprigionano. Basaglia contesta il vecchio rapporto dello psichiatra con la creatura affetta da malattia psichica così come si è formato nella pratica medica: «l’uomo sfuggirà ai suoi occhi perché definitivamente codificato in un ruolo che ne sancisce soprattutto un nuovo status sociale. Si entra cioè in una sorta di passività che lo «scienziato» viene ad assumere di fronte al fenomeno e che lo porta a risolverlo attraverso una routine tecnicamente perfetta – da lui nettamente separata – la cui finalità pare quella dello smistamento fra ciò che è normale e ciò che non lo è» (CEO, p. 26).
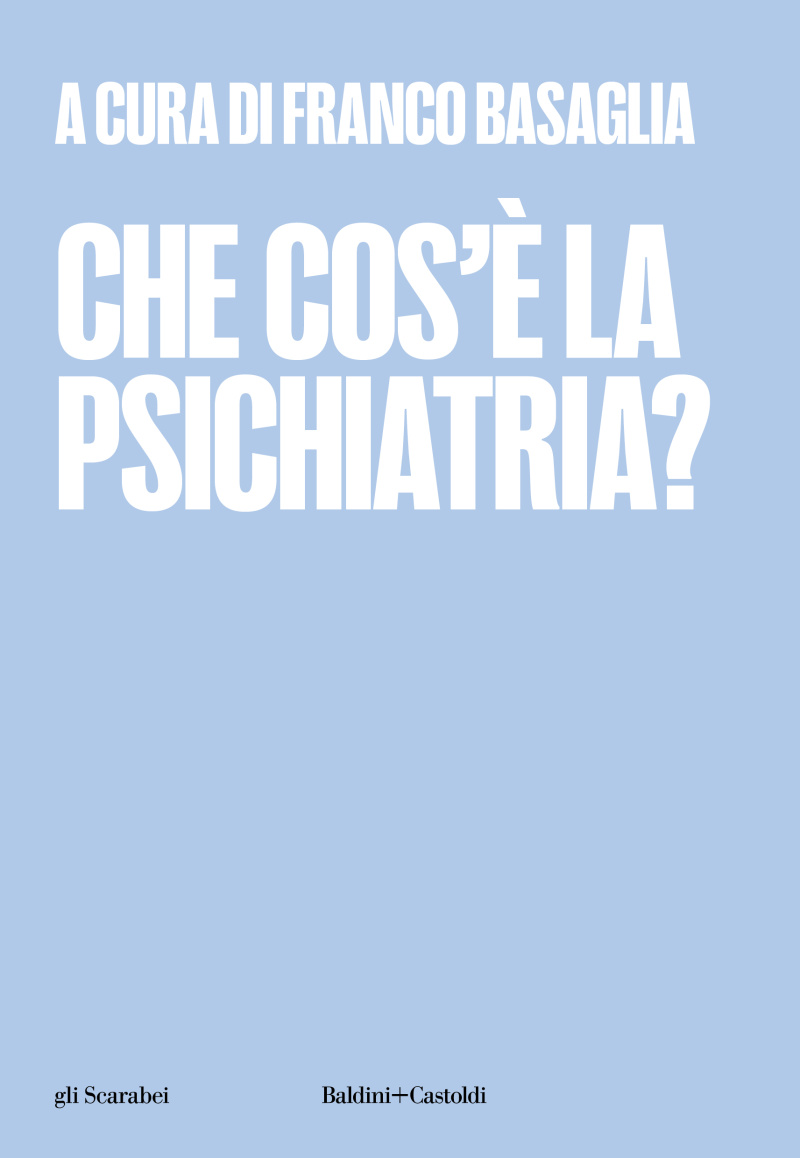
Che cos'è la psichiatria? fotografa una realtà concentrazionaria in procinto di dissolversi come luogo forzato di clausura. Esige di aprire porte, sbarre, cancelli, di quello che era, come simbolo e come realtà, il manicomio, il luogo di reclusione per ogni smisurata e scomoda passione umana. Vuole eliminare contenzioni e violenze ragionando sulla qualità della terapia, sul significato dell'istituzione chiusa e della psichiatria, sulla necessità stessa della propria esistenza; internati, infermieri, medici, psicologi, amministratori, cercano nuove identità, di ruoli e di rapporti qualitativamente diversi: esigono (oggi sembra ovvio, ma non sarà mai ovvio) la negazione della clausura; cercano libertà, responsabilità, disponibilità, dignità, fiducia, confronto, verifica, critica e autocritica, per formare la base di una reciproca terapeuticità. Primo Levi scrisse: «Si immagini ora un uomo a cui, insieme con le persone amate, vengano tolti la sua casa, le sue abitudini, i suoi abiti, tutto infine, letteralmente tutto quanto possiede: sarà un uomo vuoto, ridotto a sofferenza e bisogno, dimentico di dignità e discernimento, poiché accade facilmente a chi ha perso tutto di perdere se stesso» (Se questo è un uomo). Di quell’“uomo vuoto”, e dell’inestinguibile speranza di restituirgli dignità umana, scrive ancora Franco Basaglia: «La nostra realtà è dunque l’internato degli ospedali psichiatrici, per il quale la psichiatria non ha trovato finora che soluzioni negative, vivendone l’incomprensibile psicopatologico come una mostruosità socio-biologica da allontanare e da escludere. Ma se lo studioso di psicopatologia può trovare legittimo continuare a cercare ideologicamente la soluzione per una tale mostruosità, mantenendosi staccato dalla realtà che non gli sta sotto gli occhi, lo psichiatra che faccia parte di un’organizzazione ospedaliera, si trova inevitabilmente costretto ad una scelta immediata. O accetta i parametri della psichiatria tradizionale e, quindi, fa ad essi aderire il malato ed i sintomi con i quali è stato etichettato, sanando il conflitto fra teoria e pratica a solo favore della teoria (e allora instaura con lui l’ovvio rapporto gerarchico-autoritario che il suo ruolo gli richiede). O si avvicina al malato così com’è, cercando di comprendere che cosa è diventato a causa di quei parametri che ne hanno sancito – come con un marchio – la diversità, dando la precedenza questa volta alla realtà, come unica fonte di verifica» (p. 30).
L’alternativa oscilla fra un’interpretazione ideologica della malattia che consiste nella formulazione di una diagnosi esatta, ottenuta attraverso l’incasellamento dei diversi sintomi in uno schema precostituito; o l’approccio al “malato mentale” a una dimensione reale dove la classificazione della malattia ha e non ha peso. A mio modesto parere, esercitando per trentasette anni la professione dello psichiatra in un servizio territoriale, e quindi vivendo lunghi fallimenti e brevi successi, mi sono accorto che l’approccio al malato non è descrivibile da un metodo standard, valido per tutti; si avvicina piuttosto a una jam session dove è sempre necessario sapere dove si va (il “benessere” del malato), ma essendo coscienti che le strade che seguiremo, insieme a lui, non possiamo prevenirle in anticipo, MAI. Sarà lui, il malato, a dirci, non appena potrà farlo, qual è l’accordo giusto per lui in quel momento della nostra “improvvisazione” a due. D’altronde, anche Novalis ci dice come la malattia è sempre una “questione musicale”.
Considerato un “escluso” dalla società dei normali, il “matto” si vede così confermata la motivazione della sua reclusione: “pericoloso a sé e agli altri”. La follia è sempre un “pericolo”, per la società costituita, che se ne difende in tutti i modi. E i matti sono “matti” perché non sanno gestire l’energia delle loro “galassie parallele” e ne sono sopraffatti. Negli stessi anni in cui i libri sovversivi di Basaglia venivano pubblicati da Einaudi, le edizioni Adelphi pubblicavano Memorie di un malato di nervi di Daniel Paul Schreber, un libro di memorie dove il Cancelliere di stato Schreber, fingendosi guarito, racconta nei minimi dettagli, come in un beffardo romanzo-confessione, la sua esemplare “follia”.
Erving Goffman per i ricoverati negli ospedali psichiatrici, Franz Fanon per la condizione dell’uomo di colore, Primo Levi per i prigionieri dei campi di concentramento nazisti, parlano tutti lo stesso linguaggio: si riferiscono tutti allo stesso fenomeno di esclusione e di cancellazione. Fanon, in I dannati della terra: scrive: «L’indigeno è un essere chiuso in un recinto, l’apartheid è una modalità della divisione in scomparti del mondo coloniale». Prescindendo dalla malattia in sé, è evidente che si tratta dello stesso fenomeno di esclusione. Quando si parla della condizione asilare del malato mentale, la malattia si trova ad avere un valore puramente accessorio nel processo di ciò che Primo Levi chiama la «demolizione» dell’uomo. Se l’escluso è stato rifiutato da una società che lo ha visto solo per i sintomi di cui soffriva o per il colore della sua pelle, la comprensione del malato (come del colonizzato e del prigioniero) è quella del suo ruolo reale, libero da ogni significato di malattia (o di inferiorità). Questa percezione è l’avvio a una presa di coscienza nei confronti della malattia stessa: l‘opposizione all’esclusione rafforza quell’io la cui demolizione era stata già statuita dal processo di istituzionalizzazione. Scrive Basaglia: «Se, infatti, il malato è l’unica realtà cui ci si debba riferire, si devono affrontare le due facce di cui tale realtà è appunto costituita: quella del suo essere un malato, con una problematica psicopatologica (dialettica e non ideologica) e quella del suo essere un escluso, uno stigmatizzato sociale. Una comunità che vuol essere terapeutica deve tener conto di questa duplice realtà – la malattia e la stigmatizzazione – per poter ricostruire gradualmente il volto del malato così come doveva essere prima che la società, con i suoi numerosi atti di esclusione, e l’istituto da lei inventato, agissero su di lui con la loro forza negativa» (p. 35).
Forse queste parole di Basaglia sono le prime a evidenziare con precisione la relatività della malattia mentale senza schematizzarla in una definizione generica, non mancando di individuare la duplice realtà della malattia e della stigmatizzazione, e ricostruendo in tal modo la sola cosa che conta: “il volto del malato”, quello che sarebbe il suo volto reale prima che i soprusi del potere lo trasformino in maschera vuota. Scrive Antonio Slavich: «Ogni campo istituzionale esiste solo come funzione delle persone che si muovono nei loro ruoli fissi, e più ancora in quelli da negare, come ci interagiscono, come vivono la loro vita concreta, attiva e passiva, le loro immaginazioni, le loro emozioni, e così del campo entrano a far parte non solo l’oggi sensibile, ma anche le memorie e le culture del passato, e le speranze e i progetti per un domani» (All’ombra dei ciliegi giapponesi, AB Edizioni, 2018, p. 91). In uno dei saggi contenuti in questo libro, John Connelly. Dalla filantropia alla psichiatria sociale, di Agostino Pirella e Domenico Casagrande, si parla dell’esperienza del “Ritiro” di New York (1839), basata sull’esigenza preliminare di modificare profondamente il clima asilare, sulla base del rifiuto delle restrizioni fisiche e, in parte, psicologiche, e sulla base del nuovo metodo che ne deriva, il “moral treatment” (p. 216). La realtà di un internamento “umanitario”, senza le stigmate dell’esclusione, in qualche modo analoga alla coeva “Clinica del dottor Blanche” in Francia, dove furono ricoverati artisti come Maupassant e Bizet, indica che l’utopia di un futuro “umano” per il malato mentale può anche arrivarci dalle esperienze del passato, e che dovremmo ancora, e sempre, studiare con attenzione l’opera dello psichiatra libertario Philippe Pinel. È sempre stato questo lo scopo di Franco Basaglia: non limitarsi a parlare dei concetti di esclusione ma viverli, nel presente e nel passato, proprio nella dinamica fra le singole persone, malati e curanti, preservando così l’impalpabile atmosfera che per anni è stata cancellata dall’istituzione psichiatrica: l’aria viva della relazione umana.









