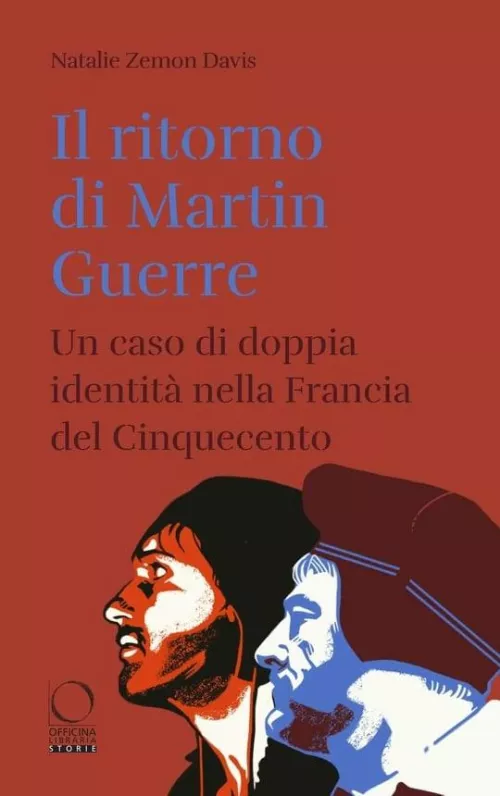Un classico della storia / Il ritorno di Martin Guerre
Arriva in questi giorni in libreria la nuova edizione di una delle opere storiografiche più significative del XX secolo: Il ritorno di Martin Guerre della storica canadese-statunitense Natalie Zemon Davis (Harvard University Press, 1983). La versione in lingua italiana, pubblicata nella collana “Microstorie” di Einaudi, risaliva al 1984 ed era ormai introvabile. Viene quindi oggi riproposta da “Officina Libraria” con tutti i suoi ingredienti originari: la postfazione di Carlo Ginzburg, un agile apparato iconografico esplicativo, e l’ottima traduzione di Sandro Lombardini. L’intento è offrire ai lettori la possibilità di riappropriarsi di un libro ormai tanto paradigmatico quanto unico. L’idea di comporlo nacque infatti da circostanze singolari, vale a dire su un set cinematografico. È la stessa autrice a raccontare nelle pagine introduttive di aver collaborato in qualità di consulente scientifica con il regista Daniel Vigne e lo sceneggiatore Jean-Claude Carrière alla lavorazione di un fortunato film incentrato sulla vicenda, interpretato da Gérard Depardieu e Nathalie Baye.

La trama è nota a molti, ma giova ricordarne alcuni tratti essenziali. Nel 1548 l’agiato contadino di origine basca Martin Guerre decide di scomparire nel nulla, facendo perdere le sue tracce. Nella sua casa del villaggio di Artigat, a sud-ovest dei Pirenei in territorio francese, lascia la moglie Bertrande de Rols e il piccolissimo figlio Sanxi, costretti ad affrontare una situazione difficilissima. Pur essendo ancora molto giovane, la donna non può risposarsi perché la morte del coniuge non è certificabile. Dopo otto anni di sofferenze e attese, intravede uno spiraglio per una svolta: un uomo si presenta alla sua porta, afferma di essere suo marito e chiede di essere accolto. Molti dubbi serpeggiano fra parenti e conoscenti, ma l’enigmatico individuo mostra di possedere in maniera approfondita i ricordi di Martin, oltre ad avere un aspetto molto simile. Il passo decisivo è comunque quello di Bertrande, che riconosce in lui il compianto coniuge e apre la strada alla ricostruzione del matrimonio. La coppia vive in armonia fino al 1559, dando alla luce altri due figli, ma l’idillio si rompe con l’insorgere di conflitti nel parentado, dovuti alla divisione delle modeste eredità familiari. Lo zio Pierre Guerre denuncia il redivivo nipote, accusandolo di essere un impostore e sostenendo di aver scoperto la sua vera identità: secondo lui, l’uomo è Arnaud du Tilh, proveniente dalla regione di Sajas, e conosciuto da molti anche con il soprannome di Pansette.
La controversia degenera fino all’apertura di un procedimento giudiziario destinato ad attrarre l’attenzione di molti francesi e a finire di fronte alla corte di Tolosa, con sviluppi sorprendenti. I giudici sono infatti inclini ad accogliere la versione dell’imputato e a mettere alla sbarra Pierre per la sua avidità. Tuttavia, quando tutto sembra deciso, le sorti della causa vengono capovolte dall’arrivo di un uomo con una gamba di legno che sostiene di essere il vero Martin e di essere stato ferito durante un conflitto armato. Due soggetti diversi, dunque, si contendono un unico nome, un unico esile patrimonio e un’unica moglie.
Mentre osservava gli attori recitare sotto la direzione di Daniel Vigne per la realizzazione del film, Natalie Zemon Davis si rese conto di essere stata catapultata in un vero e proprio laboratorio storico. Le espressioni del volto di Gérard Depardieu dipingevano solo una delle tante immagini possibili di Pansette, lasciando in secondo piano diverse sfumature, che solo una differente forma di narrazione avrebbe potuto salvare.
La pellicola – racconta l’autrice – stava acquisendo la semplicità necessaria per attrarre l’attenzione del pubblico, ma stava al contempo perdendo tutto il potenziale esplorativo che poteva avvicinarla alla realtà dei fatti accaduti. Più che soddisfare le esigenze conoscitive della studiosa, quell’esperienza cinematografica l’aveva quindi spinta a sviluppare nuove domande, facendole avvertire in maniera ancora più forte la necessità di far luce sui fili di fondo di quella vicenda, esplorando il contesto economico, culturale, politico e religioso dell’Europa rurale del XVI secolo. Solo una ricerca di tale respiro avrebbe reso possibile rispondere al mandato del lavoro storico: provare a comprendere le motivazioni profonde che avevano ispirato le scelte dei protagonisti, le loro paure e le loro aspettative, le loro battaglie e le loro rese.
Nasce così un libro di storia che accoglie nelle sue pagine tutte le incertezze proprie della ricerca di una verità complessa, che a tratti appare addirittura irraggiungibile. Le fonti a disposizione sono davvero scarne. La principale è un testo intitolato Arrest Memorable, composto all’epoca dei fatti dal giurista Jean de Coras, chiamato a pronunciare il parere definitivo in sede processuale. Coras è un maestro di eloquenza e gode di una carriera brillante, ma il suo rapporto con la giustizia è complesso: si mostra in diverse occasioni scettico nei confronti delle decisioni prese dai tribunali, e ancor meno crede nel valore delle testimonianze, nell’attendibilità delle prove e nell’efficacia delle confessioni estorte con la tortura. È fin da subito vicino al protestantesimo e studia la dottrina calvinista con grande interesse, fino a decidere di convertirsi. È soprattutto convinto di dover rendere la pratica giudiziaria comprensibile a una più ampia platea di lettori e uditori, uscendo fuori dal circuito ristretto degli specialisti: non a caso decide di diffondere il suo testo in lingua volgare, rinunciando al latino.
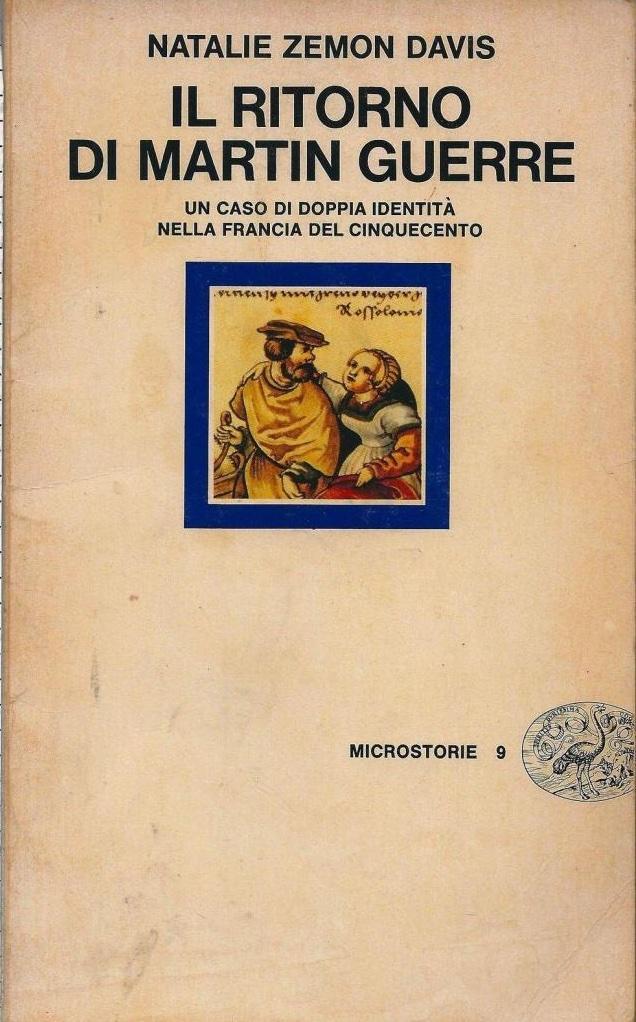
Ammette di essere affascinato da Pansette, dalla sua prodigiosa memoria, dalla capacità di offrire racconti vividi usando in maniera mirabile i gesti e le parole. Proprio per questa ragione, Coras è tentato dall’idea di credere alla sua versione dei fatti e di assolverlo. Il ritorno dell’uomo con la gamba di legno, il presunto “vero Martin”, scongiura quindi la possibilità di un clamoroso errore. Non c’è quindi da stupirsi del fatto che il prestigioso giurista interpreti l’evento – il “ritorno” – come un segno della grazia divina, una conferma di ciò gli era dettato dal suo credo religioso.
Un nodo ancora più dirimente è l’unicità dell’Arrest Memorable, ben lontano dall’essere uno dei molteplici resoconti di giustizia pubblicati nel Cinquecento, prima dell’avvento della stampa periodica e delle gazzette: brevi racconti moralizzanti, talvolta accompagnati da incisi fantasiosi, che privilegiavano le sentenze, le punizioni e le abiure dei criminali, tenendo nascosti al pubblico gli intrighi procedurali e gli arcani della pratica giudiziaria. L’opera di Coras dedica solo due delle sue 117 pagine al verdetto finale, che condanna Pansette: il giudice non mira a costruire un trattato giuridico, ma a far comprendere quanto siano imperscrutabili i casi umani. Per farlo, coniuga il registro comico a quello tragico, finendo talvolta per attribuire al presunto malfattore tratti eroici. Il suo racconto – capace di accogliere suggestioni molteplici, dalle novelle di Giovanni Boccaccio e Margherita di Navarra, fino a racconti picareschi come Lazarillo de Tormes (come sottolineato anche da Giancarlo Alfano nel suo recente volume sulla Fenomenologia dell’impostore – vedi la recensione su doppozero) – è attraversato dal dubbio, conducendo i lettori nei percorsi tortuosi imposti dalla ricerca della verità.
Natalie Zemon Davis traduce queste incertezze in tanti “forse” e “può darsi”, rivelando in tal modo quanto siano fragili le possibilità di ricostruire l’accaduto con ragionevoli margini di certezza. Per aggirare i limiti di una documentazione elusiva, l’autrice si rivolge quindi agli universi contigui, nel tentativo di rinvenire risposte plausibili. Leggiamo nel testo: “Quando non trovavo l’uomo o la donna di cui ero in cerca mi sono rivolta, per quanto era possibile, ad altre fonti dello stesso tempo e luogo per scoprire il mondo che essi dovettero conoscere e le reazioni che poterono avere. Se quanto offro è in parte di mia invenzione, è però saldamente ancorato alle voci del passato”. Non si tratta dunque di contrapporre la fantasia all’esatta ricostruzione del reale, ma di integrare la stessa realtà con le possibilità che accompagnano l’agire umano. Non sapendo quali motivazioni profonde avevano ispirato i comportamenti di Martin, Bertrande, Pierre o Pansette, la storica si rivolge ad altri uomini e donne della stessa epoca che hanno lasciato tracce negli archivi notarili o giudiziari, per entrare nelle loro vite e cercare le spiegazioni plausibili del loro operato: in altre parole, la mancanza di notizie essenziali sui protagonisti viene compensata da uno sguardo ampio rivolto al mondo che li circonda.
Carlo Ginzburg ha evidenziato in questo metodo la presenza di alcune importanti analogie con i fili conduttori dell’opera di Erich Auerbach sulla rappresentazione della realtà nelle letterature occidentali (Mimesis, 1946). Uno dei problemi cruciali è infatti comprendere gli intrecci profondi che legano la narrativa d’invenzione ai testi di cronaca legati a eventi “più o meno straordinari”. Difficile non cogliere in queste riflessioni anche l’eco del discorso sviluppato da Alessandro Manzoni sul romanzo storico, inteso come prodotto capace di superare i limiti della ricerca documentaria, di riempire i silenzi delle fonti con l’esplorazione del verosimile: nell’impossibilità di conoscere ciò che è davvero accaduto, si apre la possibilità di formulare ipotesi su ciò che possiamo provare a sapere. Questi confini porosi non devono tuttavia far pensare – per rimanere sull’opinione di Ginzburg – a “un’attenuazione delle possibilità conoscitive della storiografia, ma al contrario a una loro intensificazione”. La ricerca della prova rimane dunque essenziale, e non lascia un largo margine di azione alle tentazioni relativistiche. Ci sono molte soluzioni possibili per esplorare il passato, compresi i viaggi fra documentazioni contigue alle vite dei personaggi indagati, ma sicuramente è da escludere la pura invenzione: quest’ultima non è un’alternativa da tenere in considerazione.
Gli stessi nodi hanno accompagnato il dibattito degli studiosi negli ultimi decenni, sospeso fra l’importanza della dimensione narrativa della storiografia (il cosiddetto “ritorno al racconto”, che ha seguito la fortuna dei grandi quadri collettivi centrati sulla lunga durata, sulle analisi quantitative, sulle mentalità, l’economia, le culture materiali) e le necessità conoscitive del sapere storico. Un caso editoriale degli ultimi mesi è stato certamente utile a far riemergere alcune questioni interpretative che rimangono cruciali: si tratta del lavoro di Fernanda Alfieri dedicato all’esorcismo praticato a Roma sulla giovane Veronica Hamerani negli anni Trenta dell’Ottocento (Veronica e il diavolo, Einaudi, 2021, vedi la recensione su doppiozero). L’autrice chiarisce che la ricerca riesce a raccogliere dati, ma questi ultimi risultano spesso insufficienti, galleggiano “nel mare del dimenticato, dell’andato perduto, o del mai scritto”. La storica lascia quindi entrare il suo stato d’animo nella narrazione ed è indotta a seguire alcune suggestioni, nelle quali si riconoscono indicazioni metodologiche simili a quelle di Natalie Zemon Davis: fingere che “la morte non sia mai sopraggiunta”, intraprendere la “via intermedia della congettura, purché fondata sulla plausibilità, purché da qualche parte ci sia un’informazione superstite” utile a formulare delle ipotesi valide. Bisogna muoversi dunque in una “libertà vigilata” sperando di far rivivere nei suoi testi uomini e donne possibili, “e albe, tramonti, freddo, caldo, odori, tessuti, umori di approssimazione, accettando di avere già nostalgia […] di quello che sono stati”.

Proprio al rapporto fra elaborazioni letterarie e ricerca storica fa infine pensare una curiosa coincidenza: il ritorno in libreria delle avvincenti avventure di Martin, Bertrande e Pansette non è legato solo al titolo di Natalie Zemon Davis, ma anche a un’opera di finzione: La moglie di Martin Guerre, un romanzo breve della scrittrice Janet Loxley Lewis, originariamente composto nel 1941 e oggi proposto in italiano dalla casa editrice “Racconti” nella collana “Scarafaggi” (con la traduzione di Eva Allione). Le due opere hanno in realtà un importante punto in comune, ed è proprio Natalie Zemon Davis a individuarlo: entrambe focalizzano l’attenzione su Bertrande, senza considerarla come un’ingannatrice o una vittima, bensì come una donna dotata di spirito e indipendenza. In entrambi i libri emergono con forza le ragioni di Bertrande, che cerca con ostinazione un suo spazio di autonomia, rifiutando la condizione miserevole a cui è costretta una moglie abbandonata del XVI secolo, priva anche del privilegio della vedovanza. La protagonista della storia combatte dunque diverse battaglie: contro i ruoli che le sono concessi in quanto donna, contro il marito, contro i sentimenti che la legano a Pansette. La sentenza pronunciata a Tolosa ha per lei un sapore amaro, avendola liberata “da entrambe le passioni e da entrambi gli uomini”. L’unica cosa che le resta è la solitudine.
Leggi anche
Luigi Grazioli, Mentire, imbrogliare e raggirare