La gente mormora. Ancora su Eco e i media
Parole, non fatti! Questo ribaltamento del detto – e del senso – comune dovrebbe esser banale: tutto il Novecento lo ha ampiamente teorizzato e praticato, parlando di svolte linguistiche, strutturaliste e poststrutturaliste, semiotiche e così via. Se c’è un tema che pensatori, intellettuali, studiosi, artisti o critici anche assai diversi per ideologia e valori hanno condiviso è proprio quello della centralità, se non della primarietà, del linguaggio o, meglio, dei linguaggi. Difficile proporre i grandi temi della filosofia (essere/divenire, conoscenza/sensibilità, giustizia/terrore), della letteratura (realismo/finzione, impegno/disimpegno…), dello studio delle culture (innato/acquisito, mito/rito…), per non parlare della mediologia (massa/potere, manipolazione/persuasione, tecnologia/corporeità…) senza introdurre quella dimensione simbolica che nel linguaggio, nei linguaggi, quasi per natura risiede. Di modo che quando si discute la vexata quaestio dell’informazione più o meno corretta, delle notizie post-false o post-vere, sono appunto le parole a essere importanti, non i fatti. Non per quel che significano o, se accade, rappresentano, ma per quel che fanno e fanno fare, e dunque per il loro valore, per dirla coi linguisti, performativo. D’altro canto, come diceva Bachelard, i fatti sono fatti: e fatti di segni, ne abbiamo contezza soltanto grazie a essi. Una banalità.
Così, ritrovare uno slogan come questo sulla copertina di una delle ultime raccolte di scritti mediatici di Umberto Eco – L’era della comunicazione. Dai giornali a Wikileaks (La Nave di Teseo, pp. 190, € 12) – provoca un sussulto perplesso. Certo, parole e non fatti, cos’altro? Non ce lo ha insegnato proprio lui, in sessant’anni di magistero (e di maestria) sui segni? Cosa c’è di nuovo? Perché allora, in soldoni, rileggere questi testi adesso, in un’epoca così ingarbugliata e virulenta che qualcuno, giustamente, ha definito postmediale? Non dovremmo essere altrove?
La risposta, manco a dirlo, è in Eco stesso, e sta in quella constatazione al contempo evidente e profonda che dava il titolo a un suo libro che ormai ha quasi vent’anni: rispetto alle grandi conquiste del Novecento – nell’economia, nella società, nella politica, nel costume, nella cultura e quindi anche, per quel che riguarda i media, nella teoria della comunicazione e dell’informazione – torniamo indietro a passo di gambero. Di gamberone verrebbe da dire, data la velocità di questa restaurazione accanita e astutissima. Di modo che eccoci di nuovo a parlare di eventi concreti e obiettività, di separazione fra notizia e commento, di fake news che ne presuppongono di vere, di trasparenza informativa e simili. Scambiando, direbbero i filosofi, il dover essere per l’essere. Insomma, bene ha fatto La Nave di Teseo a ripresentare questi scritti echiani sui media, e ad accostarli intelligentemente ad altri, apparentemente più filosofici ma in effetti del tutto complementari, raccolti sotto il titolo Quale verità? Mentire, fingere, nascondere (pp. 168, € 12) – entrambi curati e introdotti da Anna Maria Lorusso.
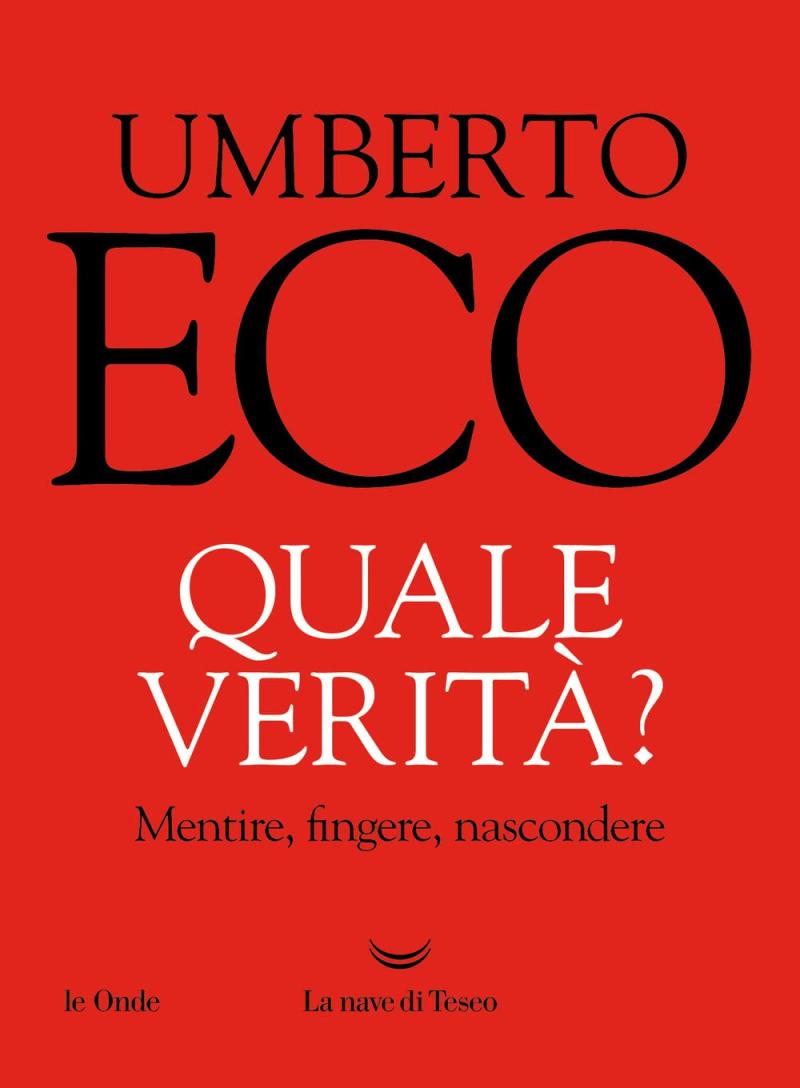
L’obiettività, nel giornalismo come in altri tipi di discorso (storia, scienza etc.), è un mito ideologico – ribadisce Eco a più riprese –, e come tutti i miti ha un peso e un valore che devono esser presi sul serio, non solo per capirne i dispositivi di funzionamento ma, soprattutto, per misurarne il significato. Come dire che il problema non è dire, semplicemente, che l’obiettività non esiste, oppure che è funzionale al (quarto?) potere della stampa; semmai, ribadirne la fondatezza significa negare l’evidenza. Sentiamo Eco: “Parlare di ‘mito dell’obiettività’ significa dire: non si dà notizia se non interpretandola, se non altro per il fatto di sceglierla. Per di più un giornale si fa con il titolo, con il loro corpo e il loro carattere; con l’impaginazione, e il taglio dell’articolo; con la collocazione dell’articolo in una pagina piuttosto che nell’altra; coi colori, se ci sono, e con tante altre cose. A livello di ciascuno di questi elementi abbiamo altrettanti interventi interpretativi”. Difficile dire che non sia così, e fa specie esser qui a ribadirlo, soprattutto oggi che si è altresì acquisita la definitiva consapevolezza che anche raccontare è sempre e necessariamente interpretare: lo storytelling non è mai innocente. C’è sempre un punto di vista, un sistema di valori entro cui prendere posizione, azioni e passioni che nel loro concatenarsi generano mondi possibili.
Ma tant’è. Allora, ne conclude Eco, piuttosto che incaponirsi a inseguire una trasparenza e una veridicità impossibili (per costituzione stessa dei media), è molto meglio farsi carico delle responsabilità interpretative che stanno nella fattura stessa del giornale (o di qualsiasi altro mezzo di informazione). Leggiamo ancora: “Il giornalista non ha dovere di obiettività. Ha dovere di testimonianza. Deve testimoniare su ciò che sa e deve testimoniare dicendo come la pensa lui”. Così, “il compito del giornalista non è quello di convincere il lettore che egli sta dicendo la verità, bensì di avvertirlo che egli sta dicendo la ‘sua’ verità. Ma che ce ne sono anche altre”. Dichiarazione di chiara ragionevolezza illuminista che, si sa, Eco ha sempre rivendicato.
Ulteriore argomento contro quello che – aggiornando il panorama mediatico – potremmo di conseguenza chiamare il mito ideologico delle fake news, come suggerisce anche Lorusso nella sua introduzione, è la cosiddetta censura additiva, dispositivo cosmetico che funziona per aggiunzione indifferenziata piuttosto che per eliminazione o menzogna. Ed Eco, a questo proposito fa l’esempio delle veline, termine che una volta designava i ‘suggerimenti’ del Minculpop ai giornali mentre oggi indica, con inversione semantica niente male, le ballerine di Striscia la notizia. La velina fascista era simbolo di una censura che ammantava le cose fino a farle scomparire. La velina televisiva, dice Eco, è il contrario: è la celebrazione dell’apparenza, della visibilità a tutti i costi ma anche, aggiungeremmo, dell’irrisione del giornalismo nel suo insieme. Così laddove il fascismo metteva a tacere, i media informativi, oggi, fanno rumore, moltiplicano a dismisura messaggi tanto veritieri quanto insignificanti, finendo per creare quello che, in tutt’altro contesto, lo stesso Eco chiamava effetto nebbia, e cioè indeterminazione cognitiva. Parafrasando Wittgenstein (cosa che a Eco piaceva moltissimo): su ciò su cui si deve tacere, si deve parlare moltissimo. Che vuol dire? che sta succedendo? che pensarne?, ne conclude, confusissimo, il lettore dei giornali o lo spettatore della tv. E, ancor più, il navigante nella rete, dove la moltiplicazione infinita di stimoli d’ogni genere non censura proprio nulla ma, anzi, dice troppo, rendendo impossibile ogni interpretazione, dunque qualsiasi cosa voglia presentarsi come notizia. L’eroe di internet, dice Eco, è Funes el memorioso, il celebre personaggio di Borges che, ricordando tutto, mandava a puttane ogni memoria reale, ogni selezione possibile, ogni salutare dimenticanza.
Cosa opporre, in questa condizione, al rumore mediatico? La risposta di Eco è importante, più che mai oggi in epoca di dilagante infodemia: non il silenzio, per carità, che sarebbe un ritorno alle veline prima maniera, semmai il mormorio, quel sommesso flusso di pensieri e parole grazie a cui “ogni popolo è sempre riuscito a sapere tutto quel che succede nel mondo”. È il primato del pettegolezzo, della diceria, della chiacchiera, che nessuna censura riesce a bloccare, né quella fascista né quella televisiva. Se il silenzio è utopia totalitaria da Grande Fratello, il rumore è il regime comunicativo dei media di massa e ancor di più di quelli attuali. Il mormorio scivola via fra queste due censure: è il passaparola tattico che dribbla ogni strategia. Barthes lo chiamava brusio della lingua. E lo sapeva assai bene Tina Pica in quei bei film di De Sica: “la gente mormora”, ripeteva in continuazione. E per fortuna, aggiungiamo dunque.









