Wake up and love more / L'insostenibile leggerezza dei poeti pop
Tutta la poesia che precede la documentazione sonora e visiva è muta. La leggiamo, prima. Dopo, anche se non si può certo dire che la poesia sia un genere documentatissimo, possiamo ascoltare e vedere la poesia. Nel secolo audiovisivo non sempre questo significa vedere-sentire il poeta; ci sono poeti che leggono orrendamente i loro testi magnifici, come Giuseppe Ungaretti, e altri che nel live documentato hanno cambiato la storia della poesia del Novecento, come Allen Ginsberg. Potremmo disperarci di non poter vedere o ascoltare Edgar Allan Poe, o William Blake, o Majakovskij… abbiamo Carmelo Bene che legge Majakovskij, e finissimi attori che rimettono nel testo qualcosa che la sola lettura non ci può dare. Uno dei miei primissimi ricordi di forte emozione poetica risale a quando, bambino nell’era del vinile, nella non nutrita discoteca di mio padre scovai un long playing nel quale Arnoldo Foà leggeva Federico Garcia Lorca, tradotto ovviamente: il Lamento per Ignacio Sanchez Mejìas mi ha dato per la prima volta la convinzione che la poesia era l’emozione più bella e assoluta che avevo mai provato, e mi ha convinto di voler imparare a scrivere come poeta.
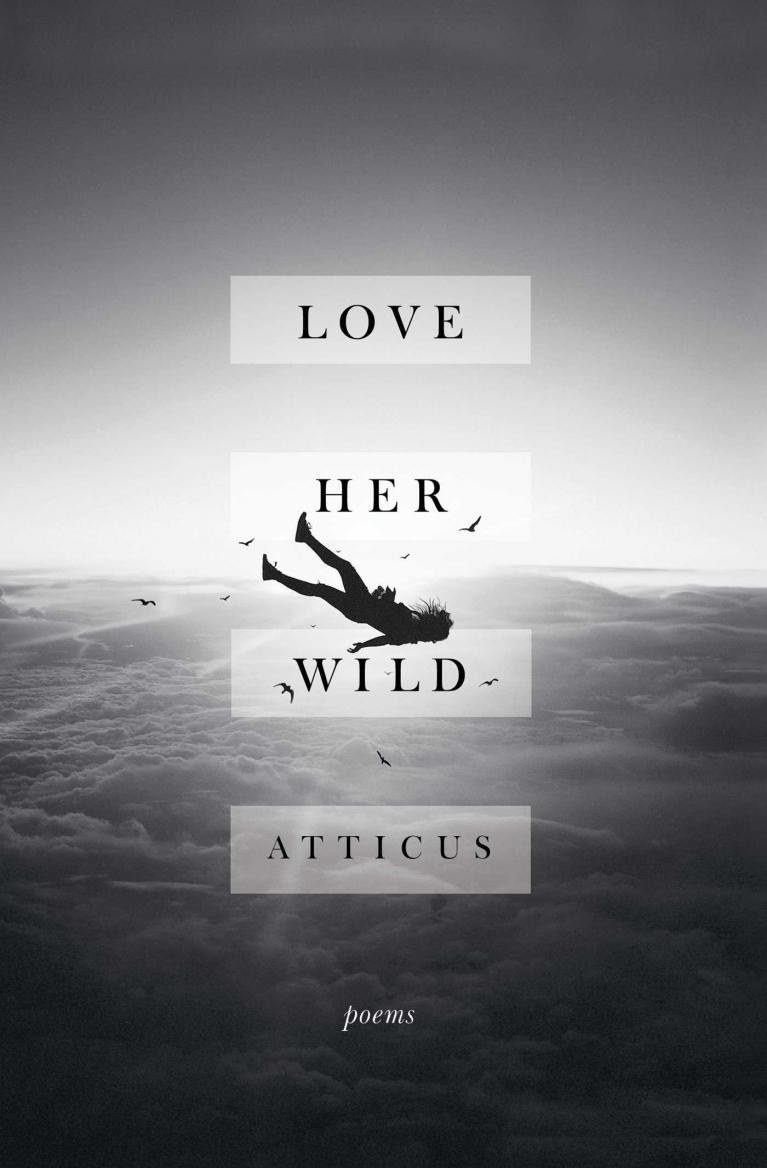
Se avessi ascoltato Carmelo Bene che leggeva il Llanto non avrei avuto lo stesso choc dionisiaco, perché non ero pronto al testo e al contesto, al tragico e folle e sardonico sarcasmo di Carmelo Bene; mi bastava il silenzio finalmente rappresentato tra una parola e l’altra, tra una linea e l’altra; il bianco da quel momento poteva per me essere il silenzio che alla poesia serve per inspirare, per caricare l’ascolto della densità che segue, il verso dopo. Arnoldo Foà (nella traduzione di Carlo Bo?) era solenne, straziante, virile, funebre e anche se non sapevo ancora che in quella poesia c’erano la sensibilità e l’estetica di un apollineo ma sanguigno omosessuale, da quel momento ero preso, come Dioniso prende, e nell’apollineo della parola scritta scava un turbine violento di passione e di canto.
Mi ha fatto pensare questo l’ondata dionisiaca che Kate Tempest trattiene e poi scatena in acquazzone-lavacro-di-amore nel suo magistrale poemetto Let them eat chaos (Che mangino caos). Kate (Esther Calvert, all’anagrafe) ha 32 anni, ma ha volto e voce di adolescente; non ha una voce teatralmente educata, ha la sua voce; ma non è una voce languida di poetessa triste. Non si accompagna con la lyra con cui si accompagnavano tutti i poeti greci, ispirati dal fuoco passionale e dionisiaco delle Muse, ma conosce molto bene l’arte che le Muse hanno scaturito, ovvero la mus-ica, che è rimasta tanti secoli con la poesia, sino alla lengua de oc, ai troubadours che Dante conosceva e omaggiava non accompagnandosi più con la musica (dicono che Petrarca invece a volte si accompagnasse con il liuto cantando i suoi versi, ma non trovo il link!), e che erano “cantautori” che si accompagnavano con il liuto di origine andalusa. Non si accompagna con l’organetto a mantice indiano con cui Allen Ginsberg si accompagnò quasi sempre, e che se tace mentre lo leggiamo lo dimezza. (Ginsberg cantò Blake, trasformando le sue Songs of Innocence and Experience in nursery rhymes, in ballad ubriaca, in foolish song).

Kate Tempest è una MC, una Mistress of Ceremony: il rap con i DJ ha aggiunto ai dozens di strada dei quartieri afroamericani di New York alla fine dei Settanta i primi scratch da vinile; i dozens erano battaglie di insulti tra gang in rime, erano cioè poesia di strada cui dopo si è aggiunta la musica come frammento ritmico, e non come melodia. Sul palco ricorda a memoria, senza sbagliare una parola, o perdere mai le svolte struggenti del suo lamento o furiose della sua invettiva, le centocinquanta pagine del suo poema. La accompagnano alcuni strumentisti, che al suo scritto (che possiamo leggere tradotto davvero bene da Riccardo Duranti per e/o) e alla sua passione aggiungono un doppio ai silenzi.
Kate racconta sette insonni nella stessa notte di Londra; «It’s four eighteen» sono le 4:18 di lui e lei strafatti di menfetamina o distrutti da un turno di notte, etilisti in vicoli sordidi e fighetti e fighette della City con i loro weekend e i loro mutui. Tutti sono disperatamente soli, ma sono «the people. The life. | Their faces are bright in your body. | You’re feeling. | You want to be close to them. | Closer»: Kate comincia così verso il pubblico nelle sue potenti e stupende performance; è veramente maestra di cerimonie, è sacerdotessa druidica, invasata dai suoi dei, sudata, con i boccoli biondi che mulinano sulle guance infuocate; vuole che noi ci avviciniamo a tal punto alla sua rappresentazione che sentiremo nel nostro corpo la luce di quei volti. Poi, capiremo, siamo noi quella gente.
Noi insonni che non capiamo più niente della nostra vita, che camminiamo di notte cercando invano il sollievo dell’alba, e dovremo tornare al lavoro senza aver dormito. Soffocati dalla non-vita. Alternando scariche di rapper e declamazioni di tragicità shakespeariana Kate Tempest lavora a un crescendo magistrale, nella sua ora di poetessa parlante, talvolta quasi cantante: l’elettricità emotiva si addensa in modo insoffribile, sino a che la tempesta shakespeariana arriva nella notte di Londra, spalanca con i suoi turbini le porte degli appartamentini dei miseri sette-noi, scroscia il diluvio universale che toglie il secco della solitudine cui è restato solo un sesso piacevole e senza relazione emotiva; sappiamo tutto, dei bombardamenti delle guerre dei bambini morti
neanche una traccia d’amore
nella caccia
al massimo
profitto.
Qua
nel paese
dove a nessuno
frega un cazzo.
ma tutto rimbalza come un’eco ovattata in noi
bloccati
come pietre
in un
ruscello pigro.
Siamo persi Siamo persi Siamo persi Siamo persi Siamo persi
Siamopersisiamopersisiamopersi
Siamo
davvero
persi.

«Londra è una fortezza per ricchi, se non ce la fai sei fuori» ma il chaos dell’uragano sta arrivando, e infine arriva l’orgasmo della catarsi, la pioggia sveglia i morti viventi, ognuno vede l’altro, e la piccola sacerdotessa chiude con parole stupende: «La fiducia è la fiducia è una cosa che non vedremo mai finché l’Amore non sarà incondizionato. Il mito dell’individuo ci ha lasciati scollegati smarriti e in stato pietoso. Me ne sto sotto la pioggia in una fredda notte londinese urlando ai miei cari di svegliarsi e amare di più. Scongiurando i miei cari di svegliarsi e amare di più».
La piccola grande Kate in Gran Bretagna è ripresa e prodotta dalla Bbc, e sale sul palco di Glanstonbury come Jeremy Corbyn, come lui accolta dalle ovazioni del popolo rock. Viene premiata dalla bella società letteraria, riceve nomination nei premi discografici pop. Kate è una grande poetessa e una eccellente performer, dà voce al sentire di un tempo e di una generazione. Ma la celebrità le viene dalla poesia per musica, dalla passione condivisa che la musica ha reso turgida nei suoi versi, che sono, muti, notevole letteratura. Nella sua ora sul palco fa ridere di gusto il pubblico due volte, ma tira dritto senza godersi l’applauso.
A Torino, che non è più una piccola Parigi e non è mai diventata una piccola Londra, ci sono poeti che sono stati pubblicati «nella bianca Einaudi» e ce n’è uno che no, si rammarica sarcastico di non esserlo stato ma che ora è pubblicato da Rizzoli e vende – dice – 20.000 copie. Quando Guido Catalano faceva i suoi primi reading nei caffè intellettuali di Torino qualcuno dell’Einaudi andava a sentirlo, rideva, lo trovava indubbiamente letterario, ma non lo pubblicava; Catalano non si accompagna alla musica suonando alla chitarra, o cantando, o rappando, anche se è un campione delle poetry competition. Sognava di diventare una rockstar e ha cominciato con un gruppo nella stagione del rock demenziale. Non ha la crudeltà autodistruttiva di Freak Antoni, infatti è ancora vivo.

Ha cominciato cabarettando accompagnato dal cantautore genovese/torinese Federico Sirianni, e dal 20 gennaio 2018 parte per un tour italiano con Dente («Non un reading, non un concerto, non una commedia dialettale e nemmeno uno spettacolo circense, non un balletto, un workshop, uno spogliarello burlesco e neppure una dimostrazione di prodotti di bellezza o aspirapolveri: il cantautore emiliano e il poeta torinese incrociano chitarra e penna, per parlare d’amore a modo loro»).
Ha infine avuto la sua celebration nell’auditorium della Scuola Holden di Alessandro Baricco: ha esordito dicendo che quello spazio gli piace un casino, e che quando avrà preso ancora più diritti d’autore se lo comprerà, e ne farà il loft dove vivrà. Valerio Magrelli, poeta della bianca Einaudi e poetissimo della società letteraria italiana, quando è uscito il suo Ogni volta che mi baci muore un nazista si è costretto a recensirlo su “la Repubblica” e a dirne abbastanza bene sino una perfida chiusa finale. Ma una autrice Einaudi, Michela Murgia, implacabile stroncatrice, lo ha elogiato nella sua rubrica nella trasmissione televisiva Quante storie su Rai3 dopo averlo scoperto al Circolo dei Lettori risalendo la lunga coda di pubblico in attesa di entrare a un reading di questo tipo. Catalano tiene ora ogni domenica sul nuovo, gramelliniano inserto torinese del “Corriere della Sera” una spiritosa rubrica di consulenza amorosa, “Gli amori ai tempi di Torino”.
Catalano è un poeta comico, merita di entrare nella nostra genealogia letteraria di poeti comico-realistici, sì, dopo i giullari anonimi, e Cecco Angiolieri; non è un clerico ma certo vaga molto, ormai, di teatro in teatro. Sta con Trilussa e Freak Antoni nel pantheon delle argute risate e delle consce bevute. Si limita a tanti tanti baci e il cazzo lo nomina come interiezione, ma si capisce che potrebbe andarci giù esplicito come il Baffo. Non è la Comedia di Dante, ma anche Dante non ebbe timore di censire condotte scandalose.
Catalano della torinesità ha l’understatement violato nella storia letteraria di Torino soltanto da Baricco; di Gozzano ha un po’ di ironia erotico-malinconica, ma non ha nulla da rievocare, né con struggimento né con grazia: buffamente inclemente con se stesso, adora tutte le donne che bacia, cui dice spessissimo che sono bellissime; le donne sono ologrammi che hanno lasciato il suo letto la mattina, o che non ci sono entrate la sera; sono intime e insieme sfuggenti, se ne percepisce una regalità tirannica, che il poeta buffo infiora e deflora, amaramente certo che nessuna resterà da lui, un poeta con la barba. Certamente c’è il Ronald Laing di Mi ami? e lui dichiara di venire da Prévert, e la lingua parlata e pop di Catalano, la sua parlata non teatrale con erre moscia nei suoi reading saporitissimi per chi vuole è piena di letteratura, anche con un po’ di Pasolini:

Ciao belle labbra lontane
Il vecchio Pier Paolo
sarebbe stato fiero di noi
vederci baciare
sotto il sole della grande città capitale
sotto quel sole di periferia
tu
e quel vestitino leggero
che quasi il vento
se lo portava via
io
che non mi facevo capace
di quant’eri bella da fare paura
Non credo che siamo di fronte a un revival della poesia. Quello che è certo è che molti poeti hanno capito che solo riabbracciando teatro e musica e voce e pubblico si può testimoniare con il proprio corpo che la poesia è una dimensione per riflettere sul nostro vivere. Ancora a Torino uno scrittore, Dario Voltolini, dopo gli anni in cui aveva fondato con Baricco la Scuola Holden, dopo gli anni di romanzi con Feltrinelli, si è nascosto nel silenzio, e si è seduto negli angoli ombrosi dei bar e delle vinerie di Torino a guardare gli altri e a esplorare se stesso. Nel settembre 2017 l’Einaudi che ignora Catalano ha pubblicato un “racconto in versi” che definirei un poemetto onirico e ondeggiante nella memoria dolorosa e famigliare: Pacific palisades è stato portato in scena al festival Romaeuropa da Alessandro Baricco, con le musiche live di Nicola Tescari ed è andato in prima serata su Rai3.
Il testo recitato sul palco dall’amico scrittore non è lo stesso del libro: Baricco ne recide il dolore e la miserabile compassione per gli altri e per sé, la leggendarietà opaca e sbiadita di santo bevitore, e ne fa una apollinea e delicata suggestione di memorie, di personaggi in una città. Le pacifiche palizzate di Voltolini (ricordo di una località sull’oceano californiano) sono quella barriera che mettiamo tra noi e il mondo, per proteggerci dal dolore; ma non è un muro, e neanche alto, è una palizzata che le ondate dell’oceano possono trafiggere, spingendo con violenza emozioni che non volevamo nella nostra più vulnerabile, inconscia intimità; e l’amore spesso è l’ondata più imponente, che ci lascia rovesciati al suo rifluire. Questo concept con cui Voltolini ritorna ha bellezza poetica, e immane delicatezza, insieme pietosa e impudica verso sé.
Tempest, Catalano si sputtanano sui palchi, lei con grandezza shakespeariana, lui con dimessa ma gagliarda autoironia. A Pacific palisades mancano ancora la voce e la presenza di Dario Voltolini.
Tempest, Catalano, Voltolini certo beneficiano del teatro, della musica, della televisione, di Instagram e di YouTube: ma è la poesia che si espande e si fa vedere. La loro audience non è di adolescenti che non leggono e che hanno bisogno di poesia che interpreti i loro turbamenti e le loro tristezze.
Invece ci sono “poeti” che vanno a capo con i loro pensierini, e li chiamano versi e quindi poesia, che vanno su un palco con la loro chitarra e scrivono anche canzoni melodiche come Gio Evan (al secolo Giovanni Giancaspro), che hanno centinaia di migliaia di contatti in rete e vengono ora pubblicati da Fabbri Editori, sorella della Rizzoli di Catalano ingoiata da Mondadori.


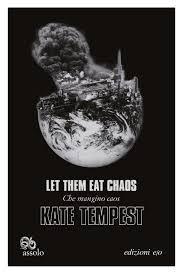
E Fabbri pubblica anche Love her wild del misterioso e mascherato Atticus the Poet, che su Instagram posta fotografie in bianco e nero gotico-romantiche glam con i suoi brevissimi pensieri con tanti a capo. Sul libro di Atticus c’è una fascetta che rassicura i nostri Romei e Giuliette che Atticus è un grande poeta, firmato Francesco Sole. Non sapendo chi costui fosse indago e scopro che all’anagrafe egli è il ventiduenne Gabriele Dotti, belloccio con voce educata televisivamente che ha inondato YouTube con le sue “poesie” pubblicate da Mondadori! “Francesco Sole” avrebbe tradotto Atticus, lui, un “progetto” della agenzia di management televisivo di Francesco Facchinetti figlio del Pooh, apparso su Canale 5 accanto a Belen Rodriguez nel format Si tu que vales; i duri e puri youtubers si sono indignati che tale giovinotto venisse mendacemente lanciato in tv come un “fenomeno fattosi da sé sulla rete”. Una tv che ha lo stesso proprietario (Mediaset) di Fabbri, Rizzoli, Einaudi e Mondadori.
In questa personale odissea tra i poeti “popolari”, di lettura in lettura, di video in video, sono così finito in un dilemma sgradevole: gli adolescenti che non leggono più, ma che vivono amore e tristezza autentici, se consumano sul web o addirittura in libreria questi pensierini carini e senza cultura credendoli “poesia” (visto che Mondadori stampa “poesie” sulla copertina di “Francesco Sole”) incontreranno mai la passione stupenda di Kate Tempest? L’autoironia sentimentale di Guido Catalano? Le sfumate reminiscenze dolorose di Dario Voltolini? In quale punto della “rete” si apre una voragine spaventosa tra la letteratura e la letteratura fake?
Ritrovo Pasolini: «La poesia non è merce perché non è consumabile. Non è prodotta “in serie”: non è dunque un prodotto. E un lettore di poesia può leggere anche un milione di volte una poesia: non la consumerà mai».
Riapro, né pessimista né ottimista, Let them eat chaos:
È la Generazione a Noiaunica
il prodotto della pubblicità occulta
e della manipolazione,
una pallottola per tutti. Il brutale dovere dell’assistenza,
coraggio! Scarpe nuove! Belle acconciature.
stronzate
canzoni
smielate
e selfie
e selfie
e selfie









