
A Ja Ljublju SSSR / Massimo Zamboni, La trionferà
Per metà della lettura, La trionferà di Massimo Zamboni assomiglia a una sorta di anti-Guareschi. È la rievocazione, da sinistra, dell’esistenza storica di un mondo che oggi sembra quasi fantastico, ormai mediato dalla nostalgia e dalle suggestioni dei film, della letteratura e della musica, di cui anche la parabola dei CCCP-Fedeli alla linea fa parte. Parliamo della saga del comunismo emiliano, vista dalla prospettiva di Cavriago, autentica piccola Mosca della pianura emiliana, ben nota per presentare nella topografia locale una piazza Lenin con busto del rivoluzionario russo ancora oggi al suo posto, per quanto sotto forma di “multiplo”.
Ecco così un’antologia di personaggi e di situazioni che, seppur scoperti dalle ricerche dell’autore, ci sembra di conoscere benissimo. Il mitico sindaco Arduini di inizio secolo, per esempio, archetipo del socialista buono e magnanimo che la storia (sotto le vesti del fascismo) si incaricherà di maltrattare fino all’indegnità. Abbo Partisotti, “Principe”, partigiano comunista tutto d’un pezzo che nel corso del secondo Novecento i pezzi li perde uno per uno a partire dalle rivelazioni di Kruscev su Stalin. O Valentina Tereshkova, leggendaria prima donna nello spazio, che proprio a Cavriago viene a rendere omaggio all’ortodossia dei paesani. Per non parlare delle epopee della costruzione della Casa del Popolo prima, del cinema popolare poi, e perfino del dancing “Caprice” negli anni sessanta – tutti edificati letteralmente mattone su mattone dalla popolazione locale. In tutta questa prima parte più che il “cosa” è bello il “come”. Occorre infatti dire – e forse non lo si è fatto abbastanza da quando ha cominciato a cimentarsi con la letteratura – che Massimo Zamboni è uno degli scrittori italiani dotati di più stile personale. La sua scorrevolezza discorsiva è impreziosita da una lingua niente affatto ovvia, costruita con un vocabolario che corteggia talvolta l’obsoleto, ma mai per capriccio, sempre per una necessità intrinseca di rapporto tra la cosa raccontata oggi e il passato. Uno schema comunicativo che, tutto sommato, era quello dei CCCP: usare un codice per sabotarlo dall’interno, ma rimanendogli in qualche modo fedele. Essere moderni creando un’eco arcaica. È un’intenzione apertamente dichiarata nell’incipit: “Noi, questa terra, la sua unicità. Cantarla per costruire non una memoria, ma un’epica della memoria, magnificarla come nell’antico e con quel canto creare un fondamento per ciò che sarà”.
Poi, a metà del libro, avviene qualcosa. Il narratore entra nella storia. La vicenda esistenziale e politica dei comunisti emiliani diventa quella di Zamboni stesso: nato nel ’57, figlio di famiglia di destra (ha raccontato questa parte della storia in L’eco di uno sparo), giovane inquieto come tutti noi nei primi anni settanta. Il gesto di rottura nei confronti del suo mondo lo compie iscrivendosi alla FGCI (senza peraltro avere il coraggio di confessarlo in casa…), in questo diverso da molti di noi, attratti piuttosto dal fascino dell’extraparlamentarismo. Ma poi quello che Zamboni incrocia è lo stesso di tutti: cose più forti della politica, o che la attraversano in modi che non si sa come definire, come il ribellismo rock.
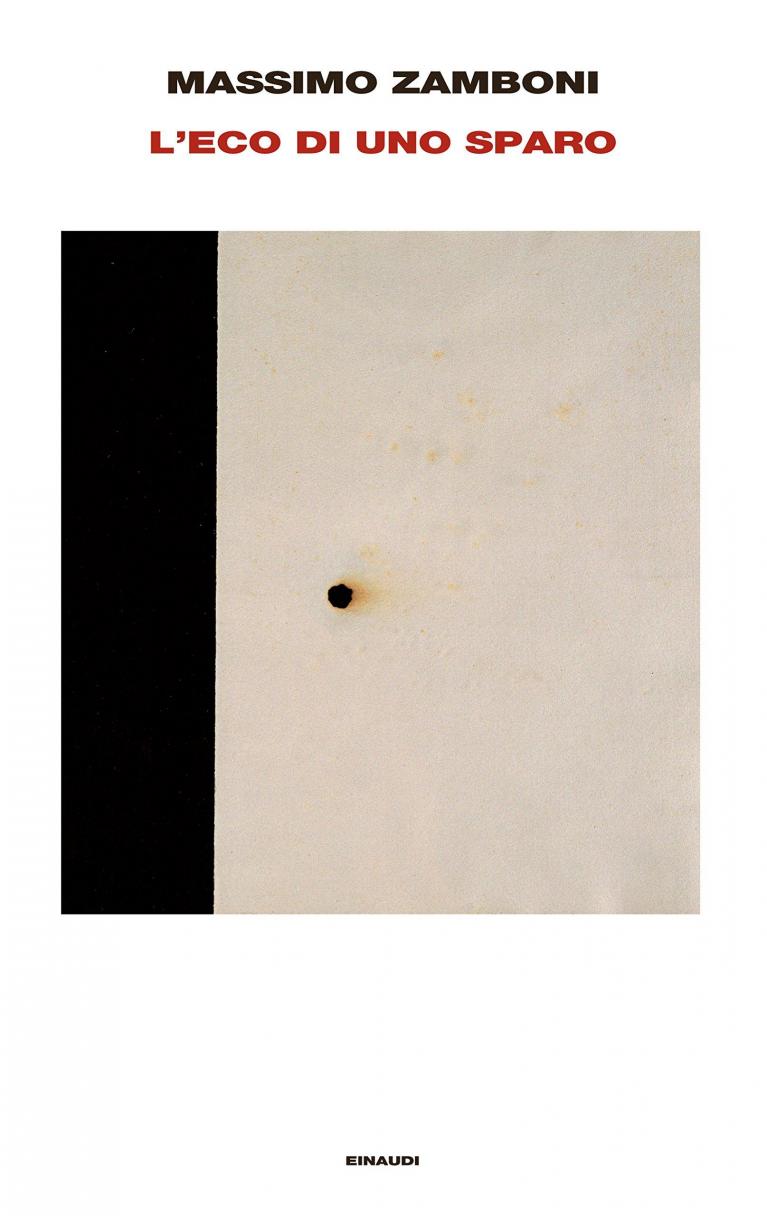
A quel punto l’epica si mescola con il memoir, e tutto quello che prima poteva apparire bonariamente oleografico diventa invece carne e sangue di un coming of age. E non solo. Perché parlare di comunismo emiliano significa poi fare i conti con tutto il resto della vita di quella generazione: l’ortodossia, la ribellione, la “diversità” del PCI, i compromessi – storici, ma anche più banalmente quotidiani –, il 1989, il tracollo. E dal libro vien fuori un fatto che riguarda anche tutti quelli che, come me, al Partito non si sono mai iscritti. Potevi contestarlo e combatterlo, il PCI, ma era una casa collettiva.
Ci stavamo dentro tutti, che ci piacesse o meno: allo stesso modo in cui potevi detestare i tuoi genitori ma non potevi fare a meno di riconoscere che quella era la tua storia. Il PCI infondeva la stessa sicurezza della Chiesa: ci sarebbe sempre stato, non ci si poteva immaginare un mondo senza. Tanto più in Emilia, dove il buongoverno di sinistra aveva creato un piccolo Eden laico. Un tetto sotto il quale stare, abbastanza tollerante da reggere anche la contestazione più radicale: penso adesso a cosa è stato il convegno contro la repressione a Bologna nel 1977. Lo si poteva anche combattere, il PCI, perché – alla fine – si era certi che ci sarebbe sempre stato. Quando tutto si disfa, è come quando muoiono i tuoi. Sei costretto ad arrangiarti e non assomiglia affatto a come te lo immaginavi. Ma se uno è cresciuto in quel contesto, alcune cose le ha capite. Per esempio, che si può perdere senza rinnegare quello che si è. Il 31 dicembre 1991 Massimo Zamboni va in piazza Lenin a Cavriago. C’è una specie di veglione, non dissimile dai molti che si celebrano in Italia in quel momento: musica danzante, spumante, botti. Solo che a mezzanotte dagli altoparlanti esce l’Internazionale e tutti i presenti la cantano.
Poi viene liberata una bandiera rossa legata a dei palloni e la bandiera decolla nel cielo nero della notte di San Silvestro, non a caso patrono di una categoria inevitabilmente comunista come i muratori e i tagliapietre: “Una dose di commozione, una di sarcasmo, una di pratico ed emiliano senso del disincanto. (…) siamo nell’anno nuovo, stanotte si canta, si balla, si beve. Io sono con una ragazza, i fuochi scoppiano, ci baciamo, siamo sposati da febbraio, io sono disoccupato, lei licenziata, il comunismo è finito, qualcosa inventeremo”.
È una scena che rimbalza nell’immaginario come una specie di complemento a quella dell’enorme bandiera rossa sull’aia in Novecento di Bertolucci. E che personalmente mi rivela perché si può fare a meno del comunismo, ma non dei comunisti.
Leggi anche
Marco Belpoliti, Massimo Zamboni. L'eco di uno sparo









