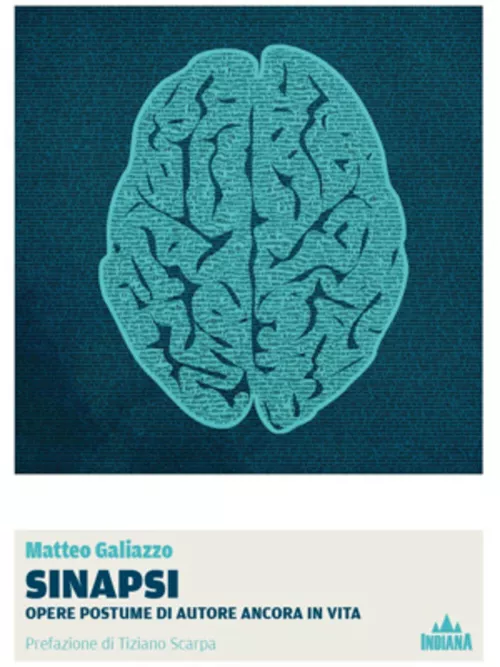Matteo Galiazzo. Sinapsi
C’è un libro di Vila-Matas, Bartleby e compagnia, in cui lo scrittore catalano passa in rassegna quelli che definisce gli “scrittori del NO”, ovvero coloro che, come lo scrivano di Melville, a un certo punto decidono di abbandonare la pratica della scrittura. I motivi sono molti: dalla constatazione dell’insufficienza del linguaggio al desiderio di liberarsi in un solo colpo sia dell’angoscia della scrittura che delle cattive maniere dei colleghi letterati, fino alla sacrosanta affermazione di Oscar Wilde, per cui “non fare assolutamente niente è la cosa più difficile del mondo, la più difficile e la più intellettuale”. Ecco perché di questa raccolta di scritture disperse su riviste varie e “postume in vita” dell’ex-cannibale e scrittore genovese Matteo Galiazzo, Sinapsi (Indiana 2012, p. 301, prefazione di Tiziano Scarpa, 16,50 euro) l’elemento più interessante è senz’altro la prematura dipartita letteraria dello scrittore, a lungo considerato una delle voci più interessanti della sua generazione e poi sparito dalla scena letteraria (cosa tanto più strana, in un panorama dominato da aspiranti protagonisti che pretendono di scrivere per esistere).
È quindi con malcelata ammirazione verso questo “gran rifiuto” che leggo delle prospettive molteplici dei racconti di Galiazzo (“Matteo Galiazzo ha usato l’arte del racconto per affacciarsi a tutti i punti di vista di tutte le finestre aperte su tutte le strade”) di cui parla Scarpa nella prefazione; poi leggo il primo racconto, Il ferro è una cosa viva, dove è già evidente e più che ammirevole questa capacità di adottare voci e registri diversi, o per meglio dire di trovare una storia e di usare per essa la voce giusta, il tono appropriato. In Il ferro è una cosa viva, per esempio, i due registri: la voce dell’io narrante che cerca il significato di due parole sconosciute e quella dell’amico missionario che insegna alle popolazioni africane i loro riti fingendo che siano riti cristiani, creano un attrito a sfondo linguistico che ci parla di come, per le cose che capiamo, manchino spesso le parole (vedi Hoffmansthal, Lettera a Lord Chandos, grande classico della Letteratura del NO).
A leggere gli altri racconti di Galiazzo, da Sedici gradazioni di nero, in cui un pittore cieco dipinge con cura un quadro tutto nero ma che lui, ingannato dal suo aiutante, crede che sia ricco di colori, a Meteorologia delle sinapsi, dove i protagonisti sono “agiti” da una macchia dentro di loro che li fa parlare in modo incomprensibile, ci si imbatte in storie che parlano spesso di un tradimento dei segni; i segni sono lì, apparentemente a nostra disposizione, ma in realtà sono infidi, ingannevoli, molto più stranieri di quanto possa apparire a un primo sguardo o possa sembrare a uno scrivente inesperto.
Non è in gioco semplicemente una qualità imitativa o ventriloqua, che pure esiste in Galiazzo e dà risultati di grande intelligenza e arguzia; è che “io” è un’altra voce, quasi sempre di origine sconosciuta. Questa voce altra e spossessata, sembra che si leghi strettamente alla trama pur di non trovarsi, di non riconoscersi. Matteo Galiazzo non ha una voce: ne ha troppe, talmente spontanee e generose che rinunciarvi, come un Bartleby che soffre della troppa facilità con cui ricopia le sue carte, è anch’esso fin troppo facile.