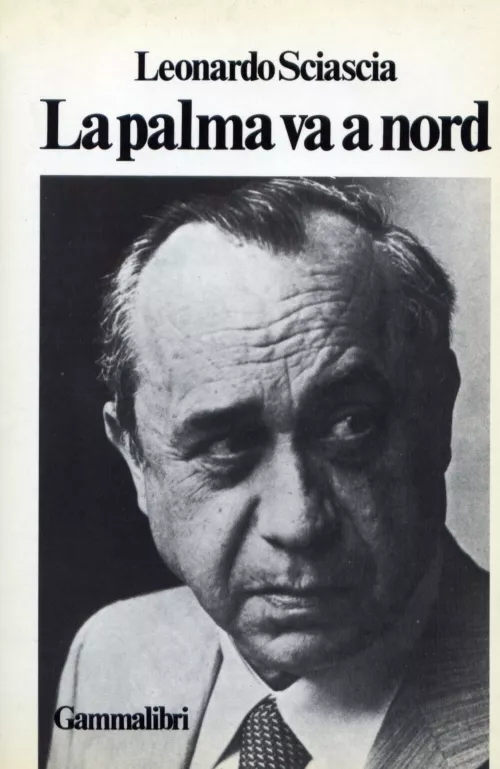Sciascia. La palma va a nord
Il sospetto non è l’anticamera della verità, avrebbe urlato Leonardo Sciascia sino allo stremo. Motivo in più per sentirne la mancanza in questi giorni in cui avrebbe compiuto 90 anni. Certo però che fa strano. La palma va a nord è l’unico suo libro mai ristampato, ed è certamente quello più duro: politicamente, eticamente, stilisticamente. Quello più inattuale. Da qui la voglia di rileggerlo ancora, sospettando di chi, per volontà o per caso, fa finta di ignorarlo. Basti, per pietà, questa frase, estratta da uno dei testi di quel libro che ripresentiamo: “certo, a uno che polemizza col silenzio, sarebbe saggio rispondere col silenzio. Ma in certi momenti non si può essere saggi; e io, poi, raramente lo sono”.
Gianfranco Marrone

La palma va a nord
Mi capita ancora di scrivere dei versi. Ma ormai, forse, quando ho qualche difficoltà con la prosa. Vent’anni fa i versi erano per me il grezzo della prosa. Avevo più difficoltà, con la prosa. Oggi mi illudo di averne di meno. Affare (a fare) difficile, la prosa.
Questa considerazione mi viene dall’aver ritrovato un foglietto di versi scritto nel ‘60 - e sono versi che hanno trovato condensazione in una battuta del Giorno della civetta. Lì trascrivo qui perché hanno una vaga rispondenza a fatti di oggi, non perché valga la pena di salvarli:
Il poeta Abu-Hatem, es Segestani
di Persia o di Sicilia (la questione
è rimasta in sospeso), scrisse
lungo elogio della palma: albero
foggiato dalle mani di Dio
a immagine dell’uomo, come Adamo
a immagine di Dio; albero eccelso
che segue la marcia dell’Islam
poiché è dono al credente, e in paradiso
darà ombra dolcissima a fanciulle
dagli occhi neri e casti
che nude defluiranno tra le mani
del credente vero.
Gli scienziati
dicono invece che la linea della palma
non ha niente a che fare
con la marcia dell’Islam, e si sposta
di cinquecento metri ogni anno
verso il nord.
Personalmente,
non giurerei che la marcia della palma,
non ha niente a che fare con l’Islam,
né che avanza verso il nord
solo di cinquecento metri ogni anno.
Probabilmente, a sbalzi e ad arresti,
la media della marcia è più celere ...
Non difendo questo uovo
L’anno scorso, mentre si svolgeva la polemica tra Giorgio Amendola e me, il giornale Paese Sera pubblicava una mia fotografia, già nota per essere stata pubblicata nella pubblicità dell’editore Einaudi, con questa dicitura: “Matteo Pedicini, capo dell’Anonima sequestri”. Amici miei telefonarono subito al giornale: ma non mi risulta che il giornale abbia pubblicato la rettifica e si sia scusato con i lettori e con me, né privatamente mi sono state fatte delle scuse. Forse qualcuno, nel giornale, riteneva che quello fosse il modo più intelligente di partecipare alla polemica. A me, e a tutti quelli che notarono la cosa, parve un modo puramente teppistico.
Domenica 19 marzo Paese Sera è tornato a occuparsi di me. Il suo direttore, Aniello Coppola, ha polemizzato, come dice l’Unità con letteraria espressione, col mio silenzio. Il mio silenzio riguardo al sequestro dell’on. Moro. E certo, a uno che polemizza col silenzio, sarebbe saggio rispondere col silenzio. Ma in certi momenti non si può essere saggi; e io, poi, raramente lo sono.
L’articolo di Coppola consisteva in un rifacimento della favola di La Fontaine sulla cicala e la formica, ma trasposta da un significato economico a un significato politico: io sarei stato la cicala e, secondo Coppola, tacevo - forse spaventato - di fronte alla massa di formiche che si muoveva in solidarietà e cordoglio per gli agenti uccisi e l’on. Moro rapito. Le formiche, inutile dirlo, erano la classe operaia, erano il popolo.
È di molti uomini di sinistra il vedere classe operaia e popolo come formiche: a livello delle proprie scarpe. Comunque, a me va benissimo essere paragonato alla cicala. Di fronte alla favola di La Fontaine, la mia simpatia è sempre stata per la cicala. E poi Coppola avrebbe dovuto tener conto di quel proverbio che, a somiglianza di quello che prescrive di non molestare il can che dorme, raccomanda di non toccare la cicala che tace (quest’ultima osservazione la debbo alla confidenza di un autorevole comunista: non ne faccio il nome, ma mi par giusto confessare che non è mia). Più tardi, in risposta alla mia risposta, Coppola scrisse: “Leonardo Sciascia sfugge alla questione che gli avevo posto”. Chi ha voglia di leggere il suo articolo, o di rileggerlo, cercherà invano la questione che dice di avermi posto. Mi ha semplicemente attaccato: gratuitamente e scioccamente. La
questione me la pone nel suo secondo articolo, ed è questa: “Vale la pena di difenderlo questo nostro Stato?” Dieci mesi fa ho detto: così com’è, no, non vale la pena di difenderlo. Oggi dico: così come va diventando, siamo noi che dobbiamo difendercene.
Dieci mesi fa mi appariva come un guscio che racchiudesse, per dirla vittorinianamente, putredine e morte. Oggi mi appare come un guscio vuoto che può essere da un momento all’altro, e forse senza che ce ne accorgiamo, comunque riempito. Comunque; ma, in ogni caso, per noi pericolosamente. E dicendo noi intendo tutte le persone che in questo momento sentono e pensano come me; e sono tante, più di quanto un Coppola possa immaginare. E non sono formiche. E da questo punto non parlo più con Coppola e con coloro che la pensano (si dice per dire) come lui. Parlo, appunto, con coloro che sentono e pensano come me, con i lettori dei miei libri (che sono tanti, tanti), con tutti quelli cui la pena per la sorte dell’on. Moro, il dolore per la scorta massacrata, l’angoscia per la violenza dilagante, non impediscono di vedere le cose come sono e come stanno per essere; con tutti quelli, insomma. che hanno memoria e giudizio.
Nella campagna per le ultime elezioni politiche, che io ho fatto assieme ai comunisti, mi sono sempre, a ogni comizio, dichiarato contrario al compromesso storico e per un governo di salute pubblica in cui avessero parte i comunisti.
Una volta, dopo un comizio, un gerarca comunista mi sussurrò il consiglio di non parlare di governo di salute pubblica: evocava la Rivoluzione francese, la ghigliottina, la gente se ne intimoriva, si ritraeva. A me pareva piuttosto il contrario: che la gente, appunto, volesse sentir parlare, se non di ghigliottina, di giustizia, di legge uguale per tutti, di pulizia: di quei principi, insomma, che erano stati acquisiti da quella rivoluzione e che, nella impossibilità di farne un’altra, senza bisogno di farne un’altra, potevano essere richiamati e applicati. Del resto, la Costituzione della Repubblica italiana stava lì, con tutti quei principi dentro e anzi portati più avanti. Poiché quello che stava accadendo in Italia era appunto questo - lo Stato che stava svuotandosi della Costituzione - mi pareva fosse operazione di salute pubblica che tutti i partiti che erano stati artefici della Costituzione ritrovassero quel compromesso che valesse a restaurarla e magari a rifondarla, e facendo principalmente leva sulla idea della giustizia: della giustizia sociale e della giustizia in quanto amministrazione, in quanto giustizia penale.
Questo era anzi il punto da affrontare immediatamente. Senza dilazioni: l’attenzione della giustizia penale, della legge che cadesse uguale per tutti, che prontamente e inflessibilmente colpisse ogni maneggio irregolare e fraudolento della cosa pubblica. Di questo la maggioranza degli italiani si sarebbe appagata. Troppo poco. diranno i rivoluzionari: ma in un Paese come il nostro, soltanto l’applicazione della legge sarebbe un fatto rivoluzionario. Quello che Pasolini chiamava il ‘processo al Palazzo’, bisognava che il Palazzo se lo facesse in parte da sé. In parte con l’aiuto degli altri.
L’esito delle elezioni, purtroppo, non sconfortò il Palazzo. Nessuno, dentro, si mosse per cominciare il processo; né gli altri mossero incitamento a che cominciasse. La mia esperienza al consiglio comunale di Palermo fu, in tal senso, significativa: non solo fu dichiarato apertamente, da uomini responsabili del PCI, che non si sarebbe fatto il processo al passato, ma nulla vidi muoversi che almeno annunciasse il processo al presente.
Le elezioni politiche avevano dato ai due più grandi partiti italiani - a ciascuno e a entrambi, mutuabilmente, simbioticamente - la certezza di essere stati approvati così come erano. Restarono dunque a specchiarsi, l’uno nell’altro. Senza curarsi della Costituzione che marciva dentro il guscio dello Stato. E questo è stato per me, nella polemica che ho avuto con Amendola e con altri comunisti, un vero rompicapo: com’è che sostenessero che lo Stato è nostro. Di tutti, quando - e bastava la sola specula della giustizia penale - a evidenza era dimostrato che non era nostro, che non era di tutti. In questo senso io dicevo che non valeva la pena di difenderlo. Ma dicevo anche - e lo dicevo allora come lo dico ora - che bisognava difendere noi stessi, sentire il dovere verso noi stessi di non avere paura: e che soltanto per questa difesa, per questo dovere, superando la mia innata e poi ragionata paura di giudicare, io sarei andato giurato al processo di Torino.
Lo dicevo a chiare lettere. L’ho ripetuto in televisione un mese fa. Ma grande è la malafede e l’imbecillità e il fanatismo di cui si è circondati. Con mezzi terroristici, polemizzando col mio silenzio. Vogliono che io dica: o che bisogna difendere questo Stato così com’è, o che hanno ragione le BR. Tutta la mia vita, tutto quello che ho pensato e scritto, dicono che non posso stare dalla parte delle BR. E in quanto a riconoscermi nello Stato così com’è (e sarebbe esatto dire com’era fino al rapimento dell’on. Moro), continuo a dire di no.
Capisco che ci sia, da parte dei fanatici, la esigenza di etichettarmi una volta per tutte o come rivoluzionario o come reazionario.1 fanatici hanno bisogno di star comodi. Per mia parte, dico di essere semplicemente, in questo momento, un conservatore. Voglio conservare, di fronte allo Stato che se ne è svuotato, la Costituzione. Voglio conservare la libertà e la dignità che la Costituzione mi assicura come cittadino; e la libertà di cui ho goduto come scrittore, e la dignità che come scrittore mi sono guadagnata.
Questa libertà e dignità sento oggi che sono in pericolo. In quanto cittadino capisco - ma non approvo - che molti siano disposti a barattare libertà e dignità per un po’ di ordine pubblico, di sicurezza: in quanto scrittore mi batterò affinché questo baratto non si compia. Metto in conto la sconfitta, e anzi la prevedo: ma non posso che battermi, finché avrò un margine, sia pur piccolo, sia pure insicuro. Il ripristino dell’ordine pubblico, da noi è stato sempre pagato caro: a prezzo di un più vero e profondo disordine, che corrode anche le menti più lucide e le coscienze più nette. Ed è già cominciato, a guardar bene.
E in conclusione. Sono stato vicino ai comunisti, e non sono per nulla anticomunista. Ma quello che accade in loro, e che attraverso loro sta accadendo al Paese, mi inquieta molto. E dovrebbe inquietare anche loro, o almeno quelli di loro che veramente credono nella democrazia, nel pluralismo e in tutte le nobili cose che hanno detto in questi anni.
La mia affermazione che lo Stato è oggi un guscio vuoto, di cui mostreranno forse di scandalizzarsi-loro lo fanno ogni giorno accortamente, velatamente: la salvezza dello Stato la dicono nelle loro mani, nelle mani della classe operaia, nelle mani delle loro masse. Questo è - facendo mia una espressione di Moravia - un già visto rovinoso, un già visto tragico. Pretenderei da loro, dovrebbero pretenderlo tutti, dovrebbe soprattutto pretenderlo la classe lavoratrice, un fatto non già visto: che entrassero nel governo dello Stato non per la porta della repressione.
Nello svolgersi degli avvenimenti, nei prossimi giorni o nei prossimi mesi, sapremo se questa pretesa attinge al possibile o all’impossibile, ma il dovere verso noi stessi, in questo momento, è quello di avanzarla direttamente, senza paura.
Panorama, aprile 1978