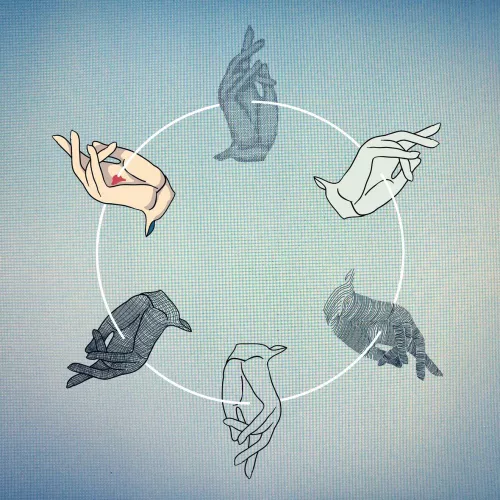Sto meglio così / Tre anni senza Facebook
Ai primi di dicembre del 2014 mi sono disiscritto da Facebook d'istinto, senza solenni proclami (non ci vedevo nulla di solenne, e sono allergico da tempo ai proclami). Forse avrei potuto avvisare, per garbo, le persone che mi hanno seguito lì per tanti anni: d'altro canto, basta una ricerca su Google per ritrovarmi.
Il punto è che Facebook mi aveva stancato da tempo, sia per la quantità di interazioni che mi sentivo chiamato a gestire sia, soprattutto, per una questione di design. Il coacervo di immagini e parole, l'abbondanza di notifiche, l'attenzione spasmodica al tempo presente, la difficoltà a recuperare i contenuti passati, i troppi video, lo scrolling infinito, la mancanza di asimmetria fra relazioni (a differenza di Twitter, dove follower e following sono distinti). Da allora sono rientrato di tanto in tanto, di sfuggita; ma ogni volta ho disattivato il profilo.
So cosa state pensando. Gli articoli che parlano della propria assenza da un social network hanno sempre un tono paternalistico: o si lanciano in sermoni sulla superiorità della vita "reale" (come se il digitale non fosse reale), inneggiano al disconnessionismo spinto, blaterano attorno all'importanza del ritrovato silenzio contro le inondazioni di gattini e baggianate virali eccetera.
Più di tutto, sono pervasi da una fastidiosa aura di auto-indulgenza: come se Facebook fosse un mostro capace di irretire le coscienze, impedendo un suo uso moderato e ragionevole. Naturalmente non è così. La responsabilità di come scegliamo di abitare il digitale dipende da noi soltanto, e molte persone lo fanno senza patemi o deliri.
Il mio scopo, in effetti, è più modesto. Vorrei solo mettere in fila alcune riflessioni laiche su come è cambiata la mia vita in questi tre anni; cosa ho guadagnato e cosa ho perso soprattutto a livello linguistico.
1. Contro la lettura polemica.
Il 5 dicembre 2017, Francesco Farabegoli ha scritto un bel pezzo dal titolo Ed è polemichetta. Discute il modo in cui il tempo viene vissuto su Facebook, evidenziando la predilezione del sistema per il presente e le sue scarse concessioni al passato.
Ecco la definizione del concetto-chiave:
La polemichetta è ovunque. È sistemica, orizzontale e pervasiva; riguarda ogni campo dello scibile, interessa quasi tutti e non lascia quasi mai traccia di sé fuori dall’ecosistema in cui si è generata. Nella sua forma più pura è l’applicazione di un’ideologia, di una visione del mondo, alle piccole puttanate che succedono da mane a sera. È l’effetto secondario – tendenzialmente indesiderato ma per molti aspetti piacevole – di una narrazione: una questione complessa deve potersi ridurre al suo racconto, a un singolo gesto a cui aderire oppure no. La semplificazione del racconto porta alla semplificazione – e quindi alla cristallizzazione – dell’opinione in merito al racconto, e per induzione della questione tutta. A un certo punto qualcuno rende pubblica la propria opinione, e da lì in poi è una slavina di sostegni e confutazioni.
In sostanza, è la caricatura di una vera e propria discussione; è effimera e marginale per natura; e "più che costruzioni sul lungo periodo, produce semmai una specie di fornitura just-in-time di tanti piccoli J'accuse monodose".
La tesi è molto suggestiva. Non so se sia interamente corretta o se sia applicabile soltanto a una fetta di Facebook; io mi limito a osservare che il modo in cui leggiamo — ancor prima di quello in cui scriviamo — è stato così influenzato da questo automatismo che ne esce malridotto, come corroso da un sospetto primordiale.
Su Facebook si legge sapendo di potere, di dovere implicitamente rispondere a chi afferma qualcosa. Si legge come coautori, non come semplici lettori; si legge con una fortissima tendenza alla polarizzazione delle opinioni, che è la premessa al "Adesso gliene dico quattro". (Anche su Twitter, mi si dirà: vero; ma il modo in cui è disegnato Facebook rende questa cascata di conversazioni più invadente. Forse è un semplice dato personale, ma la coazione a commentare mi è sempre apparsa più radicale, quasi più feroce, su Facebook).
Non voglio dire che sia sempre così; ma spesso lo è.
Ora, per quanto mi riguarda il discorso è molto semplice: non volevo e non voglio più cedere a tale impulso. Leggere è un affare serio, che comporta un grado di umiltà veicolato dal silenzio e dall'ottusità, per così dire, del testo: non ho modo di dire cosa penso riga dopo riga a Stig Dagerman o a Nina Berberova o a Ludwig Wittgenstein, e in fondo è un bene. Può essere utile avere la possibilità di aprire sempre un dibattito, ma in molti casi diventa un alibi per la propria disattenzione: un po' come in questa vignetta di Tom Gauld.
2. Contro la scrittura obbligata.
Questo vale per l'attività speculare, appunto quella con cui da qualche anno mi guadagno da vivere e che per me è sempre stata fondamentale: scrivere.
La conseguenza più preziosa dell'uscire da Facebook non è stata l'aumento quantitativo e qualitativo del tempo e della concentrazione — c'entra anche quello, certo — bensì la fine della coazione a dire qualcosa pubblicamente: non tanto in forma di risposta ma di semplice condivisione. Credo sia il motore fondamentale di tutti i social media. L'immobilità è sinonimo di morte, nel regno animale; e dunque muoviti, alimenta il tuo profilo, rendilo il più vivo possibile.

Illustrazione di 3palec.
Non si tratta per forza di un impulso ad annientare la propria privacy e condividere qualsiasi cosa. Lo sottolineava bene Massimo Mantellini: "Mai, in nessuna epoca passata, abbiamo esposto agli altri, più o meno volontariamente, parti tanto ampie di noi. Sarà importante ricordare che si tratta comunque di un iperbiografismo marginale. Esponiamo molto, talvolta moltissimo, ma solo quello che vogliamo". Inoltre, ho sempre trovato la censura preventiva un affare piuttosto moralista.
Ciò nondimeno, su Facebook si scrive; e si scrive parecchio. Si caricano video, immagini — ma soprattutto si scrive e si interagisce. Con il tempo mi sono accorto che elaboravo una quantità di parole inutili o sommarie che danneggiavano il mio lavoro quotidiano; mi rendevano più superficiale, più reattivo nel senso peggiore del termine, meno riflessivo. Soprattutto, mi rendevano impreciso. Anche il mio scetticismo ne usciva deteriorato.
Dovevo dire qualcosa e dirlo subito perché altrimenti — be', che ci stavo a fare lì? Cercavo di condividere articoli interessanti, eppure temo che la maggior parte dei miei contributi sulla piattaforma si limitava a osservazioni volanti o video musicali.
A questo vanno aggiunti i casi limite, quando mi prendeva un improvviso bisogno di affetto e conferma. Guardami, sono qui. Oggi mi sembra inconcepibile che mi sia messo a scrivere scemenze, fare battutine, postare vecchie foto, copiare frasi di Kafka eccetera per questo unico scopo. È tutto quello che ho sempre combattuto da scrittore, e l'ho fatto per anni senza quasi accorgermene. Perché era normale; perché lo faceva chiunque. Come ho detto non c'è nulla di terribile: ma visto da fuori, riassume quel carattere di stranezza che avrebbe assunto molto tempo fa — quando Facebook non esisteva.
C'è di più. Come è stato osservato, la quantificazione delle proprie attività digitali è un aspetto preponderante della nostra giornata online. Offrire la valutazione numerica di qualsiasi contenuto è attraente: ma elimina anche le sfumature e traduce la lettura in applausometro. Può sembrare banale osservare che la verità non è necessariamente affare della maggioranza, e che avere venti like o faccine sbalordite in più di un altro non implica affatto che io sia nella ragione e lui nel torto: ma è una banalità che conviene ripetere.
Anche questo volevo evitare: che le mie parole dipendessero anche solo in minima parte dal loro successo più o meno immediato. Si obietterà che uno status o un commento non hanno nulla a che vedere con un articolo o un romanzo; che i due tipi di elaborazione possono benissimo convivere. È vero, ci mancherebbe altro. E tuttavia, credo che l'abitudine a scrivere ogni giorno alcune frasi con un dato fine — similmente all'abitudine a leggerle — non sia scevra di influenza su tutte le altre.
Proprio come non posso dire a Nina Berberova che ne penso di un suo romanzo a ogni riga, non vorrei mai che la scrittura diventasse un affare di incitamento parziale e quotidiano; che dipendesse dagli apprezzamenti di una ristretta comunità di amici.
Certo i feedback sono importanti, ma ancora più importante per la scrittura è la capacità di isolarsi: un aspetto della vita che ormai risulta assai fuori moda, ma in cui ho sempre visto un elemento positivo. Come ha fatto Dostoevskij a scrivere I demoni senza nemmeno una pacca sulla spalla digitale? Ha fatto.
3. Regalare soldi a Zuckerberg.
Del resto, non voglio nemmeno che le mie parole alimentino gratuitamente il capitale di Facebook. Non tanto per il loro valore in sé, ma quasi per il loro valore numerico — vale per me come per chiunque. Ci ripetiamo da anni che nell'economia digitale dell'attenzione il prodotto e il produttore siamo noi stessi: che per quanto sia bello fruire di tante applicazioni gratuite, gratuite non lo sono affatto — e il loro costo sta nei nostri dati, nei nostri contenuti, nel tempo che doniamo loro ogni giorno.
Ribellarsi a tutto ciò in modo indistinto è piuttosto folle (dovrei chiudere innanzitutto il mio account Gmail), ma è un tema che continuo a vivere abbastanza male, come tutti i temi che hanno a che fare con il capitalismo surrettizio. Uscire da Facebook è stato anche un modo per ricordarmelo, benché certo non il motivo principale.
Questo naturalmente non significa difendere alcun ritorno all'analogico, anzi. Quando tengo dei corsi di scrittura digitale, la prima cosa che consiglio è di creare un proprio sito — anche solo un blog su Wordpress. Basta un minuto e si imparano già diverse cose sul funzionamento della rete e magari su com'è fatta una pagina web.
Ma più di tutto si avrà a disposizione un luogo interamente proprio, che farà da casa madre e da collettore di tutti i propri contenuti: fossero anche un cv, una biografia e qualche foto. Sarà più facile recuperarli con una semplice ricerca su Google, anche dopo anni, perché fuori dal recinto presentista di Facebook; non saranno limitati dalle vaghe norme di privacy di quella piattaforma; saranno linkabili liberamente. Godranno di tutto il bello della rete, insomma.
4. Cosa ho perso.
E tuttavia, uscire da Facebook ha comportato anche qualche perdita.
Ho smarrito il lato positivo di alcune conversazioni che — almeno prima del dilagare della polemichetta di cui parlava Farabegoli — di fatto esistevano. Inutile liquidare quella piattaforma come un covo di pazzi assetati di sangue. Ho smarrito la possibilità di dibattere con semisconosciuti e l'esercizio a difendere il mio punto, anche contro gli argomenti più stupidi o le aggressioni: nulla di piacevole, ma che contribuiva a tenere svegli certi muscoli mentali. E in diversi casi, ho smarrito la possibilità di discutere per via scritta ogni giorno. (Non so ancora se è un bene o un male).
Inoltre, ho anche smarrito una certa percezione del discorso comune; una tonalità del linguaggio, per così dire. Proprio la forma di scrittura reattiva che criticavo sopra, e che comunque fa parte di questi tempi. Frequentarla di tanto in tanto potrebbe non essere una cattiva idea. Non perché desideri imbottirmi di assurdità anti-scientiste (che comunque vengono pronunciate ovunque, al di là di Facebook): ma perché dopotutto questo ordine del discorso esiste ed è assai coltivato. Uscirne è stato anche uscire da un insieme nebuloso ma affascinante di parole, di tic, di litigi, di vita che comunque faceva parte della mia dieta quotidiana — e non sempre era dannosa o mi mandava fuori dai gangheri.
Ancora: ho perso qualcuno che mi dia contro al volo quando serve, pubblicamente. E l'imprevedibile gesto di gentilezza da parte di un semisconosciuto, o il piacere di fare altrettanto. Ma certo non mi manca l'allegra ferocia scritta con cui ci si aggiunge al coro degli insulti; né la lettura passiva di parole che mi deprimono.
Infine, ho perso il getto di articoli interessanti che alcuni contatti rilanciavano. Pochi, per la verità; ma li ho persi. A volte li recupero per altre vie, a volte no.
5. Quindi, oggi.
Oggi sono su Twitter, che governo più facilmente e che non influisce né sul modo in cui leggo né sul modo in cui scrivo. Non so perché; credo abbia a che fare innanzitutto con la brevità del mezzo. E benché i caratteri a disposizione siano di recente raddoppiati, 280 battute spazi inclusi restano sempre poca cosa: inoltre, cerco sempre di condividere link esterni invece di elaborare aforismi arguti.
Tre anni senza Facebook mi hanno privato di una camera di risonanza, ma liberato di un po' di rumore bianco, e della bolla editoriale che vi sta all'interno — e che funziona come ogni altra bolla: pensare che quanto proclamato o discusso da venti persone sia il tema più caldo in tutti i bar della provincia. Mi hanno anche liberato dell'impulso a dire più cose di quante probabilmente dovrei. Del resto una delle distorsioni più pericolose degli ultimi anni — e so che dicendolo rischio il temuto paternalismo, ma amen — è stata proprio quella di equiparare la libertà d'espressione con la sua impellente necessità. La struttura visuale di Facebook induce a considerare questo fatto come dato.
Non esistono obblighi, invece; il mio solo è quello di scrivere bene, e mi pare di scrivere meglio così, senza quel social network. Dopotutto, ricordava di recente Marco Archetti sul Foglio, non si pratica la scrittura letteraria per dimostrare qualcosa, né per inserirsi in un flusso di "consenso generico, generale, generalizzato": proprio il contrario: si tratta invece di coltivare pervicacemente una differenza, la propria differenza.
E quindi, laicamente ed empiricamente, oggi sto molto meglio così.