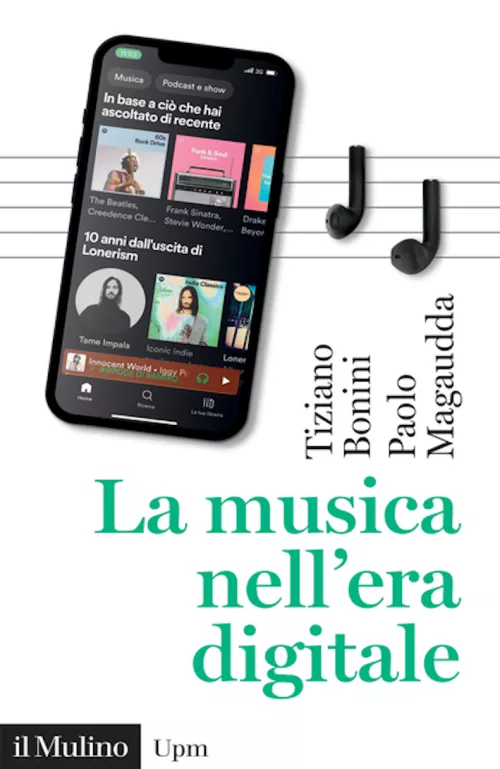100 milioni di canzoni e ascolto sempre la stessa roba
Non so se sono la persona adatta a recensire questo libro (Tiziano Bonini e Paolo Magaudda. La musica nell’era digitale, il Mulino 2023, pp. 216). Mi sono accorto, leggendolo, di essere rimasto parecchio fuori dalla rivoluzione che ha portato la gente ad ascoltare musica quasi solo attraverso le piattaforme più note: Spotify, Amazon Music, Apple Music, ecc. Non sono un loro abbonato, no, ma nemmeno un ascoltatore delle caverne; a YouTube devo moltissime scoperte nel campo dei tardoromantici minori o nuove interpretazioni del repertorio bachiano, non pochi minimalisti che altrimenti non avrei mai scoperto oppure epici concerti jazz, di folk americano o di gruppi storici del progressive rock inglese. E siccome sono un frequentatore occasionale di Bandcamp e SoundCloud scopro con piacere, leggendo Bonini e Magaudda, che queste due piattaforme sono ancora in qualche modo “alternative” e mantengono un rapporto quanto possibile diretto tra artista e ascoltatore. Non rompono il monopolio delle grandi compagnie, ma rappresentano ancora una sorta di “zona liberata” (o che forse non è mai stata occupata, visto che si occupano di musiche che, quanto a diffusione, non vanno molto più in là dei sinfonisti romantici minori).
Data la mia ignoranza, è stato interessante scoprire che Spotify è nata come una piccola startup svedese – in maniera non diversa da come sono nate Microsoft, Apple e le altre imprese che ora dominano al mondo – e che in pochi anni, contro ogni aspettativa, ha raggiunto un valore di mercato di 41 miliardi di dollari. Ancora più sorprendente però è scoprire che Spotify non è ancora in attivo. Il suo giro d'affari è immenso, ma i profitti sono ancora in rosso. Era accaduto anche ad Amazon, ma se non sbaglio solo per i primi cinque anni. Spotify invece non è ancora riuscita a guadagnare un centesimo da tutta quella musica che fa girare nel mondo, ma si sa che chi investe grandi cifre sa aspettare. Meno simpatica è la conferma (ma lo sapevo già) che in questo enorme valzer di soldi i produttori di contenuto (i musicisti) sono quelli che ci guadagnano meno di tutti. Ultimamente la situazione è migliorata, ma non di molto, e in ogni caso sembrano finiti i tempi in cui un gruppo rock arrivato al terzo disco poteva comprarsi un castello nella campagna inglese (uno per ogni membro del gruppo) e adattarlo a idillico studio di registrazione. Anche alla musica ormai conviene la battuta che Mick Jagger, proprio lui, pronuncia in Freejack (dir. Geoff Murphy, 1992) film di fantascienza peraltro non memorabile, tranne appunto quando Jagger dice: “Questo è il futuro. C'è gente in cima e gente sul fondo. E niente in mezzo”.
O meglio: c'è Taylor Swift e ci sono i gruppi indie. In mezzo, ci sono le piattaforme. E la questione non è tanto come gestirle, perché sono loro che gestiscono noi, i nostri gusti e le nostre scelte. La questione, per i pochi che ancora credono di potersi scavare una tana dove gli algoritmi di Spotify non li troveranno mai (ma gli algoritmi sono come l'occhio tentacolare della Guerra dei mondi di Spielberg, che ti seguono in tutte le stanze di casa), è come usarli in modo situazionista, imbrogliandoli al loro stesso gioco. Lo faccio anch'io. Se su YouTube vado a vedere un video che mi interessa per qualche ragione particolare – ma non voglio assolutamente che diventi un trend – mi guardo bene dall'aprire il prossimo video che YouTube mi consiglia, sapendo che, come risultato di una curiosità occasionale, mi troverei inondato di video che non voglio vedere, mentre i risultati dei miei algoritmi preferiti sparirebbero o verrebbero cacciati in fondo alla colonna di destra della schermata. Da Bonini e Magaudda vengo a sapere che questa minima igiene mentale è una pratica diffusa, perseguita con calcolo e astuzia da molti giovani (nel libro debitamente intervistati) che pensano o di fregare il sistema, oppure che questo è l'unico stratagemma rimasto per affermare non tanto una propria identità di consumatore quanto una piccola, debole, ma comunque resistente soggettività.
È legittimo sentirsi orgogliosi di una pratica che ti fa sentire come un topo inseguito da un gatto fin dentro un labirinto, e che per mettere il gatto fuori strada sceglie il percorso più tortuoso, anche pieno di muri ciechi, sperando che il gatto invece voglia andare dritto al centro e che quindi dovrà rimandare l’inevitabile cattura nonché l’altrettanto inevitabile sbranamento? Bonini e Magaudda non prendono posizione; la loro ricerca, documentatissima, non è la solita critica dell'industria della cultura. È una ricognizione, un referto medico. Vogliono solo spiegarci come si ascolta la musica oggi, o meglio come l’ascoltano i giovani, dato che le subculture di coloro che ancora si ostinano ad ascoltare interi album nell’ordine voluto dagli autori o addirittura composizioni fatte di più movimenti (che per le piattaforme generaliste sarebbero comunque delle “canzoni”: il Requiem di Mozart è una serie di canzoni e un Adagio di Bruckner è solo una canzone un po' più lunga) nel libro vengono considerate solo di sfuggita.
Non prendono posizione, no, ma questo è anche un merito, perché la critica della cultura arriverebbe in ogni caso troppo tardi. Qui non ci troviamo di fronte a una strategia pianificata a tavolino perché dia vita a una struttura aziendale. Abbiamo piuttosto una serie di innovazioni tecnologiche che si sono succedute con rapidità impressionante e che hanno spiazzato tutti, tranne coloro che quelle innovazioni le avevano inventate. Non appena è comparsa, ognuna di tali innovazioni ha sgominato il campo e si è imposta come la modalità dominante con la quale la generazione contemporanea “doveva” accostarsi alla musica. Sì, ci sono le eccezioni: i monacali collezionisti di cd, gli ulissidi del ritorno al vinile come alla loro Itaca perduta, intenti a restituire il tono sacrale all'atto dell'ascolto anche semplicemente costringendo se stessi ad alzarsi dalla poltrona, togliere la puntina dal disco e a girarlo dall'altra parte. Ma sono un nulla in confronto agli abbonati a Spotify, Amazon e Apple.
La musica nell’era digitale è un libro utile per coloro che hanno vissuto il passaggio rapido dall'impero del cd (che toccò le sue punte di vendita maggiori tra il 1999 e il 2003) all'improvviso trionfo dell’mp3 e della condivisione peer-to-peer (gli anni in cui scambiarsi musica senza pagare un soldo era diventata la continuazione dello scambiarsi un paio di canne o qualcosa di più forte sull'erba di un prato, senza preoccuparsi se fosse legale o illegale né se poteva avere conseguenze). Ma è utile anche per chi è nato nell’attuale brodo digitale, l’utilizzatore di app algoritmizzato al quale dicono che ha a disposizione 100 milioni di canzoni e non riesce a capire perché le playlist della sua piattaforma gli fanno ascoltare sempre le stesse.
Costui dovrà leggere il terzo capitolo (“Chi sceglie la musica al posto nostro”) e capire come i curatori intervengano solo nella prima fase della creazione delle playlist, dopo di che gli algoritmi vanno per conto loro. Dovrà leggere il quarto capitolo (“Ascoltare la musica in streaming”) per capire la differenza tra l’epoca in cui regalare agli amici una cassetta con una playlist pensata per loro era un’affermazione di autonomia del soggetto (“la mia playlist è sacra”, mi ricordo di aver letto una quindicina d’anni fa) e l’epoca attuale in cui la musica, come dicono gli autori del libro, è passata dallo status di oggetto a quello di servizio e, come tutti i servizi, o come tutti i servitori, viene per lo più data per scontata.
L’ultimo capitolo è dedicato all’intelligenza artificiale e alla “musica del futuro”. Va letto soprattutto da chi vuole realizzare una masterizzazione a poco prezzo e ora sa che con programmi come Landr se la può fare in casa. Con l’avvertimento però che molte informazioni, come tutto ciò che si è scritto sull’I.A. negli ultimi mesi, sono già superate dai fatti. È di pochi mesi fa l’apparizione su YouTube di canzoni eseguite da Drake, Rihanna e Kanye West che i rispettivi artisti non hanno mai cantato. Alcune settimane fa sono apparse anche alcune canzoni dei Beatles con la voce di Lennon rifatte con la voce di McCartney e viceversa, nonché canzoni incompiute che l’I.A. ha terminato. Tutte prontamente rimosse dai detentori dei diritti d’autore (diritti? Quali diritti? autore? Quale autore?), ma dopo milioni di visualizzazioni e molti commenti entusiasti.
Non so davvero che cosa ci fosse da entusiasmarsi. Erano più blande delle versioni che una decente cover band potrebbe mettere insieme; blande come la prosa di ChatGPT. Sarà questo il futuro della musica? Leggo sul “New York Times” del 14 giugno che Paul McCartney completerà con l’aiuto dell’intelligenza artificiale una canzone di Lennon, Now and Then, lasciata incompiuta nel 1970. La firma di McCartney è garanzia sufficiente che la canzone risulti “autentica”? La stessa domanda era stata posta quando gli altri Beatles, e non erano i Beatles artificiali, avevano completato Free As a Bird e Real Love, due altre canzoni incompiute di Lennon, per la Beatles Anthology. E quando non ci sarà più nessun Beatle, ci accontenteremo di mediocri imitazioni che qualunque iscritto a un corso di “Beatles Composition” potrebbe scrivere, solo perché le ha composte sua maestà Intelligenza Artificiale? Vedremo. Intanto qualcuno ha cercato di usare l’I.A. anche per completare gli appunti di quella che avrebbe dovuto essere la Sinfonia n. 10 di Beethoven. Il risultato è stato penoso. O almeno: oggi diciamo che era penoso. Fra qualche anno cosa diremo?