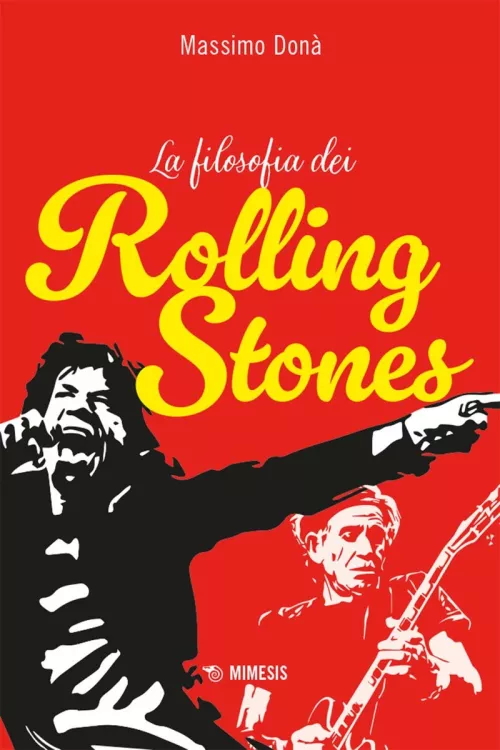Deleuze, Bataille e i Rolling Stones
Credo che saranno sempre meno in futuro coloro che, con una laurea di filosofia in mano, si tratterranno dall’avventurarsi sul terreno della pop philosophy. Massimo Donà, professore di filosofia teoretica all’Università Vita e Salute San Raffaele di Milano, nonché musicista in proprio (tromba solista e bandleader di un gruppo jazz), non solo non si trattiene, ma ci si butta con gran gusto. Dopo La filosofia di Miles Davis e La filosofia dei Beatles ci offre ora La filosofia dei Rolling Stones (Mimesis 2023, pp. 142). Verrebbe da dire che ha concluso una trilogia, ma l’accostamento tra popular music e filosofia gli è ormai congeniale e può darsi che voglia continuare la serie. Il campo è stato aperto più di vent’anni fa da Open Court, storica casa editrice americana, con la fortunata serie “Popular Culture & Philosophy” (due volumi all’anno). Si badi però che i titoli di Open Court non sono, per dire, The Philosophy of Star Trek, bensì Star Trek and Philosophy. La differenza è sostanziale; si usa una figura riconosciuta della popular culture come spunto per introdurre, in maniera semplice e propedeutica, alcuni temi filosofici fondamentali. Ti sto parlando, poniamo, di The Matrix, ma solo per farti poi leggere, che ne so, un capitolo sull’idealismo di Berkeley e sul fatto che la realtà non è indipendente dalla percezione che ne abbiamo. Se invece il titolo fosse The Philosophy of The Matrix, allora mi aspetterei che l’argomento preso in esame avesse una filosofia sua, una visione del mondo che vale la pena di essere esplicitata con gli strumenti della disciplina filosofica.
Non ho letto Massimo Donà su Miles Davis, ed è una mancanza alla quale intendo rimediare, ma conosco il suo libro sui Beatles e mi sento di poter dire che il gioco di ricavare una filosofia dalle loro canzoni, dal loro sound e dai loro film riesce meglio di quanto non possa riuscire con i Rolling Stones. Dopotutto, i Beatles avevano pretese intellettuali non da poco: si interessavano all’avanguardia musicale e artistica, citavano Lewis Carroll e la sapienza indiana, sperimentavano a più non posso in studio di registrazione e nei testi della loro seconda fase, da Revolver in poi, non si astenevano da voli arditi. I Rolling Stones sono tutta un’altra specie animale. Non è che non fossero curiosi, l’arte interessava anche a loro, ma erano partiti con l’idea di essere semplicemente la miglior band di Chicago Blues, ora che il pubblico bianco e nero si rivolgeva al soul e ci voleva qualcuno che raccogliesse il testimone dei vari Muddy Waters, Elmore James, Bill Dixon e Howlin’ Wolf (e, per aver tenuta viva la fiamma, B.B. King li avrebbe poi ringraziati: thank you boys; se non era per voi saremmo rimasti disoccupati).
La musica dei Rolling Stones, scrive Donà, nasce dal battito del piede di John Lee Hooker che incessantemente segna il ritmo; nasce dai riff geniali di Keith Richards costruiti, come nel caso di Satisfaction, con un’accorta discrepanza tra battere e levare che in mani poco esperte rischia di rendere monotona una canzone che invece è un esempio di differenza nella ripetizione. Ed ecco che qui scatta Deleuze.
Differenza e ripetizione, appunto. Che esce nel 1968, l’anno di un altro riff memorabile, quello di Jumpin’ Jack Flash. Ma c’è un discrimine sottile tra “la filosofia dei Rolling Stones” e la filosofia di Deleuze applicata ai Rolling Stones. Se il libro di Donà facesse parte della serie Open Court, un capitolo su Deleuze potrebbe essere al centro di The Rolling Stones and Philosophy. Lo stesso si può dire per l’altro autore dal quale Donà ricava la seconda idea portante del libro: l’economia dello spreco di Georges Bataille, la dépense, la “parte maledetta”. Seguendo la quale, la musica dei Rolling Stones diventa per Donà l’esempio probante di una macchina improduttiva, impegnata in una continua disseminazione. Un dono inutile, che mina dall’interno l’ossessione della produzione e che si sparge, lucido e indifferente, sul mondo intero.
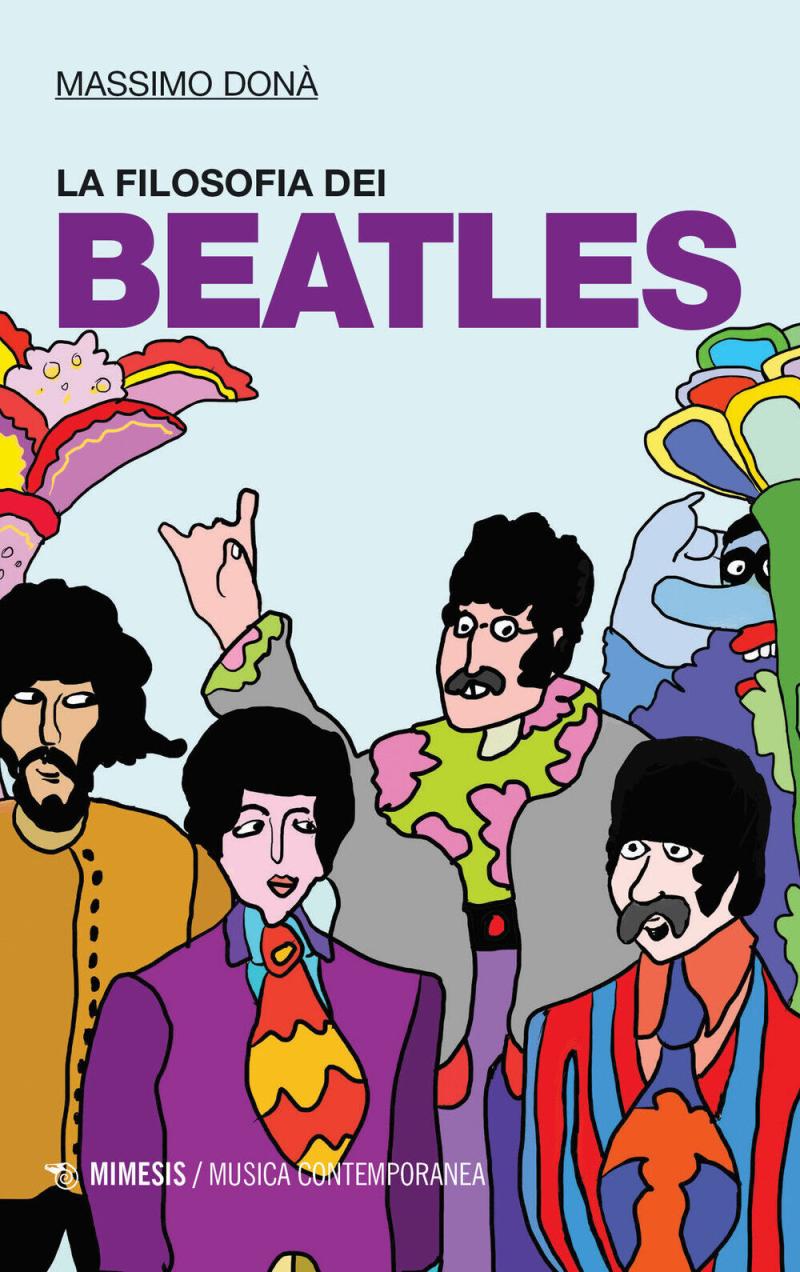
Ora, se per spreco intendiamo anche l’eccesso, il consumo forsennato di sostanze stupefacenti, l’esibizione ostentata di ambiguità sessuali che non arrivano mai, peraltro, a un’esplicita dichiarazione di pansessualismo; se per spreco intendiamo l’esibizione del corpo della musica e della musica come corpo, che magari una volta includeva l’invito rivolto da Mick Jagger alle ragazze urlanti in prima fila di salire sul palco e spogliarsi in diretta durante l’esecuzione di Jumpin’ Jack Flash, ecco, allora si può davvero parlare di un rito semi-dionisiaco nel quale la vita stessa può essere considerata una quantità da sprecare, come del resto accadde al concerto di Altamont che insieme alle imprese della banda di Charles Manson pose fine agli anni Sessanta.
Ma quella dissipazione del sé è stata un fenomeno generale del quale i Rolling Stones non erano nemmeno l’esempio più eclatante. È vero che Brian Jones fu la loro vittima sacrificale, ma lo spreco dei talenti che avvenne in quegli anni (inutile qui citare i nomi dei morti in trincea; li conosciamo tutti) non dipendeva dalla particolare estetica dei Rolling Stones. Non volevano sprecare il blues, volevano alzarne il volume.
Massimo Donà si concentra giustamente sulla musica, sull’analisi dei riff. Ma nel teatro dei Rolling Stones aveva grande importanza anche la parola. I loro testi non aspirano alla grazia lirica di Paul McCartney o alle altezze metafisiche di John Lennon. Come avrebbe detto Keith Richards, non mirano alla testa ma alla pancia, e per mirare alla pancia bisogna volare rasoterra. Sono pugni precisi, duri, brutali. Soprattutto, sono un continuo tentativo di capire, dall’esilio inglese, il mistero dell’America Nera. I Rolling Stones volevano “suonare bene” il blues, ma non si sono mai limitati a rifarlo. Non avevano e non potevano avere l’aplomb dei neri di Chicago, quel supremo distacco da se stessi che è il tratto della black coolness. Hanno interrogato il blues, l’hanno esasperato, l’hanno fatto urlare (anche nel loro ultimo Blue & Lonesome, 2016), ne hanno estratto il bene come il male, anzi soprattutto il male, il suo lato demoniaco, senza il contraltare salvifico del gospel. Brown Sugar è un riff magistrale, ma è anche il tentativo disperato di un giovane bianco londinese di capire che cosa vuol dire essere un nero in una piantagione del Sud, che cosa vuol dire essere una donna nera frustata e, insieme, qual è il godimento del boss che la frusta. Che oggi quella canzone risulti inascoltabile alle sensibili orecchie contemporanee (perfino Bob Dylan, le poche volte che l’ha eseguita dal vivo, ha omesso le parti più brucianti del testo) è solo una testimonianza in più del limite estremo al quale i Rolling Stones hanno spinto il blues proprio perché non lo potevano essere.
Qui possiamo certamente ricorrere all’“indifferenza” di cui parla Bataille, e che Donà introduce a proposito, ma è l’in-differenza (aggiungere il trattino è necessario) dell’attore che sul palco di questa particolare tragedia, nata dallo spirito di questa particolare musica, deve poter entrare nella mente dello schiavo come in quella del suo padrone, in-differente a entrambi perché non è la verità del recitante che deve giungere al pubblico, ma quella del recitato.
Se è la minima irregolarità del riff di Satisfaction a tenere in piedi una canzone che non ha né una vera strofa né un vero ritornello, allora che cos’è questo riff sempre mobile, sempre impercettibilmente differente nella sua ripetizione (una struttura a spirale, la chiama Donà) se non la perfetta analogia del testo? “I can’t get no satisfaction”, non trovo niente che mi soddisfi, devo cercare ancora e ancora, ripetere e differenziare fino a immaginare la lotta rivoluzionaria per le strade (Street Fighting Man), il sadismo dei proprietari delle piantagioni (Brown Sugar) o il brivido di sentirmi in sintonia con il diavolo (Sympathy for the Devil), solo per scoprire che non mi basterà mai, che non godrò mai abbastanza e non sprecherò mai abbastanza.
Ultima cosa: in La filosofia dei Rolling Stones l’aggettivo “mitico” compare tredici volte. Per il prossimo libro che scriverà, proporrei a Donà di fermarsi non appena un nuovo “mitico” sta per uscirgli dalle dita e ascoltare invece la canzone di Francesco De Gregori, quella che appunto si intitola L’aggettivo “mitico”. Anche tredici volte, se necessario.