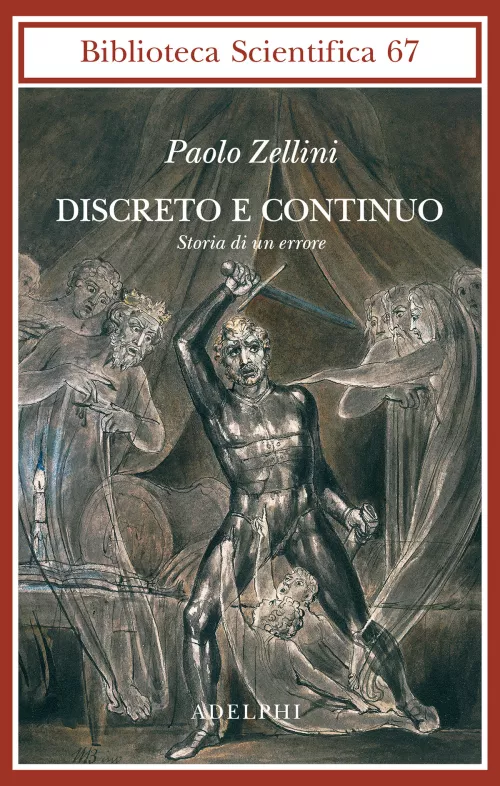Discreto e continuo: le ragioni di un errore
Nel libro di Rabelais “Dei fatti e detti eroici del buon Pantagruele”, riferendo dello scontro tra due armate, Panurge indica “lo spavento e il fragore più enorme” provenire dalle urla dei diavoli che nelle “sostanze loro aeree e invisibili” riempiono ogni spazio libero da quelle umane. Tutto è pieno.
Così racconta Paolo Zellini all’inizio di Discreto e continuo (Adelphi, 2022), che ricostruisce la storia di un errore, quello che si è commesso da sempre e per ogni dove interrogando i “poli di una fondamentale complementarietà del pensiero di tutti i tempi”: vale a dire la ragione per cui, mentre abbiamo sempre pensato il continuo come prius, “ciò che conosciamo effettivamente è solo il discreto” e l’unica maniera di avvicinare il primo è come approssimazione al secondo. Conclusione che, d’altra parte, non ci permette di disfarci dell’enigmatico concetto di continuità: per quanto inconoscibile, rimane un presupposto ineliminabile del pensiero. Pur oscuro e impenetrabile, ne abbiamo bisogno, come dell’infinito.
Ma prima ancora di Rabelais, ricorda l’autore, già secondo Giamblico il genere dei demoni e degli eroi stabiliva un legame ininterrotto, una scala continua di affinità intermedie tra Dio e l’anima. Un continuum. Il Demone si presenta come sostanza spirituale ed è, in versione angelica o diabolica, deputato a riempire ogni possibile spazio o intervallo. In orrore del vuoto.
Il termine continuo esprime quindi, più di ogni altro, il concetto di una grandiosa “catena dell’essere” priva di buchi, salti, lacune, e che in questo modo tiene insieme l’immensità del creato, ritrovandosi come tale in tante figure e narrazioni quante sono state e saranno le epoche che quel creato hanno provato e cercheranno di rappresentare. Come scriveva Norbert Wiener, citato da Zellini: “Il pensiero di ogni epoca si riflette nella sua tecnica”. Lo stesso approccio che abbiamo letto nel libro di Matthew Cobb, Mente e cervello, di cui abbiamo scritto su queste pagine.
In principio, dunque, abbiamo sempre pensato il continuum, ma è una prospettiva che dobbiamo rovesciare, e il rapporto con il discreto non va inteso nel senso di quel continuo diviso in un numero di parti “quanto nel senso che lo stesso continuo viene definito e costruito per mezzo di calcoli sul discreto”: che, lo ricordavamo, è anche l’unica prospettiva che effettivamente possiamo conoscere.
Impossibile non tornare a Zenone e ai suoi paradossi. Bertrand Russell nel saggio “La matematica e i metafisici” in Misticismo e Logica, si riferiva a Zenone come a colui che aveva affrontato i “3 problemi più astratti del moto”, e tra questi, appunto, la continuità, in aggiunta a infinito e infinitesimi (e ringraziando Cantor, Dedekind e Weierstrass per i contributi alle rispettive soluzioni, ci torniamo). Imprescindibile il riferimento ad Aristotele che – nella Fisica e nella Metafisica – spiega come il continuo presupponga l’idea di successione, il venire di una cosa dopo l’altra, in un’articolazione complessiva di ogni cosa che si deve saldare con la precedente senza lasciare lacune e vuoti nel mezzo. Di nuovo la pienezza.
L’idea primordiale, infatti, che si ritrova anche nella tradizione vedica, segnatamente nei trattati per l’edificazione degli altari a forma geometrica di Agni (un’intuizione geometrica che transita verso i procedimenti più astratti della matematica) è quella di un limite per successioni che lo consentono, tali che i loro termini diventino sempre più vicini, oltre ogni tentativo di separarli. E poi di progressione, di una progressiva espansione dello spazio. Interessante il riferimento ad alcune notazioni di Paul Feyerabend (in Naturphilosophie, 2009), quando ipotizza che il carattere iterativo delle progressioni prescinde il significato strettamente matematico.
Addirittura nell’Iliade, suggerisce Feyerabend, si ritrovano epiche formule iterative in stile geometrico, a cucire insieme gli elementi di senso. Carattere additivo che diventerebbe più evidente nella tendenza a raffigurare il corpo umano tagliato in pezzi – nei duelli omerici – separati e giustapposti: “ogni colpo e duello mortale opera quasi un taglio sacrificale della vittima, dividendola nei pezzi della massa organica che sembra seguire, nella logica del frazionare e del ricomporre del sacrificio, la forma compiuta del corpo vivente”.
Ma sempre a partire da un elemento fondante – oltre e prima della successione continua – giacché, senza eccezioni, la progressione ha origine da un seme iniziale, una monade, un punto oppure una semplice figura geometrica soggetta a una crescita (o a una decrescita, come accade per costruzioni geometriche legate alla radice di 2), un’entità invisibile che può generare successioni di grandezze più conformi alla natura degli enti reali per come li percepiamo. Dal punto, che è invisibile, ha origine la linea, da questa la superficie e quindi il solido. Il visibile come prodotto naturale del e dall’invisibile.
Ancora due osservazioni di Aristotele: “È impossibile pensare a qualsiasi cosa senza la continuità, o pensare a cose atemporali se non in termini di tempo (Parva naturalia, 450 a) […] la mente è una e continua nello stesso senso in cui lo è il processo del pensare; il pensare è fatto di pensieri. Ma l’unità di questi è quella di una successione, simile a quella dei numeri, mentre è diversa l’unità delle grandezze spaziali” (trattato Sull’anima, 407 a).
Il continuo per Aristotele è legato all’idea di serialità, svolgendo un compito analogo a quello del tempo o, come spiegava Kant: “l’idea di successione non si presenterebbe neppure alla percezione, se come fondamento non si trovasse a priori la rappresentazione del tempo”. Bisognerà arrivare a Bernard Bolzano, prima, e poi a Richard Dedekind e a George Cantor per concepire una nozione di continuità puramente analitica e del tutto indipendente dal tempo.
Ed è in questa continuità (cos’altro?) di tempo che Zellini ci accompagna, seguendo quello che era già un’indicazione-programma di lavoro di Simone Weil, quando riferendosi alle “rivoluzionarie, straordinarie e sovversive” idee sulla meccanica quantistica, indicava come necessario il tracciare delle linee storiche che risalivano alla Grecia, nelle sue parole: “la teoria dei quanti si inserisce in una lunga tradizione; perché fin dalla Grecia, la scienza è una sorta di dialogo tra il continuo e il discontinuo”.
Come abbiamo già più volte sottolineato, Zellini allarga di molto il campo, rintracciando nella tradizione vedica dell’agnicayana, la costruzione rituale dell’altare di mattoni di Agni, progressioni geometriche paragonabili (un cavallo di battaglia dell’autore).

Anche la geometria degli altari vedici si sviluppa da un seme generatore, intravisto dai “sette veggenti”, gli spiriti vitali che per potersi configurare come forza generatrice decidono di unificarsi in un’unica entità: Prajapati, il signore della creazione. “Nell’altare-Agni si cerca di ripristinare, con strumenti matematici, non tanto la continuità perduta, quanto l’unità smembrata dal sacrificio della creazione”. Prima era l’unità del continuo.
Alla vedica unità smembrata, al “taglio” sacrificale, sembrano rimandare anche i Dialoghi di Platone: “il tagliare a metà, esprime il lavoro di cesello della dialettica platonica”. Tagliare a metà l’argomento, e poi di nuovo ciascuna delle due parti, e poi ancora, così da restringere gradualmente l’ambito di definizione di un concetto. E magari, tornando ancora ad Aristotele, trovando la grandezza adeguata del bello nella struttura compositiva della tragedia, paragonata ad un essere vivente, al corpo umano la cui qualità estetica si adagia su una divisione tale che la grandezza sia abbracciabile con lo sguardo: allo stesso modo una trama “deve avere una lunghezza, ma questa deve essere proporzionata alla memoria”.
Un po’ oltre la metà dei trenta capitoli complessivi di questo libro, c’è il ventitreesimo dedicato al “Congresso di Parigi”, e lì si trova – almeno così sembra al recensore – la ragione profonda che ha ispirato Paolo Zellini a raccontare la storia di questo errore. Nella capitale francese, al giro di boa tra XIX e XX secolo, si tenne un celeberrimo congresso internazionale di matematica, legato indissolubilmente alla figura di David Hilbert e all’elenco dei 23 problemi aperti che sarebbero dovuti diventare altrettanti campi di indagine della matematica del ‘900.
È nota la circostanza per cui, solo trentuno anni dopo, Kurt Godel, con la pubblicazione dei suoi due teoremi di incompletezza, infrangeva il programma di Hilbert alla ricerca di un linguaggio matematico che da solo potesse provare la sua consistenza e coerenza. Ma, almeno in questa sede, non è questo il punto. Fu lo stesso Hilbert, invece, a raccontare di un matematico francese, vissuto diverso tempo prima, che sosteneva come “una teoria matematica non può essere considerata perfetta finché non sia stata resa talmente chiara da poterla far comprendere alla prima persona che s’incontri per strada”.
Ora, scrive Zellini, “si ritiene di solito che la spiegazione piana e semplice di una teoria consente al profano di accedere ad una forma di conoscenza per la quale sarebbe in realtà necessario un lungo apprendistato”: apprendistato che è in effetti inevitabile. Ma qui sta il punto, ritorna Zellini: “Ogni comunicazione di verità scientifiche dovrebbe recuperare le loro più profonde motivazioni iniziali, per ripercorrere poi le importanti modifiche che esse hanno subito negli anni e nei secoli. L’inizio di una teoria è di solito più facile da capire […] le teorie scientifiche non dovrebbero allora prescindere da un’indagine sulla genesi dei concetti, come pure dalle più diverse circostanze sociali e culturali, e perfino dallo sfondo mitico che potrebbe aver concorso a quelle conquiste”.
Che è, esattamente, quello che Paolo Zellini ha realizzato nei ventidue e poi ulteriori sette capitoli che precedono e seguono quello dedicato al Congresso di Parigi e a David Hilbert, giacché il fuoco inesplicabile, l’animo, il sentimento, l’ardire con il quale Hilbert si affidava alla potenza dei simboli, potrebbero avere origine in cose che non sappiamo e che tuttavia dobbiamo capire. L’origine di una idea, le ragioni di un errore.
Non ci deve scoraggiare, per altro, il differente clima che oggi viviamo al contrario di quello fiducioso, persino euforico, con il quale in quel 1900 parigino i matematici dell’epoca si accingevano ad uno sforzo eroico, come scrive Zellini, “quasi si trattasse di una discesa del divino sulla Terra”. A quel tempo anche Richard Dedekind si figurava l’uomo matematico come un demiurgo, “Noi siamo di razza divina e abbiamo il potere di creare”, come scrisse a Heinrich Weber nel 1888.
È lo stesso Zellini a notare che le ricerche avviate dalle proposte di Hilbert “pur illustrate con la massima semplicità” non sarebbero sufficienti a spiegare al primo che capita per strada tutti i motivi che le avevano propiziate.
Pure che “il recupero delle motivazioni iniziali sia utile anche alla comprensione delle teorie più difficili e avanzate” lo sapeva bene Hermann Weyl, il quale sottolineava che quando operiamo con i nostri concetti, anche in maniera rigorosa e formale, dobbiamo sempre pensare che le origini delle cose giacciono in strati più profondi, e che solo retrocedendo a quegli strati si può cogliere il significato delle nostre conquiste, anche prescindendo da una formazione specifica o da un sapere specialistico. Retrocedere comunque, fin dove è possibile, “a quel sapere intriso di ritualità e metafisica oltre che di spirito scientifico da cui ha avuto origine la matematica che conosciamo”.
Che, come citazione, si presterebbe ad una chiusa perfetta. Pure vogliamo aggiungere un’ultima riflessione. Discreto e Continuo di Paolo Zellini è un saggio di storia delle idee, la cui più piena comprensione, per essere onesti, è difficilmente agibile “prescindendo da una formazione specifica o da un sapere specialistico”, ma è anche un esempio di divulgazione a partire dalla pervasività di un concetto, dalla imprescindibilità di un’idea.
Alla migliore e necessaria comprensione del fare e dei risultati della ricerca scientifica, manca un’abitudine, difficilmente rintracciabile nei manuali scolastici, a seguire le idee, a retrocedere fino a rintracciare l’origine delle cose e dei problemi, a scovare i “poli di qualche fondamentale complementarietà del pensiero di tutti i tempi”. In questa piccola epoca di programmi e di proclami, una perorazione minima ci sentiremmo di aggiungere, a favore di una maggiore presenza tra i banchi dell’obbligo della storia e della filosofia della scienza, della storia delle idee che hanno cambiato il nostro modo di guardare il mondo e di pensarlo: partire da un punto, dal seme invisibile di un’idea per provare a rintracciare le linee del pensiero, le superfici dell’argomentazione, i solidi spazi della conoscenza.