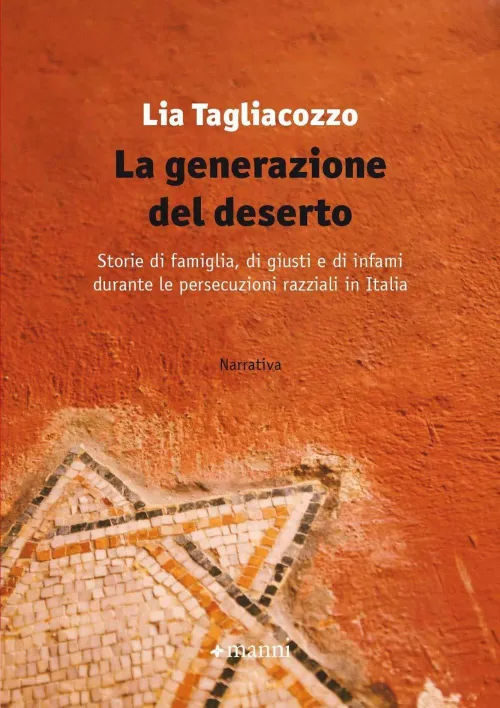Ottolenghi e Tagliacozzo / Due famiglie ebree nella Storia
Il finale l’hanno scritto i giornali. Mentre Lia Tagliacozzo, figlia di sopravvissuti alla Shoah, presentava su Zoom il suo ultimo libro sulle persecuzioni razziali, un coro d’odio ha fatto irruzione. “Hanno iniziato ad urlare ‘ebrei ai forni’, ‘sono tornati i nazisti’, ‘vi bruceremo tutti’, ‘dovete morire tutti’”, ha scritto Sara, la figlia dell’autrice, che in un post ha denunciato l’accaduto. Sullo sfondo, immagini di Hitler e svastiche.
Per alcuni lancinanti minuti, i fantasmi del passato si sono così ripresentati nella casa dove settantasei anni prima, nella razzia degli ebrei romani, era stata deportata la famiglia Tagliacozzo. E non per caso è accaduto in vista del Giorno della Memoria – uno sfregio a chi in nome delle vittime tiene vivo il loro racconto e all’Italia che ha scelto di non dimenticare.
Lo zoombombing, così lo chiamano, è uno degli incerti di questo tempo risucchiato dagli schermi e oggi, usciti dal perimetro della cronaca, mi sono chiesta se scriverne a rischio di regalare un’altra cassa di risonanza agli hater. Se non che quel veleno dà conto delle inquietudini che in un singolare controcanto intrecciano il libro di Lia Tagliacozzo La generazione del deserto. Storie di famiglia, di giusti e di infami durante le persecuzioni razziali in Italia (Manni, 197 pp.) e il bel memoir di Ada Ottolenghi Ci salveremo insieme. Una famiglia ebrea nella tempesta della guerra (Il Mulino, 182 pp.).
In libreria negli stessi giorni, i due lavori sono figli di stagioni, contesti e ragioni differenti. Il primo, la ricostruzione di una tragedia inscritta nell’urgenza del presente; il secondo, il resoconto in prima persona di una salvezza che ha del miracoloso. Ad accomunarli, l’orgoglio di un’identità e il tema della famiglia al tempo stesso radice, cura degli affetti e slancio verso il mondo. Sono libri, questi, scritti da due donne, due madri che hanno qualcosa – anzi parecchio – da dire al futuro.
Ada Valabrega Ottolenghi (1903-1979) appartiene alla generazione dei testimoni. Ha attraversato, moglie e madre di tre bambini, gli anni delle persecuzioni razziali. Quando scrive, alla fine del 1958, l’amato marito Guido, imprenditore ebreo torinese, è scomparso da poco. Solo lei può consegnare alla prima nipote Raffaella e a quelli che verranno il dono prezioso della memoria familiare.
In una lunga affettuosa lettera, finora rimasta inedita, la donna ricrea dunque quel tratto cruciale di vita. Vi si ritrovano la fuga da Torino, il periodo trascorso nella bella villa di Porto Corsini fra la pineta e il mare. I figli che crescono, giocano e studiano, gli amici, i contatti con i partigiani e la solidarietà generosa della gente di Cotignola – i Giusti hanno un ruolo centrale nella salvezza della famiglia. E poi il cerchio che si stringe – i nazisti che perquisiscono la casa e se ne vanno con due prosciutti senza sfiorare le persone, le retate sempre più prossime e l’incredulità iniziale che lascia il posto alla percezione della tragedia.
Certi ritratti umani sono indimenticabili e le descrizioni della natura incantevoli, ma Ada Ottolenghi non scrive per fare letteratura né il suo è un racconto autobiografico nel senso classico del termine, perché il soggetto si sottrae con ostinazione allo sguardo. O meglio, perché il soggetto non è l’oggetto.
La narrazione segue ritmi e i modi della narrazione orale e riprende la tradizione ebraica del racconto di famiglia, come nota nella prefazione la storica Liliana Picciotto. Gli stati d’animo di chi scrive filtrano per dettagli (lo sfinimento, il mal di stomaco costante, i capelli che imbiancano) e infine contano poco. Si scrive per tramandare simboli, usi, convinzioni. Per riaffermare un’identità di famiglia ebraica, italiana, antifascista. Per fare Memoria, nel senso più alto del termine.
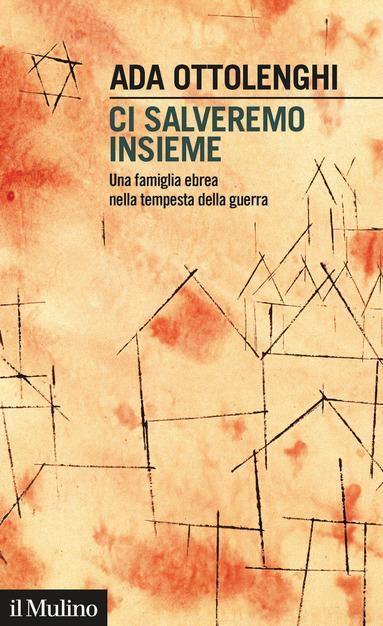
“Che cosa ci guidò? Chi fece da invisibile guida ai nostri passi?”, scrive Ada Ottolenghi. “Io penso ora che sulle nostre decisioni sempre pesarono tre idee fondamentali che erano dentro di noi: quella di separarci il meno possibile e di correre tutti insieme gli stessi pericoli; quella di non venir meno alla nostra fede ebraica e, possibilmente, di non nasconderla; e quella di poter contribuire in qualche modo alla lotta che gli antifascisti conducevano per riportare l’Italia alla libertà e con questo gli ebrei alla vita”. Quanta speranza, viene da dire, in queste parole.
Come i nipoti per cui Ada Ottolenghi scrive, Lia Tagliacozzo, autrice di libri per bambini e da tempo impegnata nella divulgazione della Shoah, è nata “dopo”. La sua, la mia, è la generazione del deserto che dà il titolo al libro. Nella Bibbia gli ebrei dopo l’uscita dall’Egitto vagano quarant’anni nel Sinai – il tempo necessario a costruire lo spazio interiore che accolga la libertà della Terra Promessa. Così i figli della Shoah, i nati in viaggio, i sospesi a metà, stanno elaborando la loro traversata.
La sua ricerca muove i primi passi nel silenzio che in casa Tagliacozzo, una famiglia piccolo borghese di ebrei romani, come in tanti altri nuclei ebraici avvolge gli anni delle persecuzioni – per riserbo, rispetto, timore di ferire. “La congiura del silenzio è amore reciproco: dei genitori per i figli e dei figli verso i genitori. Un patto a tutela reciproca, espressione di un amore taciuto eppure evidente”. In casa si tace e fuori non se ne parla. I giorni dedicati ufficialmente a ricordare, che spingeranno tanti figli e nipoti a fare domande, sono di là da venire.
Prima di farsi una domanda esplicita, la scoperta della storia familiare – che queste pagine documentano con passione – si nutre dunque di brandelli d’informazione, discorsi origliati, sotterfugi. E quando il quadro infine si compone, è devastante. Il padre si è salvato per caso da una retata ed è rimasto nascosto in un convento per tutti i mesi dell'occupazione. La madre si è rifugiata in un casolare di campagna e poi, dopo una fuga attraverso le Alpi, in un campo di internamento in Svizzera. La sorellina del padre, Ada, a otto anni è invece deportata ad Auschwitz insieme alla nonna e allo zio. Nessuno dei tre farà ritorno, come non tornerà il nonno, denunciato da un delatore (“un uomo piccolo, maledetto, infame”).
Alla piccola Ada alcuni anni fa a Roma hanno intitolato una scuola. Intanto, il clima politico e culturale è cambiato. La Memoria è diventata patrimonio istituzionale, il patto del silenzio è venuto meno. Tanti sopravvissuti hanno iniziato a raccontare e trovato ascolto come nel primo dopoguerra non era successo – per tutti basti ricordare la traversia editoriale di Se questo è un uomo, pubblicato nel 1947 dalla casa editrice torinese Da Silva dopo essere stato respinto da Einaudi che appena nel 1958 lo ripubblicherà. Il padre di Lia oggi porta la sua testimonianza nelle scuole.
Ad ascoltarlo davvero, questo racconto a più voci illumina la dimensione di normalità degli uomini e delle donne che dopo la guerra si sono dati all’ordinaria/straordinaria impresa di ripartire. E malgrado le ferite atroci – anzi, con quelle ferite – hanno messo su casa, studiato, lavorato, cresciuto la famiglia. Si sono rifatti un posto nel mondo o almeno ci hanno provato.
I nostri genitori, i nostri nonni. Tutte persone normali, come sottolinea l’autrice. Farne degli eroi “come il discorso pubblico cerca di fare per tacitare la colpa, per toglierli dalla Storia, per relegare la Shoah nella categoria della morale invece che delle responsabilità umane è un affronto alla loro memoria di esseri umani, uomini o donne, adulti o bambini, vecchi o lattanti”.
Non è solo che farne dei santi o dei feticci è una mistificazione. È che quella retorica si è avvitata nel suo contrario. In un atroce paradosso, che la storica Valentina Pisanty ha esplorato in modo brillante in I guardiani della Memoria, la costruzione di una diffusa cultura della memoria si è accompagnata dopo la guerra fredda a una netta svolta verso destra e all’emergere ovunque di un razzismo sempre più virulento e violento.
Il paradigma della Shoah ormai mostra la corda e le ragioni sono molteplici – la commercializzazione sempre più spinta, lo svuotamento di certi rituali, l’eccesso di appropriazioni spurie, la competizione fra vittime e il moralismo del racconto. Se la perdita generale di interesse e la saturazione sono palpabili, il nesso fra memoria e attivismo non è però mai stato più evidente. Basti pensare alle statue abbattute lo scorso anno negli Stati Uniti dal movimento antirazzista o alle pratiche di testimonianza che in tutto il mondo scandiscono i movimenti post coloniali.
E qui si apre la prospettiva indicata da Lia Tagliacozzo, l’unica dal mio punto di vista capace di sottrarsi alle retoriche virtuose e a certe claustrofobie, una Memoria che rifiuta di farsi fine a stessa e torna nel flusso vivo della storia come impegno civile e politico. In termini ebraici, siamo nella dimensione del Tikkun Olam – la riparazione del mondo. In termini laici, nel campo dell’azione sociale.
Troppo facile liquidare la Shoah come una storia ebraica, perché non lo è. Quell’odio è ancora qui e con disinvoltura scavalca i confini e le identità. “Lo si voglia o meno la foto imbrattata dai gilet gialli a Parigi con scritte ingiuriose sugli ebrei è di oggi. La gente cacciata senza protezione umanitaria anche, i morti in mezzo al mare senza nome. In mezzo alle montagne senza identità. Tutte storie di oggi”...
E allora corriamo al finale. Roma, pomeriggio. Un bombardamento di insulti si abbatte via zoom su una scrittrice ebrea italiana, figlia di sopravvissuti alla Shoah, che presenta on line il suo romanzo familiare. È il 10 gennaio, il primo di una serie di attacchi razzisti che nelle settimane successive prenderà di mira tanti altri. Pochi giorni prima, a Washington, gli insorti pro-Trump avevano occupato Capitol Hill in un dispiego osceno di simboli razzisti e neonazisti. Tutte storie di oggi.