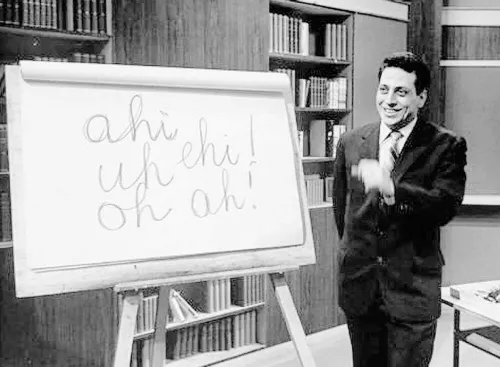Speciale
Edgar Morin. Insegnare a vivere
Il novantaquattrenne Edgar Morin, sociologo e filosofo, ci consegna l’ultimo saggio di una trilogia dedicata all’educazione. Insegnare a vivere (Cortina 2015), come i precedenti La testa ben fatta e I sette saperi necessari all’educazione del futuro (Cortina 2000 e 2001), non è un’opera pedagogica né una proposta di riforma del nostro sistema scolastico ma un suo radicale superamento. A indicare l’urgenza della proposta di Morin, due domande in esergo al libro chiudono ad anello le sorti dell’umanità e il destino del nostro pianeta: “Quale pianeta lasceremo ai nostri figli?” (Hans Jonas) ci richiama alla responsabilità nei confronti di quel prossimo che sono le generazioni future; “A quali figli lasceremo il mondo?” (Jorge Semprùn) affida la responsabilità all’insegnamento educativo che fin d’ora dovremmo attivare. L’intreccio fra l’umano e il naturale è ormai diventato un gaddiano garbuglio; gli oggetti con cui conviviamo sono sempre più ibridi, direbbe Bruno Latour, dove si fa indistinto il confine fra quanto è prodotto da noi e quanto si deve alle leggi del mondo. Di qui l’esigenza (che accomuna Morin a un altro “maestro del nostro tempo”, Michel Serres) di superare l’antica barriera che la nostra stupidità ha costruito fra cultura umanistica e saperi tecno-scientifici: non si tratta di questione accademica, o di conflitto di facoltà (mentali ed universitarie), in gioco è l’urgenza di una comprensione che ricollochi l’uomo nella natura. Tema su cui Morin ha l’innegabile merito di aver imposto tra i primi una riflessione, a partire dal lontano Il paradigma perduto (1972), quando ci invitava a comprendere la natura umana muovendo dalle radici evolutive da cui è emersa. Finché continueremo a tenere separate le due rive della cultura (fino a renderle rivali) non riusciremo a gestire le ricadute del nostro intervento sulla natura e di quest’ultima sulla comunità degli umani. Una comunità di destino, ricorda Morin, che si avvia a diventare planetaria, come esito della globalizzazione, o meglio, suggerisce il termine francese, mondializzazione, perché coinvolge non solo i gruppi umani, ma anche le loro relazioni con la biosfera.
Con la metafora della testa ben fatta (ripresa da Montaigne), Morin invitava a formare menti che fossero, non tanto piene di conoscenze, quanto in grado di porre e trattare problemi globali, grazie a criteri organizzatori che tengano conto della complessità che li governa. È questo che non sa fare la scuola, dalla primaria all’Università, frantumata com’è in discipline, affidata a competenze unilaterali o settoriali, cullata dalle certezze dei propri limitati campi d’indagine. Sempre più siamo posti di fronte a sistemi instabili, flou, dai confini indistinti e mobili (come le nuvole che già Wiener eleggeva a emblema del sapere cibernetico): in essi entrano in gioco il grande numero e molteplici variabili strette in relazioni non lineari, le leggi che governano le componenti non bastano a spiegare l’evolversi del sistema, con la conseguenza che si stempera ogni certezza previsionale. Se un tempo si poteva guardare alla geometria euclidea e/o alla fisica newtoniana come scienze regine, paradigmi di rigore esplicativo, oggi sono altre le scienze che ci educano a dialogare con l’incertezza. La matematica stessa, in perenne cammino verso il rigore, ci ha svelato la fecondità di campi dove domina il qualitativo e l’anesatto (dalla topologia ai frattali), fornendoci modelli molto più rispettosi della complessità del reale. L’esattezza è una richiesta che dovrebbe adattarsi agli esattori delle finanze più che agli insegnanti di matematica; qualcuno di essi ricorda il nevrotico protagonista di “Bianca” di Nanni Moretti, turbato dal non ritrovare ordine e regolarità fra le coppie degli amici, che fanno errori stupidi, e si separano.
Sospinti da interessi o ideologie, siamo indotti a credenze semplificatrici, a visioni binarie e manichee, a distinzioni rigide che scavalcano la complessità, al limite del contraddittorio, del reale (viviamo nel tempo degli ossimori, ha insegnato Cornelius Castoriadis, uno dei compagni di strada di Morin). C’è voluto un lungo percorso per far crollare le illusioni coltivate nel dopoguerra nei confronti dell’URSS, esemplifica Morin rievocando la sua esperienza; quelle illusioni erano frutto di una sistematica cancellazione dei fatti che disturbavano, consentivano di cullarsi in menzogne rassicuranti. Ecco perché la formazione scolastica (Università inclusa) dovrebbe prevedere un insegnamento dedicato alla “conoscenza della conoscenza” (era il titolo del terzo volume del suo Metodo), compito a cui devono contribuire, insieme alla filosofia, la psicologia e le scienze cognitive, la letteratura e la storia. Ogni conoscenza è traduzione/tradimento, costruzione e non riproduzione della realtà; siamo destinati alla fatica ermeneutica, a interpretare di continuo, il che ci condanna in modo pressoché inevitabile all’errore e all’illusione. Ma è dell’errore, più che della verità, che dovremmo tessere l’elogio: esso costringe a risvegliare l’energia mentale, è fonte di scoperta e innovazione, mentre la certezza di essere nel vero induce all’inerzia. Non era forse proprio questo il senso pedagogico dell’epistemologia delle congetture e confutazioni del vecchio Popper, il quale ricordava che chi cerca conferme le trova sempre? Bisogna fare però gli errori “giusti”, quelli che inducono a cercare le ragioni delle difficoltà, a cogliere relazioni inattese, indizi che svelano quel che restava nascosto; insegnare dovrebbe assomigliare all’arte del paleontologo che trasforma dettagli apparentemente insignificanti in indizi che consentono di ricostruire tutta una storia. “Credo che la cultura sia il presentimento di quello che non si sa” (Nati due volte), scriveva Giuseppe Pontiggia riferendosi all’incompetenza di medici presuntuosi.
Le virtù dell’uomo senza certezze, moderatamente scettico, impediscono di aderire alla pigrizia che trasforma le ipotesi in dottrine e dogmi. Sapendo di non possedere verità assolute e facili ricette, siamo indotti alla modestia di un’ecologia dell’azione pronta a riconoscere le contro-finalità, gli effetti indesiderati e imprevisti. Il Prometeo scatenato della tecno-scienza non è più il “previdente”, colui che letteralmente pensa prima, ha sempre più il volto di suo fratello Epimeteo, che solo a cose fatte si accorge degli errori commessi. Dalla catastrofe di Fukushima alla resistenza dei batteri agli antibiotici, abbiamo appreso che ogni decisione è una scommessa: le nostre strategie possono condurre a esiti opposti alle nostre previsioni, siamo sempre più inermi ad affrontare la “civiltà del rischio” e le disavventure dell’esistenza. Forse, potremmo cominciare a ricordare che il pensiero a cui affidarci è appunto metis, non logos o ratio, ma sagacia, intuizione, elasticità mentale, pronta a confrontarsi con gli incerti del mondo. Del resto, sono sempre più le scienze stesse a svelarci un mondo caotico, governato dall’aleatorio e dall’imprevisto, più simile all’andamento delle nubi o di chi va bighellonando per le strade (diceva Musil) che allo scorrere regolare degli orologi o al moto ripetitivo degli astri. Le scienze del complesso ci forniscono indicazioni di metodo, ha suggerito Morin nei sei volumi del suo Metodo (editi da Cortina); la meteorologia, le scienze della Terra e l’ecologia (Morin ha chiesto che l’insegnamento di quest’ultima venga esteso ad ogni livello d’istruzione) ci pongono di fronte a sistemi che non sono il frutto della combinatoria di elementi semplici, di mattoni distinti e separati. Gadda avrebbe detto che alla base del reale non stanno particelle che hanno l’esasperato senso d’individualità che è proprio dei piselli in scatola; più che limiti e barriere, vi sono legami e aggrovigliamenti, per cui cose ed eventi formano un impasto, “come fa la polpa delle patate sfatte, e inficiate nel sugo medesimo”. Il sistema complesso è un intreccio di relazioni dove le cose comunicano fra loro e con l’ambiente, dove l’osservatore stesso è integrato nel sistema che osserva; cause minime possono allora produrre effetti catastrofici (il famoso effetto farfalla).
Per cogliere il complesso intrico che caratterizza i problemi del nostro tempo, Morin chiede che ogni pedagogia assuma per base il “Grande Racconto” oggi proposto dalle scienze, il “grand Récit” di cui parla Serres ne L’incandescent (lo si può trovare nel recente numero che la rivista “Riga” ha dedicato al filosofo francese – qui l’anteprima pubblicata su doppiozero). Credevamo finita nel post-moderno l’epoca delle “grandi narrazioni” su cui fondavamo le nostre ideologie, ed ecco il percorso tortuoso, stretto fra vincoli e caso, fra continuità e fratture, compiuto dall’universo per giungere a noi: dai tredici miliardi di anni del Big Bang (se davvero ci fu), attraverso la comparsa della vita sulla terra, circa 4 miliardi di anni orsono, e ai primi passi, circa 7 milioni di anni fa, dell’ominizzazione fino alla successiva diaspora della nostra specie. È solo su questo sfondo che il breve segmento della storia umana si illumina, si svela l’unità antropologica nelle sue diversità individuali e culturali; diventa così pensabile insegnare il senso della cittadinanza terrestre, prepararci a un’era planetaria di inter-solidarietà, sorta dalla comprensione che l’umanità intera partecipa a una comunità di destino. Ma per questo abbiamo bisogno di operatori di relianza, osserva Morin, che ci consentano cioè di collegare la biologia e la fisica, la cosmologia e la cultura umanistica e, più in generale, di cogliere legami e connessioni, al di là della pratica disgiuntiva e separatrice del sapere classico. Un sistema complesso funziona al modo di un ologramma, come nelle monadi leibniziane la parte riproduce il tutto: la mondializzazione è all’interno di ciascuno di noi e noi portiamo tracce del percorso dell’intera umanità. Ogni cellula è un miscuglio di cellule di origini diverse: lezione di meticciato che cancella ogni illusione di purezza, e ci apre alla comprensione della nostra solidarietà vitale con la natura che degradiamo e alla condivisione del nostro comune carattere bastardo.

Il “pensiero ecologicizzante” si traduce in un’etica della comprensione umana. Quando si entrava nell’era della comunicazione (quando Ermes sostituiva Prometeo, per dirla con Serres), il male era l’incomunicabilità; oggi, il grande male è l’incomprensione, non solo fra stranieri, ma anche tra membri di una stessa società, di una stessa famiglia. Al cuore dell’educazione va posta l’acquisizione di competenze esistenziali e non solo di quelle professionali richieste dal dominio della tecno-economia. Il compito dell’educazione non è semplicemente spiegare, in termini concettuali che si vogliono oggettivi, ma offrire una comprensione umana, sempre inter-soggettiva, e che richiede apertura verso l’altro. È da questo riconoscimento empatico dell’Altro che possono sorgere strumenti efficaci per lottare contro razzismo e xenofobia; è quel sentire che si ingenera in noi nella partecipazione emotiva agli eventi e ai protagonisti di un film, per cui proviamo simpatia per le sorti del barbone di Chaplin, per dimenticarcene presto fuori dalla sala quando troviamo uno zingaro. La comprensione richiede di apprendere testo e contesto, caso locale e situazione globale; chiede ancor più di comprendere l’incomprensione, cioè le modalità psico-sociali dell’esclusione e del rifiuto del diverso. Solo così possiamo sperare di resistere alla barbarie, non tanto a quella che viene da fuori, ma a quella che abita le nostre case e le nostre strade, a quella che portiamo in noi, pronta a riemergere in tempi di isteria collettiva. Morin chiede che ogni università istituisca una cattedra di “comprensione umana”: sarebbe il luogo in cui prendere coscienza dei condizionamenti subiti, degli imprinting che hanno marchiato la nostra infanzia e la nostra adolescenza. Non c’è libertà se non c’è prima liberazione, anche dai nostri pre-giudizi; ma per comprendere in quali rive scorre il nostro pensare e il nostro sentire dobbiamo porci a confronto con altre culture, ad esempio con quella della Cina come fa da decenni François Jullien.
La pratica inter/multi/trans-disciplinare proposta da Morin connette i saperi all’esigenza del ben vivere e di una vita buona; si tratta di sviluppare le proprie attitudini, trasformando le conoscenza acquisite in sapienza, in arte di vivere. Il compito dell’educatore è ancora quello che indicava Rousseau nell’Emilio: “Vivere è il mestiere che voglio insegnargli”. La virtù specifica del docente è la benevolenza, rileva Morin, quella che non deve mancare in chi dispone di autorità, una virtù che non si impone ma si diffonde, mediante un clima partecipe ed erotizzato. Di qui l’elogio finale dell’Eros, lo stesso che di recente ha ricordato Massimo Recalcati: essere insegnanti in una società senza padri e senza maestri, significa fare del sapere un oggetto del desiderio, promuovere curiosità così da mettere in moto la vita e allargarne l’orizzonte. Dove non c’è amore ci sono solo problemi di retribuzione, di carriera e di noia per l’insegnamento. Quelli che sempre più si avvertono nelle assemblee sindacali della scuola, dove gli aspetti educativi scompaiono nella difesa di interessi settoriali e nella spartizione di misere risorse; non sarebbe un bel segnale evitare che le assemblee si svolgano in orario di lezione, sia per rispetto dei diritti degli studenti, sia per testimoniare che non sempre deve vincere la logica da pubblico impiego? Certo, rimane l’antica domanda “chi educa gli educatori?”. La risposta di Morin é che debbono auto-educarsi con l’aiuto degli educati, nel tempo in cui si aprono spazi di una democratizzazione della cultura. Serres ricordava (Non è un mondo per vecchi, Bollati Boringhieri 2014) che il rapporto fra docente e allievo deve tenere conto dei saperi diffusi lungo la Rete che rendono talvolta l’allievo più competente del maestro. Purtroppo non hanno ancora introdotto meccanismi di formazione che garantiscano lo sviluppo di competenze relazionali: sogno un TFA (tirocinio formativo attivo) al termine del quale si certifichi che il futuro insegnante sia in possesso almeno di un’anima …
Il libro: Edgar Morin, Insegnare a vivere. Manifesto per cambiare l’educazione , Cortina, Milano 2015, pp. 116, €11,00.