23 novembre 1980 / Irpinia, paesaggio con rovine
Scrive Daniele Del Giudice nel suo libro, In questa luce: “Ogni secolo ha le sue rovine e un suo modo di metterle in immagine facendone paesaggio”. (…..) “È comunque il paesaggio che ci è dato, una compresenza grottesca di naturale e artificiale, un fondale della quantità e dei suoi resti; difficilmente tale paesaggio potrebbe consentire quella triangolazione tra natura, io osservante e consapevolezza di una divinità diffusa che garantiva la pacificazione dell’animo romantico. Tuttavia, sono i luoghi dove viviamo i nostri rapporti con gli altri, e dove, pur con ogni altrove nella fantasia o nella nostalgia, ambientiamo i nostri sentimenti”.
A partire dalle ultime righe, in Paesaggio con rovine, Mondadori 2020, che Generoso Picone ha scritto con la penna dell’anima, si ritrovano le articolate e ambivalenti stratificazioni sentimentali e analitiche considerate da Del Giudice. Fare paesaggio, tradurre in paesaggi della nostra vita i luoghi dove siamo nati e dove viviamo, non è una scelta. Comunque siano quei luoghi e qualsiasi rovina contengano. Facciamo paesaggio dei luoghi semplicemente perché non possiamo fare diversamente.
Ciò vale se consideriamo il paesaggio non solo come il “bel paesaggio”, ma come lo spazio della nostra vita, quella dimensione che designa il nostro habit, che configura una semiosi e un senso di appartenenza, che connette il nostro mondo interno e il mondo esterno con l’incessante modellizzazione dell’immaginazione. Sappiamo oggi di essere un corpo con un cervello che producono una mente, principalmente mediante il sistema sensorimotorio e nell’intersoggettività con gli altri. Siamo esseri ecologici, non tanto perché rispettiamo gli ambienti delle nostre vite, ma perché ne siamo comunque e prima di tutto parte. Le nostre menti, oltre che incarnate, sono situate in un contesto e estese agli altri in una cultura.
Allora, nonostante il sofferto e, per molti aspetti doloroso, cammino narrativo con cui Picone attraversa i quaranta anni trascorsi dal terremoto irpino del 1980, le righe finali del libro sono un atto d’amore per quella terra, che è anche la sua terra.
Un “nonostante” costoso e ologrammatico. In quanto l’autore riesce a fare di un evento e di una storia locali per quanto rilevanti, una metafora della nostra condizione di esseri umani di fronte ai traumi che noi stessi causiamo. Siano essi traumi sismici o epidemiologici, come l’autore mostra individuando affinità psicodinamiche e comportamentali nei modi di reagire alla sismicità di un territorio o all’emergenza di una pandemia.
Siamo noi umani i protagonisti del libro di Generoso Picone.
I terremoti e le pandemie non sono eventi “naturali”, ci suggerisce con garbo e determinazione, l’autore. Se per naturale si intende qualcosa che riporta al destino, quelli non possono essere ritenuti eventi solo naturali. Siamo noi che costruiamo case in zone sismiche in modi inappropriati; siamo noi con le nostre scelte e i nostri comportamenti che portiamo in giro da un essere umano all’altro, e da una specie all’altra, i virus.
Eppure, nonostante tutto e non senza evidenziare le responsabilità verticali e orizzontali, concentrate e diffuse, la fitta e intensa narrazione di Picone mostra tutta la difficile arte di prendere la distanza dall’oggetto narrato, se quell’oggetto è allo stesso tempo interiore e amato.
Eh! Sì, la distanza, è ‘na parola! Come si dice in Irpinia, quando si vuole indicare un compito arduo che se riesce produce un esito di particolare efficacia, come accade con Paesaggio con rovine. Non si è mai capito quale sia la formula per combinare coinvolgimento e distanza, eppure si sa che proprio da quella ricerca nascono le cose migliori, sia nella scienza che nella narrazione. Tra le tante cifre del lavoro di Generoso Picone, quella della tensione tra l’essere testimone partecipe del suo mondo e il guardarlo col distacco necessario ad analizzarne le vicende drammatiche che ne hanno caratterizzato l’evoluzione recente, è certamente una delle più significative. Del resto, è quello che l’autore aveva fatto con un libro che costituisce un’esemplare espressione della ritrattistica narrativa di un popolo e di una cultura, quando nel 2005 pubblicò per Laterza, I napoletani, con una risonante copertina di Tatafiore, generando una sintesi che assunse e tuttora assume le connotazioni di un dramma senza fine, tra meraviglia e rovine.
Da un’altura e da un margine, e la scelta non sembra casuale, prende le mosse la serie di quadri per un’esposizione, per richiamare Modest Petrovič Musorgskij, di cui la narrazione di Picone ha lo stesso ritmo crescente e incalzante, con progressione mai calante, per giungere a descrivere quel che gli umani che in Irpinia vivono hanno fatto della terra in cui sono nati, e i modi che hanno messo in piedi per reagire al trauma sismico che li ha cambiati per sempre. Da una terra di miseria economica prima dei due terremoti del 1962 e del 1980, a una terra di miseria culturale, assistita e consumistica da quegli eventi a oggi. Una metafora del mondo, con tutti i suoi protagonisti, dai dominatori, naturalmente in minore, ai seguaci adesivi e interessati, tutti coinvolti nel creare un blocco sociale, un habit, proprio di una società bloccata, pietrificata nella sua incapacità di darsi un’identità e un progetto.
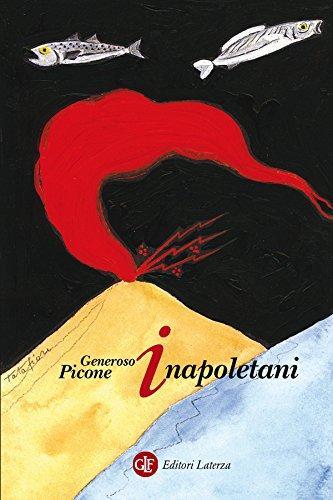
Attingendo al proprio habit, all’abitudine, gli irpini si sono dati un “terremoto infinito” come recita il sovratitolo del libro. Un terremoto che è divenuto uno sconvolgimento di menti e comportamenti, di memoria e di coesione sociale. Il disordine paesaggistico, che è capace di contenere oggi le più azzardate prove di costruzione di case e le maggiori esemplificazioni di abbandono e degrado, emerge dalle pagine di Picone, come un mosaico che si esprime in una composizione o ricomposizione dei repertori di esperienza accumulati nel tempo da cui scaturiscono creazioni mitiche, schegge di passato e improvvisazioni su temi urbanistici e su tentativi di scelte produttive, che il nostro sistema sensorimotorio, il nostro corpo, e la nostra sensibilità fanno molta fatica a tenere insieme.
Quelle emanazioni che si manifestano in forme di prassi senza o con poco pensiero derivano, molto probabilmente, da un riutilizzare, riciclare degli schemi che sono stati raccattati per un uso rapido e strumentale, dove lo scopo non era recuperare o ricostruire luoghi e vivibilità, ma sfruttare l’occasione fornita da sisma nel modo più disimpegnato e profittevole possibile. Secondo un sempre più rilevante paradigma corporeo il mondo astratto non è mai un mondo realmente astratto, è sempre qualcosa che è strutturato all'interno dell'esperienza e l’esperienza è formazione di abitudini, di habit. In questo senso il concetto di habit diventa un concetto di particolare rilevanza, perché riguarda il nostro pensiero che è sempre una preparazione derivata da schematizzazioni corporee, secondo una prospettiva da embodied cognition. Gli schemi di risposta adattati all'ambiente che, a sua volta, è anche un ambiente sociale in continuo mutamento, assumono a volte le forme del mito, creati come sono dalla narrazione e dalle sedimentazioni condivise in cosmologie e cosmografie. E delle abitudini, delle consuetudini e addirittura forme di assuefazione si sono create in quella sorta di ordine scomposto che è il paesaggio sociale, economico e urbanistico irpino contemporaneo. Nulla a che vedere con il paesaggio agrario precedente, né con una qualche forma riconoscibile di paesaggio contemporaneo: paesaggio con rovine, appunto.
Con il sisma e il trauma che ne è derivato si è creata una situazione di spaesamento incombente (Jung C. G., Gli archetipi dell'inconscio collettivo, in Opere vol. 9, Bollati Boringhieri Editore, Torino 1997), e gli esseri umani che da sempre tentano la conquista dell’abbondanza del mondo (P. K. Feyerabend, Conquista dell’abbondanza. Storie dello scontro fra astrazione e ricchezza dell’essere, Raffaello Cortina Editore, Milano 2002), si sono ritrovati a elaborare l’evento catastrofico con una posizione di dipendenza, nella quale l’assistenzialismo clientelare si è inserito come il cacio sui maccheroni.
Il mito dei consumi ha fatto il resto, creando un contesto sociale labirintico, un intrico di interesse, malaffare e clientelismo politico che ha sconvolto, con la ricostruzione, sia il sistema sociale che il paesaggio. Come documenta con precisione Picone, il sisma è intervenuto in “una natura intatta e acquietata, sospesa in un equilibrio vigile e minaccioso, come se conservasse una trattenuta energia pronta a esplodere”; l’ha sconvolta e ne ha evidenziato arretratezza e problemi atavici: “Il Sud dell’osso è fatto di pietra, acqua e vento”. Fatto sta che oggi la scena appare così: “Tanti materiali malmessi di un presente sbandato, rovine dell’inesauribile contingenza che impediscono al paesaggio di scivolare verso la dimensione dello stato di natura, scorie di una modernità goffamente inseguita e che appena sfiorata risulta già eccessiva e fuori posto portano disordine e squinternano la linea d’armonia un giorno vissuta o magari soltanto sognata”. Oggi, da ogni punto di osservazione, è difficile astenersi dal provare un profondo disagio a cui l’autore dà voce, una voce lirica e allo stesso tempo tragica: “Nella vertigine di quest’altura almeno per un attimo accarezzo la certezza che il tempo puro possa essere quello restituito dalle immagini delle rovine, dal loro spettacolo e dalla loro coscienza. Dal loro significato.
Qui il tempo è in rovina: ma che cosa è il tempo puro se non la consapevolezza delle rovine?” C’è anche il silenzio tra i protagonisti della raffinata narrazione di Generoso Picone, e non solo il silenzio delle rovine, tra i silenzi uno dei più eloquenti e rumorosi, ma il silenzio dei responsabili e dei colpevoli, nonché quello degli indifferenti e dei collusi. Ha scritto la poetessa Chandra Livia Candiani: “Il silenzio semina. Le parole raccolgono. Il silenzio è cosa viva”. Il silenzio che, nonostante le parole, si afferma per rappresentare l’indicibile: “la morte non è raccontabile”, scrive Picone, “perché il suo istante fatale rivela sempre un fatto elementare, ridotto alla “quoddità” di Vladimir Jankélévitch: l’istante della morte nella sua essenza diventa una data sul calendario e un secondo di cronometro, ‘pertanto non c’è nulla da raccontare in questo istante indivisibile, nessuna estensione discorsiva da svolgere, nessuna profondità comprensiva da inventare’”. L’estensione che Generoso Picone compie, connettendo nel corso della sua narrazione il sisma irpino con la pandemia di Coronavirus sottrae il libro al vincolo di un solo evento, per quanto catastrofico e tragico. L’analisi si fa capace di cogliere le dinamiche dei traumi e della loro elaborazione; i molteplici appunti “sull’agenda delle coscienze” che, simili a una teoria del male evitabile, tempestano la nostra storia recente.
Quando una madre partorisce lo fa con dolore. Il travaglio è condizione di ogni nascita e di ogni crescita. Come un trauma, che può essere generativo, mentre è sconvolgente. Vi sono traumi, però, che persistono in una latenza capace di neutralizzare la generatività. Proprio di una latenza che perdura da quaranta anni si occupa il racconto che Generoso Picone fa dell’Irpinia a partire dal trauma del terremoto. Con un passo narrativo pacato e stringente, denso di vita e di stacchi quasi musicali nel rendere il dramma di intere comunità nelle loro terre sconquassate, l’autore ingaggia una resa dei conti antropologica e storica, psicologica e politica, con una realtà per la quale vive un appartenente distacco. All’appartenenza vissuta e sofferta che sgorga da ogni riga, fa infatti da contrappunto una distanza non solo richiesta dall’analisi, ma voluta, nel tentativo di lenire la sofferenza derivante da una “matria” che si fa matrigna. Matria aveva chiamato un suo libro precedente, Generoso Picone.
Il neologismo con cui finalmente si riconosce la terra madre, può evocare anche un richiamo alla matrigna che la parola Matria fa venire in mente, e non sembra casuale. Quanto una terra e le comunità che vi vivono riescono ad essere ospitali, naturalmente in ragione di quello che gli esseri umani stessi ne fanno? L’analisi per molti aspetti senza concessioni che riguarda la caduta verticale del valore della vita (“Fino a quando potremo permetterci di dire che una vita umana non ha prezzo?”), accomuna ancora una volta le esperienze traumatiche del terremoto con quelle della pandemia e con la pervasività distruttiva della filiera di traumi che il nostro tempo ci consegna. Memoria e oblio, operando insieme, fanno del tempo un grande scultore, come lo ha definito Marguerite Yourcenar.
Un valore distintivo che Generoso Picone riesce a consegnarci con questo suo lavoro, frutto di un’osservazione attenta durata dal momento del sisma fino a oggi, “un istante lungo quarant’anni e novanta secondi”, è lo sguardo dal futuro e da una prospettiva planetaria, che attraversa tutto il libro. Per molti aspetti Paesaggio con rovine è una riflessione sulla condizione umana. Mi sono immaginato, leggendo, di essere al Vajont nel momento della catastrofe, o un abitante di Chernobyl, o di Fukushima, oppure di essere a New York l’11 settembre 2001, o nella crisi iniziata con la bancarotta di Lehman Brothers, o sulle Alpi nelle ore di Vaia, o ancora a Venezia con l’“acqua granda”, o ora con il Coronavirus. E la lista potrebbe continuare, perché si estende, per almeno due ragioni: la nostra presenza pervasiva e distruttiva sul pianeta, mentre ne diventiamo ogni giorno di più i padroni incontrastati.
![]()
Nel 1969 Gregory Bateson aveva scritto: “Stiamo imparando sulla nostra pelle che l’organismo che distrugge il proprio ambiente distrugge se stesso”. La nostra disposizione a non imparare ad imparare dall’esperienza e dai nostri modi di reagire ai fenomeni catastrofici, vivendo i traumi solo per tornare all’ordine precedente e non per la loro possibilità generativa di cambiamento di rotta. Picone si interroga e ci interroga sulle ragioni individuali e collettive delle resistenze al cambiamento di comportamenti di fronte ai traumi, e cerca di comprendere perché la paura e i costi dei traumi fanno così fatica a tradursi in apprendimenti e cambiamento di pensieri e azioni. Pur di non cambiare e di resistere, siamo capaci di ricorrere persino alle spiegazioni metafisiche delle catastrofi che noi stessi causiamo, o direttamente o per i modi con cui reagiamo ad esse. “Se la natura provoca le catastrofi, sono poi gli uomini a causare i disastri”, scrive Picone. Ad esempio, se dal 1315 al 2016 soltanto l’Appennino è stato interessato da 148 terremoti con entità superiore ai 5,5 gradi della scala Richter, uno ogni quattro anni, qualcosa forse si poteva imparare in termini di prevenzione. Per queste vie analitiche e narrative, un evento molecolare diventa molare e il paesaggio con rovine diventa il paesaggio della nostra vita sul pianeta Terra.
Una prospettiva autobiografica, discreta ed efficace, si fa strada nel libro, dal momento che l’autore mette in gioco e condivide la profonda presenza del terremoto nella stessa costruzione della propria ricerca e, per non pochi aspetti, della propria vita. Con le sue parole, non rinviabili, e forse non commentabili, Picone scrive: “perché noi siamo i luoghi, io sono il luogo e questo luogo, anche quando ho provato – e provo – in ogni maniera a espellerlo, a tenerlo lontano, a emanciparmi da una filiazione che possa agire come un rigurgito nel buco nero di vizi ed errori in cui questa terra è risucchiata. Io sono il luogo nel suo abbandono, nella sua incompletezza, nella sua precarietà congenita.
E dunque un’antropologia delle rovine – in fondo, che cos’altro è la mia? – è indispensabile a costruire una risposta alla domanda di senso che il luogo mi oppone, che dal luogo mi pressa”. Quell’antropologia delle rovine prende forma nel racconto e documenta non solo le rovine fisiche, inclusi gli effetti della ricostruzione, ma anche le rovine psico-sociali che dal modo di elaborare il trauma del terremoto sono derivate. “Mi accorgo che la mia scrittura nasce dal risentimento”, si confida Picone. Soprattutto per la pervicace rimozione della memoria e dei fatti, delle responsabilità e delle conseguenze.
Il contributo di Generoso Picone si fa, dall’analisi di un evento locale, domanda universale, quando si chiede:
“Perché l’Irpinia quando ha potuto, perché chiamata a doverci provare, non è riuscita a diventare diversa e migliore da quella che prima era? Perché ha mancato la grande e, per molti versi, irripetibile occasione di cominciare e non ricominciare, di costruirsi e non ricostruirsi, di darsi un nuovo inizio e non di affaccendarsi a ritessere il filo logoro che la legava al passato? Perché ha scelto di ripetere i peggiori errori di cui la sua storia era già piena e non, invece, di valorizzare quelle pagine di coraggioso protagonismo, di rompere il cerchio chiuso della più nauseante tradizione e fare di quella rottura la stella polare per il suo avvenire?” Quella di Picone è una posizione che non si acquieta. Questo fa del libro, un testo di domande che riescono ad avere una particolare fecondità, mostrando che la via non può essere mai la rassegnazione. Con un efficace excursus storico di ampio respiro, dall’economia, alla cultura, alla musica, l’autore caratterizza la storia irpina degli anni precedenti il terremoto.
Crea così un’atmosfera storico-antropologica attenta alla vita materiale, alla microstoria, al costume, allo sport e agli stili di vita, utilizzando i più avveduti paradigmi di analisi che richiamano gli orientamenti di Eric Hobsbawm o di Carlo Ginzburg. Diviene evidente, in tal modo, in quale contesto precipiti la tragedia del sisma e, per molti aspetti, emergono anche gli antecedenti evolutivi del modo di elaborarne le conseguenze. Nell’intreccio di molteplici esperienze, la cronaca si fa storia, pur non dismettendo l’ingenuità dello sguardo autentico di “una giovinezza in provincia”.
In questa trama del libro risuonano con evidenza le passioni narrative e di studioso della letteratura contemporanea di Generoso Picone. Nel narrare il “grigio colore della morte” che cala sull’Irpinia con il terremoto, dal richiamo del grido di “Il Mattino”: “Fate presto”, all’affermazione di un politico italiano, commentata da “Le Monde”: “Tutto si dimentica nel giro di tre settimane”, emergono tutte le componenti del dramma. Fino all’epilogo che porta l’autore a farsi quella che probabilmente è una delle più dolorose domande: “Quando è successo che la ricostruzione dell’Irpinia, della Campania interna, della Basilicata, le ferite nuove e le cicatrici vecchie, la celebrazione sull’altare della solidarietà di un rito rifondativo per il Sud, si sono trasformate nel coagulo marcio di un indicibile e interminabile scandalo? Sono interrogativi che mi accompagnano da quarant’anni”.
La ricerca delle risposte che Picone conduce con tenacia esplorativa, anche della letteratura nata sul tema, può essere ben sintetizzata nella citazione di un testo di Carlo Tullio Altan che così commenta la commistione tra l’azione della malavita organizzata con quella degli esponenti della politica e dell’amministrazione: “I due temi, quand’anche trattati distintamente, finirono non di meno per andare di pari passo presso i lettori, che ricordarono come l’ennesima straordinaria gara di solidarietà nazionale a seguito del terremoto del 1980 in Irpinia (e Basilicata) fosse subito andata a esclusivo vantaggio della corruzione e della malavita organizzata”. Conseguenza di tutto questo è l’affermazione di una questione morale che riguarda oggi i modi in cui l’Irpinia ha affrontato il terremoto, una questione morale che finisce per diventare una diramazione della questione meridionale, fino all’affermazione del procuratore nazionale antimafia Franco Roberti che, di fronte ai crolli di Amatrice nel 2016, affermerà: “ Non si ripeterà lo scandalo dell’Irpinia”, riducendo così al rango di scandalo la tragedia, e caratterizzando, dall’alto dell’autorevolezza del suo ruolo, lo scempio della ricostruzione.
Il ritratto del presente, tra crisi demografica, malinconia, fabbrica del consenso, tentativi di restanza, e abbandono dei luoghi, è ancora una volta accompagnato, nella narrazione di Generoso Picone, da una domanda riguardante la capacità, e i vincoli e le possibilità, che noi umani incontriamo nell’elaborare i traumi. Sul perché vince la forza dell’abitudine, facendo arretrare ulteriormente il senso del possibile, Generoso Picone costruisce una delle parti più universali e liriche del libro. La sua posizione, nonostante il rigore sofferto dell’analisi, non cede al rancore, ma conserva un senso del possibile, quel possibile che Robert Musil ha così caratterizzato in L’uomo senza qualità: “Chi voglia varcare senza inconvenienti una porta aperta deve tener presente il fatto che gli stipiti sono duri: questa massima alla quale il vecchio professore si era sempre attenuto è semplicemente un postulato del senso della realtà. Ma se il senso della realtà esiste, e nessuno può mettere in dubbio che la sua esistenza sia giustificata, allora ci dev’essere anche qualcosa che chiameremo senso della possibilità. Chi lo possiede non dice, ad esempio: qui è accaduto questo o, quello, accadrà, deve accadere; ma immagina: qui potrebbe, o dovrebbe accadere la tale o talaltra cosa; e se gli si dichiara che una cosa è com’è, egli pensa: be’, probabilmente potrebbe anche esser diversa. Cosicché il senso della possibilità si potrebbe anche definire come la capacità di pensare tutto quello che potrebbe egualmente essere, e di non dar maggiore importanza a quello che è, che a quello che non è”.
All’insegna del “nonostante” Generoso Picone conclude il libro con un atto d’amore alla sua terra:
“È insopportabile la constatazione dello spreco degli anni, la dilapidazione di un bene irriproducibile, il suo sfarinamento in speranze che diventano aspettative e infine si rivelano illusioni.
Apro la finestra, guardo le montagne che mi circondano e che tante volte mi sono sembrate la cinta di una insopportabile separatezza. Osservo il verde e il cielo, i loro colori sono impressi nei miei occhi. Mi commuovo.
Nonostante tutto, ciò mi sembra bellissimo.”









