Multitasking / Tempo, esserci e cose
Il rapporto col tempo e con le cose, oggi, ci vede particolarmente impegnati come umani, a usare la nostra distinzione per alienarla. A impegnare l’esserci per regredire allo stadio delle cose. È come se non sopportassimo di sentire il tempo e la riflessione, e allora tendiamo a neutralizzarli in un eterno presente. Parliamo, infatti, con orgoglio, di tempo reale e di multitasking. È come se non tollerassimo l’indugio della riflessione e la ricerca di significato. Passiamo, infatti, da una cosa all’altra, senza concederci, anzi evitando, di farne esperienza. Per vivere qualsiasi cosa non riusciamo a contenere l’impegno per cercare il nostro modo specifico e la nostra via, ma abbiamo un ossessivo bisogno di modelli già pronti: per gli acquisti, oltre alla pubblicità che già satura le scelte, c’è il consulente per lo shopping; per sposarsi c’è l’organizzatore di matrimoni; per le lauree c’è un rituale prestabilito e irrinunciabile, eccetera. L’indicatore forse più evidente è il linguaggio: sono fatte le frasi per dire le cose e si riducono a un repertorio canonico che assolve da impegni di ricerca e rende vana la curiosità. Persino per raccontare una vacanza diciamo che abbiamo “fatto” una certa destinazione. È diffusa l’angoscia del tempo disponibile e la vita degli adulti e dei bambini deve essere organizzata al punto che uno spazio per giocare o pensare è fonte di ansia e disorientamento. È come se invidiassimo le cose, che non vivono la distanza tra l’essere e l’accorgersi di esserci e ci impegnassimo a tornare a quando come specie eravamo pre-simbolici, impegnati soltanto in comportamenti immediati e pratici, come un’aringa, o ancor di più come un apriscatole, enti che coincidono con se stessi e non vivono la mancanza che la tensione a cercare significati porta necessariamente con sé.

Emil Nolde, Paradise Lost.
Nel mito, possiamo immaginare che Adamo ed Eva, prima di accorgersi e sentire il desiderio della mela, fossero in quella condizione alla quale noi oggi sembreremmo tendere. Ci siamo a un certo punto, accorti di noi, di esserci, perché abbiamo sentito desiderio e mancanza: perché ciò sia accaduto e accada, perché l’esserci prenda consistenza e si faccia sentire, è necessaria una presa di distanza dall’essere e quella presa di distanza comporta l’elaborazione di una mancanza. Se ci accorgiamo di noi nella trasformazione dal silenzio, dal vuoto coincidente, al riconoscimento e alla conoscenza, sembriamo oggi impegnati a non volere vivere il dolore di quel vuoto e a regredire a una saturazione, preferendo l’horror pleni all’horror vacui.
A guidarci in una fine e per molti aspetti inquietante analisi tra uomini e cose è Felice Cimatti in un testo di particolare originalità, Cose, Bollati Boringhieri, Torino 2018. Da quel testo ho tratto il riferimento all’aringa. Cimatti, infatti, mette in tensione l’essere, l’esserci e l’aringa (ma le cose tutte in un’accezione estesa, considerando cose anche noi) e avvalendosi di una serrata critica del pensiero di Heidegger, scrive:
“L’esserci, l’essere umano, per un verso è un ente come tutti gli altri; infatti è una entità materiale, ad esempio pesa, così come la sua massa corporea, quando intercetta il movimento della luce, ‘produce’ un’ombra. Allo stesso tempo, però (e in questo avverbio c’è tutta la metafisica), l’esserci non è proprio una cosa come qualunque altra, come un carburatore o un’aringa: «onticamente, esso è caratterizzato piuttosto dal fatto che, per questo ente, nel suo essere, ne va di questo essere stesso»” (citazione da Essere e tempo, di Heidegger). “Prendiamo il caso di un’aringa”, continua Cimatti, “che vive la sua umida ma intensa vita in un banco di migliaia di suoi simili nell’Atlantico settentrionale. L’aringa è un ente che attraversa i rischi di ogni ente, ad esempio essere pescata e finire in una lattina di alluminio, e poi, dopo più o meno travagliate vicende, muore, cioè smette di essere quell’ente che era stata fino a quel momento. L’«esserci», diversamente dall’aringa, e da qualunque altro ente, è qualcuno che non semplicemente vive, ma fa qualcosa della sua vita. L’esserci può essere onesto, oppure disonesto, appassionato dell’arte fiamminga, tifoso di una squadra di cricket, sincero o infido, monogamo o libertino, e così via. Ognuna di queste possibilità non è inscritta nell’esserci, come invece succede all’aringa, la cui vita è tutta nel suo destino biologico di pesce; ogni esserci si sceglie, ossia sceglie la vita che può vivere. In questo senso l’esserci è qualcosa di diverso da qualunque altro ente” (p. 49).

Questa eccezione che siamo potrebbe persino far pensare a un “errore” nel processo evolutivo. Luciano Floridi recentemente lo ha detto: “Rappresentiamo una sorta di errore di programma nel codice dell’universo, bello ma un errore” (Corriere della Sera, 25 settembre 2018). Si tratta ovviamente di un’iperbole metaforica. Non esistono errori o cose riuscite bene nell’evoluzione: l’evoluzione è quel che è e noi siamo quel che siamo così come siamo e diveniamo. Per distinguere noi dalla “cosa macchina” non umana, Floridi dice: “Le macchine non sono in grado di gestire la semantica: cose come la verità, il significato, l’ironia, il sottinteso, il leggere tra le righe, tutto questo è al di là di qualunque macchina si possa anche soltanto immaginare”.
D’altra parte, le macchine, della semantica non hanno affatto bisogno. Siamo noi, semmai, che abbiamo bisogno di domandarci perché stia accadendo che ci troviamo a gestire problemi che non avevamo neppure immaginato. Nel campo della conoscenza regrediamo al solo “come si fa”, rinunciando sempre più a domandarci “perché le cose stanno in un certo modo”; assistiamo a un primato crescente delle cose sulle relazioni, – evidenziato anche da Cimatti nel primo capitolo del suo libro –, pur essendo il mondo sempre più relazionale e meno “cosale”; il linguaggio stenta ad essere riconosciuto come costruzione della realtà ed è spesso ridotto a strumento di comunicazione; a livello etico ci concentriamo sempre più sull’etica di chi opera, mentre sarebbe necessario considerare l’etica di chi riceve le azioni.
È possibile sostenere che l’approfondita riflessione sulle cose possa servire, in fondo, a ridimensionarci, pur salvaguardando la nostra distinzione; può aiutarci a decentrarci per disporci non distruttivamente verso le cose e verso l’universo e orientare la nostra capacità narrativa verso il sistema vivente di cui siamo parte e non verso la centratura su noi stessi.
Si tratta, con ogni probabilità, di rivedere il modo in cui abbiamo interpretato la nostra distinzione, traducendola in una presunzione di superiorità.
Il momento in cui ci siamo trovati è forse anche quello in cui ci siamo perduti. Una volta che abbiamo avuto accesso alla conoscenza di noi stessi e che abbiamo avuto consapevolezza del mondo. Una volta presi dall’attrazione e dall’inquietudine della conoscenza non ne siamo più usciti. L’avvento del pensiero simbolico e del linguaggio verbale che ci ha resi la specie che non solo sa ma sa di sapere, ha messo in moto molti deliri, tra i quali quello di dominare il tempo e di vincerlo ha reso e rende faustianamente infausta la nostra vita. Essere tempestivi, decidere senza incertezza, essere simultanei o, come si dice un po’ ridicolmente oggi, multitasking, sarebbe diventato il nostro mantra, soprattutto nell’epoca attuale, in cui il possibile immaginabile e presunto accessibile travalica l’effettivo senza tregua e respiro. Tempismo e simultaneità percepiti, infatti, creano gap sempre più profondi nei nostri vissuti e in quei gap rischiamo di affogare in un mare di stress. Ossessionati dall’efficientismo, facciamo del tempo una continua arena di misura, sezionandolo e associandolo alle prestazioni competitive.
Perché noi esseri umani, da quando abbiamo consapevolezza di noi stessi, abbiamo creato e continuiamo a creare dèi di diversa forma e caratteristiche. Il dio attuale è quello della misura efficientista. Il tempo fugge e ci sfugge, siamo finiti e allo stesso tempo capaci di concepirci infiniti, e allora ci consegniamo alla simultaneità, al tempo reale che dovrebbe contenere l’infinito e al delirio di poter dominare l’incertezza ed essere eterni.
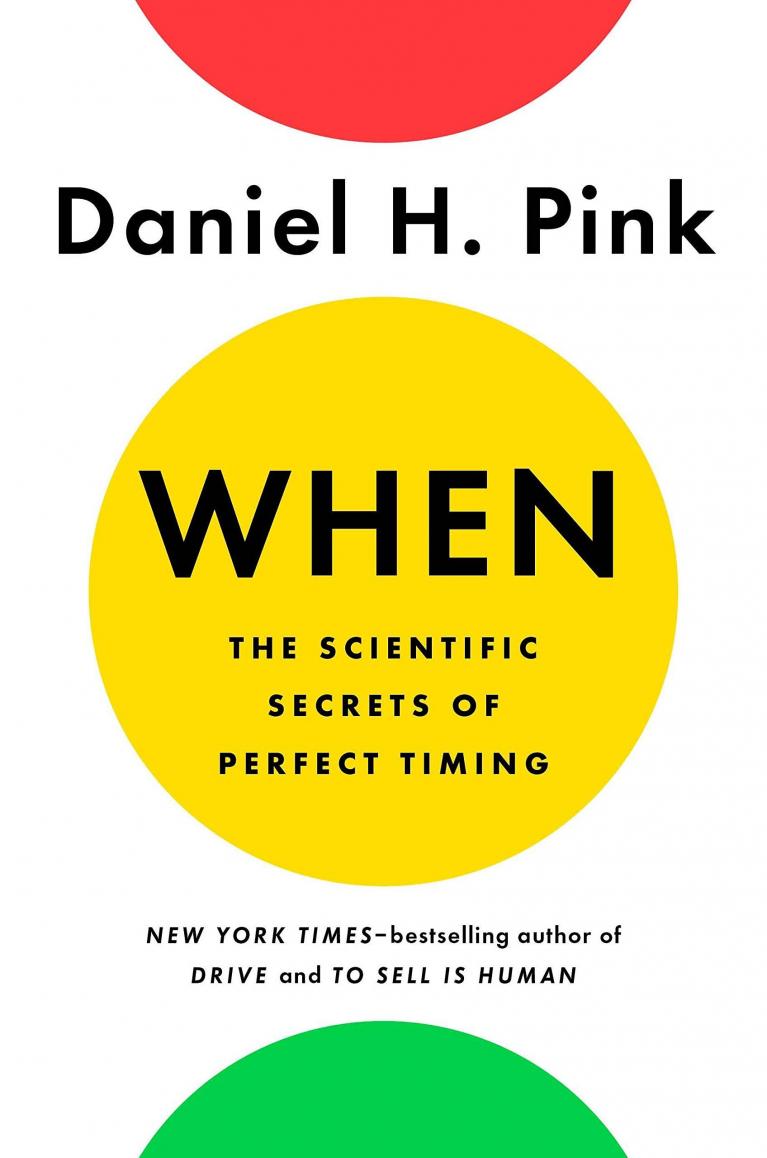
Tutto il libro di Daniel H. Pink, When, Feltrinelli, Milano 2018, ruota intorno alla questione della individuazione del tempo del giorno in cui siamo più efficienti. Gli stuoli di ricerche citate nel testo presentano una lunga serie di misure per mostrare le condizioni di tempismo più efficienti nell’arco delle ventiquattro ore. In sostanza la questione è come fare a essere automi efficienti, a diventare cose che funzionano al meglio delle loro prestazioni. Mentre si dipanano le verifiche sperimentali raccontate, controluce si presenta una regressione a selezionare i comportamenti capaci delle migliori performance nell’uso del tempo, nel corso del giorno. Per certi aspetti nulla di nuovo: il taylorismo, nella visione e nelle aspettative del suo fondatore, l’ingegnere F. W. Taylor, si era posto il fondamentale problema della discrezionalità e della distinzione creativa umane, identificandole come fattori di disturbo della funzionalità ottimale del processo di produzione. Certo, oggi, sembra essere di fronte ad una estensione del taylorismo, altro che la sua crisi, dalla fabbrica e dai luoghi di lavoro alla società. La mitica lotta tra kronos e kairòs, nella tradizione ellenistica, non ha più ragion d’essere dal momento che kronos diventa l’unica misura non solo del tempo ma anche dell’esserci.
Mentre le analisi contenute nel libro sembrerebbero orientate alla ricerca delle condizioni per scegliere il momento giusto per fare le cose, di fatto ne emerge un paradigma dei modi di vivere ed essere, con una centratura dominante sull’efficienza, o meglio sull’efficientismo. L’idea di base è che il tempismo è tutto nella vita e per questo è necessario sapere il più possibile come fare a perseguirlo. Non è solo un problema di non perdere tempo, ma di usare il tempo in base a un principio di immediata produttività efficiente. La vita è presentata come un flusso incessante di decisioni per le quali il “quando” è cruciale, è la misura, è il criterio. Il libro esamina, allora: “Oltre settecento ricerche nei settori della psicologia, biologia ed economia per scoprire la scienza del tempismo. Le nostre capacità cognitive non rimangono allo stesso livello nel corso della giornata: siamo più intelligenti, più veloci, più spenti, più lenti, più o meno creativi in alcune parti del giorno rispetto ad altre. Perché è più probabile commettere errori nel pomeriggio? Pause pranzo, sonnellini e passeggiate possono renderci più efficienti? E ancora, qual è il momento migliore per fare esercizio? Esiste un rimedio alla inevitabile crisi di mezza età?”.
Una nota di saggezza, tuttavia, sembra giungere nelle pagine conclusive del libro. Dopo aver riconosciuto che quando proviamo meraviglia il tempo rallenta, si espande, ci sembra di averne di più e quella sensazione migliora il nostro benessere, l’autore scrive:
“Presi insieme, tutti questi studi suggeriscono che il percorso verso una vita ricca di significato non consista tanto nel ‘vivere nel qui e ora’ come consigliano tanti guru spirituali. Consiste invece nell’integrare le nostre prospettive nel corso del tempo in un insieme coerente, che ci aiuti a comprendere chi siamo e perché siamo qui” (p. 180).
All’incalzante progressione dei contenuti del libro di Pink fa da contraltare un contributo ironico e compassato di Svend Brinkmann, Contro il self help. Come resistere alla mania di migliorarsi, Raffaello Cortina Editore, Milano 2018. Il punto di partenza è lo stesso e riguarda la progressiva e costante accelerazione del ritmo della nostra vita. Brinkmann sottopone a critica l’ossessione diffusa di stare al passo dei ritmi incessanti della quotidianità. Abbiamo organizzato le nostre vite all’insegna della rincorsa del successo ad ogni costo e per questo viviamo in un perenne movimento e adattamento. Si tratta dell’esasperazione di una caratteristica di homo sapiens che trasformando il mondo in cose a sua disposizione tende a reificare se stesso, a trasformare, regredendo, anche se stesso in cosa, spezzettando la propria esperienza e riducendola funzione ed uso. Il bisogno di essere riconosciuti si trasforma in urgenza di successo e, come aveva intuito Andy Wharol nella sua arcinota affermazione, ognuno cerca di essere famoso per almeno un quarto d’ora. L’essere oggetto dell’uomo non è qualcosa che stia dentro l’uomo, ma è l’uomo che trasforma se stesso in oggetto. I livelli di stress, depressione e infelicità, che derivano da questo stato di cose, sono sotto gli occhi di tutti. Interessante è l’espressione “stato di cose”, per noi esseri umani che siamo in quanto diveniamo e non siamo cose né esseri che coincidono con se stessi; per noi che siamo, quindi, “esserci in movimento”. Il fatto è che, nonostante il nostro impegno, è per noi impossibile ridurci effettivamente a uno stato di cose e da questo deriva la nostra alienazione la nostra fatica di vivere, il nostro stress e la nostra depressione. La stessa crisi del legame sociale è evidentemente connessa alle interazioni opportunistiche che dominano la scena sociale. In un clima generale siffatto diventa difficile resistere alla mania dello sviluppo di sé basato sull’esasperazione del successo. Brinkmann prende in considerazione in particolare la perversione del cosiddetto self-help, dell’autoaiuto. In discussione vanno tutte le molteplici forme di life-coaching, di “pensiero positivo”, di consulenze per l’autoaffermazione che popolano la nostra esperienza con un’aura di normalità e necessità.

Gli oggetti che popolano le nostre vie, dunque, sono divenuti capaci di penetrare in noi al punto di fare di noi stessi degli oggetti? Le relazioni e le culture prendono forma attraverso gli oggetti e il mondo delle cose che ci circondano?
Il diventar umano del vivente passa, tra l’altro, attraverso il riconoscimento degli oggetti. Nel gioco tra l’interno e l’intorno gli oggetti fanno da mediatori. Non rimangono, spesso, neppure intorno ma entrano dentro, come accade con le protesi, e quella continua transizione, tra l’inventarli, il crearli e usarli fa degli oggetti, in una singolare misura, una parte di noi. Nella elaborazione della distinzione, tra simbolizzazione e presa di distanza, si pone una questione di significati, di attribuzione di senso. Prima ancora, forse, tutto inizia dal movimento, dal sistema senso-motorio che incorpora gli oggetti che noi stessi creiamo nel nostro schema corporeo: Paul Schilder, allievo di Freud, nel 1923 parlava di Körperschema (schema corporeo). Come scrive Jean-Pierre Warnier nel saggio sulla soggettivazione in un mondo di materialità contenuto nel volume curato da Luca Ciabarri, Cultura materiale. Oggetti, immaginari, desideri in viaggio tra mondi, Raffaello Cortina Editore, Milano 2018, se Marcel Mauss avesse potuto conoscere la tesi di Schilder avrebbe trovato la risposta alla domanda su come facesse un uomo kabilo a scendere rapidamente da un ripido pendio senza perdere le sue pantofole. Scrive Warnier: “Questo infatti accade perché le pantofole sono incorporate nelle sue abitudini motorie attraverso un lungo apprendistato. Esse appartengono di fatto al suo Körperschema. Egli è un uomo-con-pantofole. Mauss avrebbe così compreso che ‘il corpo’ a cui egli era così interessato non è la somma anatomo-fisiologica di tutti gli organi umani, è piuttosto una sintesi dinamica di motricità-sensoriale all’interno di una data materialità” (p. 309). La soggettivazione avviene in un gioco circolare e paradossale nel quale l’inventore degli oggetti è a sua volta inventato dalle proprie invenzioni.
Fino alla personificazione di quanto inventato. Per cui non solo siamo parte del sistema vivente ma la distinzione fra “naturale” e “artificiale”, cioè fatto ad arte da noi stessi, sfuma e l’una dimensione sconfina nell’altra e in noi, contenendoci e costituendoci. Tutto ciò non avviene nel rapporto tra un individuo solo e un oggetto. Nelle molteplici articolazioni delle relazioni intersoggettive, da cui emergono orientamenti e costrutti che compongono una cultura, tra approssimazioni, comprensioni, malintesi e cooperazione interpretativa, noi esseri umani sembriamo danzare intorno agli oggetti che creiamo, i quali ci trascendono e ci sopravvivono e si lasciano incorporare: mentre noi li usiamo, gli oggetti sembrano usarci per perpetuare la loro presenza e la loro generazione di significati. Gli oggetti sono intermediari nella nostra intersoggettività costitutiva e ci aiutano a regolarci nelle relazioni con gli altri. Sono sodali della nostra domanda così come la formula Philip Roth in Pastorale americana: “Eppure, come dobbiamo regolarci con questa storia, questa storia così importante, la storia degli altri, che si rivela priva del significato che secondo noi dovrebbe avere e che assume invece un significato grottesco, tanto siamo male attrezzati per discernere l’intimo lavorio e gli scopi invisibili degli altri? (…) Rimane il fatto che, in ogni modo, capire bene la gente non è vivere. Vivere è capirla male, capirla male e male e poi male e, dopo un attento riesame, ancora male. Ecco come sappiamo di essere vivi: sbagliando”. Gli oggetti, intermediando, rassicurano, fornendo basi di significato che concorrono a costituirci. Vi è un gioco tra soggettivismo e oggettivismo. C’è oggetto solo per il soggetto, e viceversa.
Cosa contiene un oggetto di tutta la dimensione psichica di un essere umano? Ogni oggetto emerge da una proiezione e interiorizzazione in cui “l’interno” e “l’intorno” sconfinano l’uno nell’altro fino a con-fondersi. L’oggetto, infatti, finisce per contenere l’esperienza psichica che può essere in esso depositata. Gli esiti della circolarità tra soggetto e oggetto possono essere di estensione ed emancipazione, o di regressione. Non sembra possibile comprendere queste dinamiche complesse che costituiscono le culture umane e l’individuazione psichica e collettiva ricorrendo a pure e semplici spiegazioni meccanicistiche.
Ben più complessa appare la questione se, come fa Felice Cimatti nel libro che abbiamo considerato sopra, ci domandiamo di cosa parliamo quando parliamo di cose.
Non è secondario approfondire la differenza che si può riconoscere tra cose e oggetti. Mentre le prime hanno l’aria di giacere inerti se non attivate dalla nostra considerazione, i secondi sembrano più vicini a noi in quanto esito della nostra costruzione tecnica e operativa. Gli oggetti sembrano, in una certa misura, una mediazione tra noi e le cose.
L’oggetto è “un concentrato del mondo”, come lo definì Michel Maffesoli in una sua riflessione sulla natura morta (M. Maffesoli, Nel vuoto delle apparenze. Per un’etica dell’estetica, Garzanti, Milano, 1993). Tra la funzione degli oggetti ve n’è una che risulta cruciale per la nostra riflessione e riguarda la loro collocazione fra memoria, oblio e ricordo. Il processo di ritenzione e selezione che si svolge a quel livello è in buona misura possibile grazie agli oggetti.
Nei saggi contenuti nel libro di Ciabarri emerge un articolato mosaico del quale ogni tessera evidenzia un differente e significativo incidere degli oggetti nella costruzione della realtà, delle relazioni sociali, delle identità culturali e delle caratteristiche individuali.
Considerando la storia del nostro rapporto con gli oggetti e le cose nella sua introduzione, Ciabarri, ne riepiloga l’evoluzione, ne ribadisce la sua centralità all’interno dell’antropologia sin dalle analisi dei suoi padri fondatori nella seconda metà dell’Ottocento e di come sia progressivamente mutato l’atteggiamento verso il ruolo sociale degli oggetti grazie proprio alle riflessioni di antropologi, tra cui quelle di Mary Douglas e Baron Isherwood, di Daniel Miller, di Arjun Appadurai e Pierre Bourdieu, ma anche di studiosi della società dei consumi, a partire da Jean Baudrillard che già in Il sistema degli oggetti, Bompiani, Milano, 2003 (la cui prima edizione era del 1968) ha mostrato come gli oggetti siano tutt’altro che inerti, anzi agenti piuttosto attivi ed eloquenti, come si afferma da tempo anche negli universi della finzione, mettendo in evidenza le relazioni privilegiate che stabiliamo con essi.
Strana vicenda la nostra, quella di esseri che sollevano le cose da dove se ne starebbero appiattate dando loro significato; esseri costruttori di oggetti a cui ci affezioniamo e da cui traiamo memoria e senso della vita, di noi stessi e degli altri, al punto, sembrerebbe, che quando gli oggetti divengono miti nel processo di consumo che ci pervade, è come se fossimo da loro assorbiti fino a identificarci con essi. Trasformiamo cose in oggetti che, da noi mitizzati in processi di consumo e in un vissuto dello stesso tempo di vita come se fosse un oggetto di consumo, alienano la nostra esperienza assorbendoci al punto da indurci nella tentazione di neutralizzarci in cose.

K. Frohsin, Cokework.
L’analisi della presenza e diffusione della Coca Cola nella DDR, non tanto e solo della bibita, quanto dell’oggetto simbolo, in uno dei saggi contenuti nel libro curato da Ciabarri, è capace di evidenziare con particolare intensità quello che un oggetto può essere, istituendo un’ambiguità che può divenire trasformatrice di un intero sistema.
Del resto è opportuno domandarsi se si possa emendare il nostro linguaggio dalla sua caratteristica costitutiva di creare metafore delle cose? Non si può, perché noi sentiamo e sappiamo di esserci, noi e le cose. A differenza degli altri animali: “L’ape vola di fiore in fiore”, scrive Cimatti, ma dal suo punto di vista l’ape si trova sempre e soltanto in un unico evento motorio-percettivo, trascinata dal profumo del nettare e dai colori dei fiori: quando si posa su un fiore è solo dal punto di vista umano che possiamo dire che si è posata su un oggetto, per poi prendere il volo verso un altro oggetto. Per l’ape si tratta di un evento continuo, a cui partecipa esattamente allo stesso titolo del vento, del profumo, del sapore e del colore. C’è l’evento ape-profumo-vento-zucchero-colore e così via, non: l’ape e il fiore, il soggetto ape e l’oggetto fiore” (pp. 50-51).
È stato Samuel Beckett, come ci ricorda efficacemente Cimatti, a cercare di “cosificare la parola”, a disambiguarla volendola svuotare dall’interno. Secondo Cimatti il problema di Beckett non è tanto l’incomunicabilità, quanto come esaurire il linguaggio. “Il problema è la cosa del corpo, che il fatto del linguaggio rende irraggiungibile. Il punto non è quello che le parole non dicono, al contrario, è arrivare al punto di non aver più bisogno delle parole; lì c’è la vita indicibile del corpo, lì c’è la Cosa…” (p. 95). Una originale associazione è quella che Cimatti fa con Cézanne. Criticando l’ingenuità di chi vuol far parlare direttamente le cose, senza accorgersi che in questo modo semplicemente confonde la propria voce con quella (presunta) del mondo, Cézanne è messo in scena con il suo proposito di “rendere l’immagine che vediamo, dimenticando tutto ciò che è apparso prima di noi”. “Cézanne può permettersi la sua assoluta fedeltà alle cose proprio perché non dimentica mai di essere lui stesso cosa, e di essere il corpo che è lì di fronte al Mont Sainte-Victoire…” (p.137).
Quali evenienze siano occorse per giungere a cercare di neutralizzare lo spazio e la distinzione tra noi e le cose del mondo, fino ad agire per essere noi stessi regrediti a “cosa”, certo non nella ricerca ossessiva di chi come l’artista Cézanne sfida l’esserci per motivazioni poetiche ed estetiche, ma di chi oggi – la maggior parte di noi – vive con l’ossessione di neutralizzare il tempo e la riflessione, di censurare l’accorgersi fermandosi a guardare e considerare, non è facile da verificare e spiegare. Certo è che i dispositivi della vita quotidiana e le forme di vita ordinarie sembrano caratterizzate da obiettivi più o meno consapevoli di neutralizzazione del riflettere e del sentire, del legame e della ricerca di significato, con esiti di indifferenza.
Quella particolare forma di illusione, il “parer vivo”, che ha caratterizzato soprattutto la prospettiva, poteva essere letta secondo l’individuazione dei tre principi antropologici definiti da Carlo Severi in quel libro di particolare rilevanza analitica che è L’oggetto persona. Rito, memoria, immagine, Einaudi, Torino 2018. Le immagini degli oggetti e, in particolare delle opere d’arte, secondo Severi, possono essere ricondotte a tre principi antropologici di intellegibilità: “lo studio delle operazioni mentali coinvolte nella rappresentazione iconica e nei processi di ‘costituzione della soggettività’ che queste operazioni presuppongono; la definizione di un loro specifico universo del discorso e, infine, la creazione di serie iconografiche che costituiscono, secondo la formula di Claude Lévi-Strauss, soluzioni visive a altrettanti problemi logici” (Severi, p. 271).
La pervasività delle cose, ma soprattutto l’invasività della loro dimensione virtuale, trasformano il nostro rapporto con il tempo e le cose stesse. Queste ultime in un primo momento, con la società dei consumi, avevano assunto una forza emozionale, perfino erotica, che l’universo degli oggetti possedeva e trasmetteva agli esseri umani, come aveva narrato Perec, in Le cose, Einaudi, Torino 2011. Le cose non sembrano stare più così. È la distanza che sembra in crisi. Se Italo Calvino poteva sostenere che noi umani siamo distinti da una forma di creatività contro le stesse regole che la rendono possibile e siamo capaci di “inventare il labirinto da cui trovare l’uscita”; se George Perec sostiene una creatività secondo le regole – ogni combinatoria ristretta permette combinazioni illimitate –, è necessario riflettere sul destino della nostra capacità di dire di no e di generare l’inedito nel contesto cambiato profondamente in cui viviamo. Lo stesso Perec si schiera contro la creatività ridotta a comunione mistica ed estetica dell’estasi, dove tutto è permesso e niente è possibile (G. Perec, La cosa, (1967), con nota di lettura di Paolo Fabbri, EDB, Bologna 2018).
Se tutto è permesso e niente è possibile vale la pena chiedersi perché siamo impegnati a neutralizzare l’esserci? È come se fossimo impegnati a diventare cose, rischiando di riuscirci, ma senza poterci di fatto riuscire, in quanto essere dotati di pensiero e comportamenti simbolici. E qui sta la nostra fatica di vivere oggi, alla ricerca di una rassicurazione e di una difesa dall’ansia di mancanza e dalla fatica di pensare, da ogni apprensione, la cui elaborazione richiederebbe una rassicurazione che questo tempo non sembra in grado di offrire.









