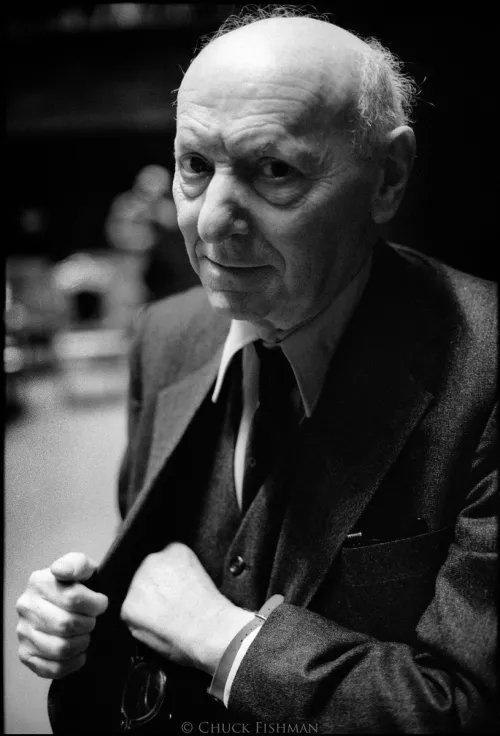I. B. Singer, dio, sesso, letteratura
Per farvi capire il mio attaccamento all’opera di Isaac B. Singer, vi dirò solo che l’ultima versione del mio testamento l’ho scritto sulla pagina del frontespizio interno di Ombre sullo Hudson. Parlo di ultima versione, perché da quando – alcuni anni fa – ho deciso di mettere nel mirino la morte, il mio testamento ha subito diverse correzioni. Diciamo che sono alle terze bozze. Sapete dove si trovano le altre due? Rispettivamente all’inizio di Nemici e de Il ciarlatano. Finché c’è vita c’è tempo. E a che cosa serve il tempo, se non a correggere le bozze della vita? Sì, d’accordo. Solo che il tempo finisce e tu, preso da mille impegni, non hai consegnato al Grande Editore la versione definitiva. La letteratura, forse, è nata per questo: perché tu, confidando nel giudizio del Grande Editore, ti illuda che sia possibile redigere una versione definitiva della tua esistenza. Sempre che non venga meno l’altra illusione, l’illusione di tutte le illusioni: che solo ciò che è individuale sia giusto e vero.
***
Beh, Singer, da buon ebreo, è sempre stato, a suo modo, un uomo di fede: credeva, a differenza di noi, in Dio e nell’individuo.
Credeva che l’uno e l’altro fossero enigmi. Credeva nella ragione e nelle passioni: la prima abbonda nella mente di Dio, mentre le seconde in quella degli uomini (“L’uomo è una povera creatura per quanto concerne la ragione, ma un milionario nel campo delle emozioni”). Credeva nel talento, consapevole che è “un’oasi in un deserto di cattivo gusto”. Credeva che tutto ciò che ci circonda sia una sorta di miracolo di fronte a cui non possiamo che meravigliarci e interrogarci. Da bambini, da giovani, da adulti, fino alla fine.
Leggete Alla corte di mio padre, dove Singer raccoglie le memorie della sua infanzia, della sua adolescenza e della sua prima giovinezza in Polonia!
Figlio di un rabbino e di una rabbina e discendente da generazioni di hassidim e cabalisti, è allevato in una casa dove la religione ebraica è come “l’aria” che si respira. Di giorno, quando chiunque abbia l’anima in subbuglio viene a sfogarsi, a pregare, a ricevere consigli. Di notte, quando fantasmi, dibbuk e spiriti dei morti fanno capolino ai piedi del letto. Ebreo della Diaspora, il piccolo Isaac attende il Messia, il quale non avrebbe solo redento questo mondo e riconquistato la terra perduta, ma avrebbe giudicato tutti, ebrei e gentili, e sradicato ogni male. Secondo il Talmud, la terra di Israele si sarebbe estesa a tutte le nazioni e un tempio di fuoco sarebbe sceso dal cielo a Gerusalemme. Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosé, re Davide, Rachele, Lea, le loro serve Billa e Zilpa, tutti i profeti, i saggi, i santi, sarebbero risorti. Lui, i suoi fratelli, sua sorella, sarebbero entrati nel palazzo in cui re Davide sedeva “su un trono d’oro” e lo avrebbero chiamato “Nonno”! Tutto ciò sarebbe stato possibile, certo, ma ci si deve comportare da ebrei pii, studiare la Torah, pregare ogni giorno e non disobbedire ai genitori.

Dentro le mura domestiche di via Krochmalna, a Varsavia, vige la legge del padre e di Dio. Ma fuori? Fuori c’è il caos: guerre, rivoluzioni, massacri, ma anche migliaia di individui umili e semplici, “sarti, calzolai e portatori d’acqua dai quali dipende l’esistenza del mondo”, in cui potrebbero nascondersi i trentasei giusti. Se le “parole dei sapienti sono come tizzoni ardenti”, un buon ebreo sa che spesso la grandezza si veste di povertà e di ignoranza. Senza contare che molto presto il piccolo Isaac registra che “per la maggioranza delle persone, è breve il passo tra volgarità e finezza, tra pugni e baci, tra sputare in faccia al vicino e colmarlo di gentilezze”. Fuori, il mondo è confusione, insidia, vanità, ma anche continua sorpresa. E il piccolo Isaac affacciato al balcone è pieno di domande, ossessionato com’è “dai paradossi del tempo, dello spazio e dell’infinito” e, inoltre, convinto “di dover risolvere quegli enigmi da solo”.
Da solo? Da solo senza l’aiuto di Dio? Dio è o non è la spiegazione di tutte le cose, la risposta a tutte le domande, come afferma suo padre? E dove si trovano tutte le risposte? Nei libri sacri, certo. Ma i libri sono scritti dagli uomini. E poi di libri ce ne sono a migliaia. E in alcuni si dice che la vera religione non è quella di Mosè, ma quella di Gesù. E in altri ancora – soprattutto quelli che suo fratello maggiore Israel Joshua, ritenuto un nemico di Israele dai genitori, gli procura – si dice che l’universo non è stato creato da Dio, ma dal caso, si dice che gli uomini non discendono da Adamo, ma dalle scimmie. Dio, è scritto in quei libri, non fa miracoli. Tutto ciò che vediamo e sentiamo è opera della Natura. Chi ha creato quel minuscolo acaro, “più piccolo di una capocchia di spillo” che il padre a volte trova aprendo la Bibbia? “Se tutti i professori del mondo si mettessero insieme, riuscirebbero a creare un solo acaro?”. Cosa rispondere al padre? Se Dio non esiste, chi ha creato l’acaro? Il fratello Joshua risponde: la Natura. “E chi ha creato la Natura?”, ribatte il piccolo Isaac.
Non c’è fine alle domande. Non c’è fine neppure al desiderio di conoscere tutti i libri, soprattutto quelli proibiti, soprattutto quelli pieni di “pettegolezzi” che il fratello Joshua chiama “letteratura”, come quello in due volumi in cui uno studente ha ucciso una megera e per questo soffre, si agita e si inabissa in ragionamenti che a Isaac ricordano la Cabala.
Che fare? La soluzione che il piccolo Isaac intuisce, che il giovane Isaac adotta e che il maturo Isaac conserverà fino alla fine dei suoi giorni, sarà paradossale: stare dalla parte di Dio, ma contestandone le azioni, o la mancanza di azioni. Non riuscendo a trovare pace né abbracciando il Dio degli ebrei né quello di Spinoza (la cui Etica, assieme ai romanzi di Dostoevskij non smetteranno mai di affascinare Singer), si adopererà a condurre una “guerra privata contro l’Onnipotente” allo scopo di rivendicare per ogni individuo il diritto di “protestare contro le violenze della vita”. Come dirà in A Little Boy in search of God, ulteriore capitolo delle sue memorie:
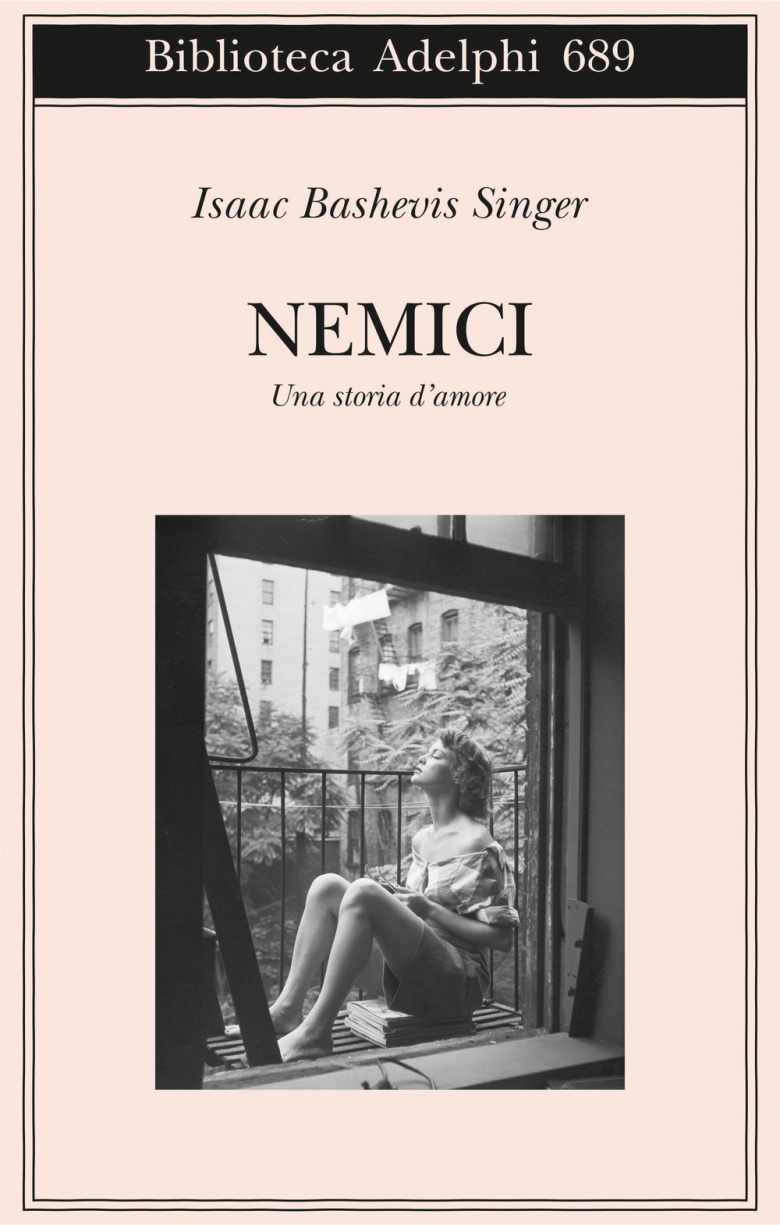
L’uomo non era obbligato a ringraziare Dio per tutte le epidemie e catastrofi che lo aggredivano praticamente dalla culla alla tomba. Il fatto che Dio possedesse una quantità incommensurabilmente superiore di sapienza e potere rispetto a noi, non Gli dava il diritto di tormentarci, anche se i suoi motivi erano i più puri e saggi.
Stare con Dio, ma non poterlo amare come impone la Torah. Né poterLo negare come vogliono tutti i materialisti. L’“etica contestatrice” di Singer si ridurrà a un unico precetto: trattare quanto meglio è possibile gli individui e gli animali (da qui il suo vegetarianismo). Tutti, secondo Singer, individui e animali, hanno il diritto e il dovere di indignarsi, “non solo quando subiscono un torto”, ma anche quando assistono “alle sofferenze altrui”:
Se Dio vuole torturare le sue creature, oppure si sente costretto a farlo, sono affari suoi. Il vero contestatore esprime la propria protesta evitando con ogni impegno di fare del male…
Nella prima pagina di Alla corte di mio padre, Singer scrive che il libro “racconta la storia di una famiglia e di una corte rabbinica così vicine tra loro che era difficile dire dove finisse l’una e cominciasse l’altra”. Tuttavia, verso la fine del libro, quando, ormai grandicello, frequenta “il mondo dell’Illusione”, cioè la bohème di scrittori e artisti ebrei che il fratello Joshua gli ha fatto conoscere, deve ammettere che in lui è avvenuto un “grosso cambiamento”. Sin dai suoi primi racconti, infatti, un “solo passo separa la casa di studio dalla sessualità e viceversa”. Dio e il sesso – “il bisogno sessuale è assolutamente legato alla forza spirituale e non a quella fisica” – continueranno a interessarlo, fino a diventare “lo schema” di ogni suo racconto, di ogni suo romanzo, la duplice fiamma che brucia in ogni suo personaggio. Continueranno a incatenarlo alla ruota del tempo allo scopo di redigere, correzione dopo correzione, la versione definitiva della sua esistenza.
Tutta l’opera letteraria di Singer potrebbe essere definita come una lunga avventura erotica in cui non ci si stanca di declinare le infinite variazioni dei rapporti tra i due sessi. Non che non gli interessino la Storia, la politica, il pensiero filosofico, i cambiamenti sociali. Solo che la sua natura lo porta altrove.
Del resto, sin da piccolo, ha scoperto che nell’Antico Testamento e nella Cabala il sesso è di casa. Dio si accoppia con la Divina Presenza, che è di fatto sua moglie, e i loro figli sono il popolo di Israele. Sebbene i cabalisti mettano in guardia nel prendere le loro parole alla lettera, risulta evidente agli occhi del piccolo Isaac che Dio e la Divina Presenza, così come tutti i maschi e le femmine del cielo, si amano e copulano in tutti i modi. Patriarchi, re Davide, Salomone possiedono diverse mogli e amanti con cui fanno l’amore per la gloria di Dio. Del resto, nel libro della Genesi, l’atto sessuale è definito “conoscenza”. Copulare tra maschio e femmina è un modo di conoscersi (ce n’è, forse, uno più profondo?). Le anime desiderano fondersi una nell’altra. Perciò il corpo stesso deve essere composto da una qualche forma spirituale. Se il principio maschile e quello femminile hanno tanta importanza in cielo, cosa c’è di male a raccontare le loro capriole sessuali qui sulla Terra? Tanto più che la Natura – con cui Dio sembra continuamente scontrarsi – sembra retta allo stesso modo: la legge della fecondazione regna fra gli animali come fra le piante. Tanto più che il piccolo Isaac comincia a essere terribilmente attratto dalle ragazze che giocano nel cortile o sulla strada. Si chiede: sono come me? No. Sono diverse in tutto, eppure mi piacciono. Sono un mistero! Anch’io sono un mistero per me stesso. Forse, raccontando gli infiniti modi in cui un uomo e una donna si incontrano e si amano (“tra un uomo e una donna tutto è possibile”), riuscirò, ne sono convinto, un giorno a raccontare il mistero di Dio.
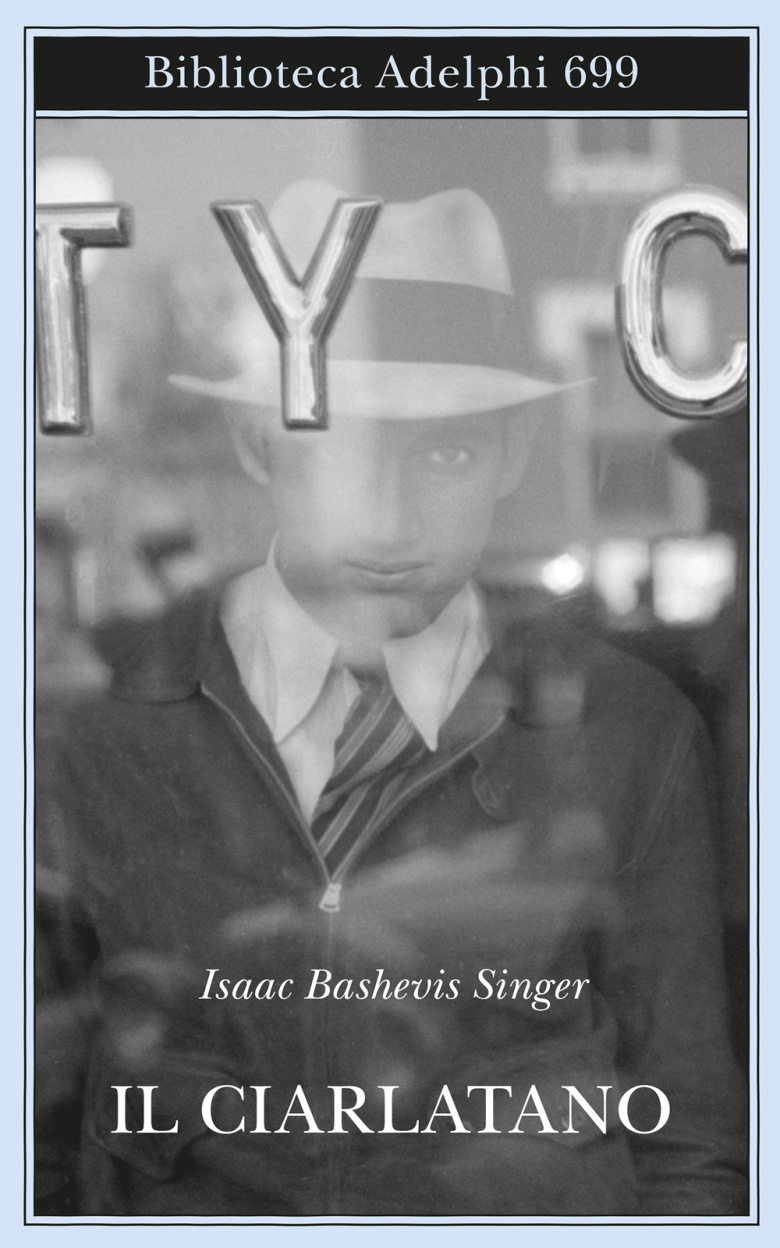
Fra tutti i brani autobiografici in cui Singer si impegna a esplorare la natura misteriosa del sesso, ce n’è uno che mi è sempre parso impagabile per bellezza e humor.
Si trova nell’ultima parte delle sue memorie, in Lost in America. Un Singer esule e squattrinato, scrittore yiddish ancora alle prese con le difficoltà della lingua inglese e con problemi di visto, se ne va a Toronto con Zosia, una donna che si è offerta di accompagnarlo e di aiutarlo. Ma a un patto: di liberarla “dall’onta di essere tuttora vergine, a un’età in cui le altre donne disponevano di mariti o di amanti o di entrambi”. Dopo la cena se ne tornano in hotel. Desiderando mantenere la promessa, il buon Singer si appresta all’azione. Ma improvvisamente “uno spirito maligno”, un dibbuk, si impossessa di lui. Forse certi accordi non si dovrebbero fare, pensa. Sono moralmente sbagliati e rovinano l’attesa. “Il sesso, come l’arte, non può essere praticato a comando”. Il desiderio è svanito. Più che il desiderio l’eccitazione:
Che vergogna, pensavo, dover dipendere dalla limitata quantità di sangue e dai pochi nervi che provocano l’erezione! Diversamente dalle altre membra del corpo, il pene possiede l’autonomia di funzionare o non funzionare secondo le proprie attrazioni o repulsioni etiche ed estetiche. È un organo che i cabalisti definivano “il segno del sacro patto”. Il suo nome era yesod, lo stesso di una delle dieci sfere dell’emanazione divina. Ciò che ora provavo in realtà era una sorta di erezione negativa, se è possibile usare un’espressione del genere. Il mio pene cercava di nascondersi alla chetichella, di rattrappirsi, di sabotarmi e di punirmi per aver osato prendere una decisione senza il suo consenso, farmi benefattore per suo conto.
La notte trascorre senza che succeda nulla. “Il signore del dispetto” che sovraintende alle pratiche amorose ha vinto. Tuttavia il buon Singer non si abbatte. La lezione, forse la più importante, l’ha imparata molto tempo prima, sfogliando all’insaputa del padre le pagine della Cabala: “i nostri genitali, che nel linguaggio delle persone volgari sono sinonimi di stupidità e insensibilità, sono in effetti espressione dell’animo umano, sfidano la lussuria, sono i più ardenti difensori del vero amore”. Senza di essi, nessuna estetica, nessuna etica, nessun “sacro patto”, nessun vero amore. E, di conseguenza, nessuna possibilità di raccontare, attraverso il mistero dell’altro, il mistero di Dio.
Non ho mai creduto alla “vulgata” di un Singer puro affabulatore, “narratore di storie nato”, come una volta lo definì un critico americano. Se ce ne fosse stato bisogno, ne ho avuto ulteriore conferma dallo stesso autore.
Di recente è uscita in Italia una raccolta di saggi dal titolo A che cosa serve la letteratura? in cui Singer esprime le sue idee sull’arte, la letteratura, la religione e la cultura ebraiche. Diciamolo subito: non è un’opera di Singer, nel senso che non l’ha pubblicata in vita, né ha lasciato scritto che venisse pubblicata, né ne ha lasciato un disegno, o un indice. Si tratta di un’opera postuma che, di solito, significa: pubblicata senza la volontà del suo autore, grazie alla volontà di coloro i quali ritengono che tradire la volontà dell’autore sia non solo un loro diritto ma un loro dovere. Si potrebbe affermare che per costoro la missione sia riuscire dove l’autore ha fallito! La cosa è piuttosto interessante nel caso di Singer. Ricordo che in una delle sue conversazioni con Richard Burgin (Conversations with Isaac Bashevis Singer, 1985) riferì al suo interlocutore, che sperava che a nessuno, dopo la sua morte, venisse in mente di tradurre in inglese ciò che aveva scritto in yiddish o di pubblicare ciò che non aveva desiderato pubblicare: “Non c’è un Max Brod nella mia vita […] Non posso bruciare i miei manoscritti. I miei manoscritti sono pubblicati”. Così va il mondo!
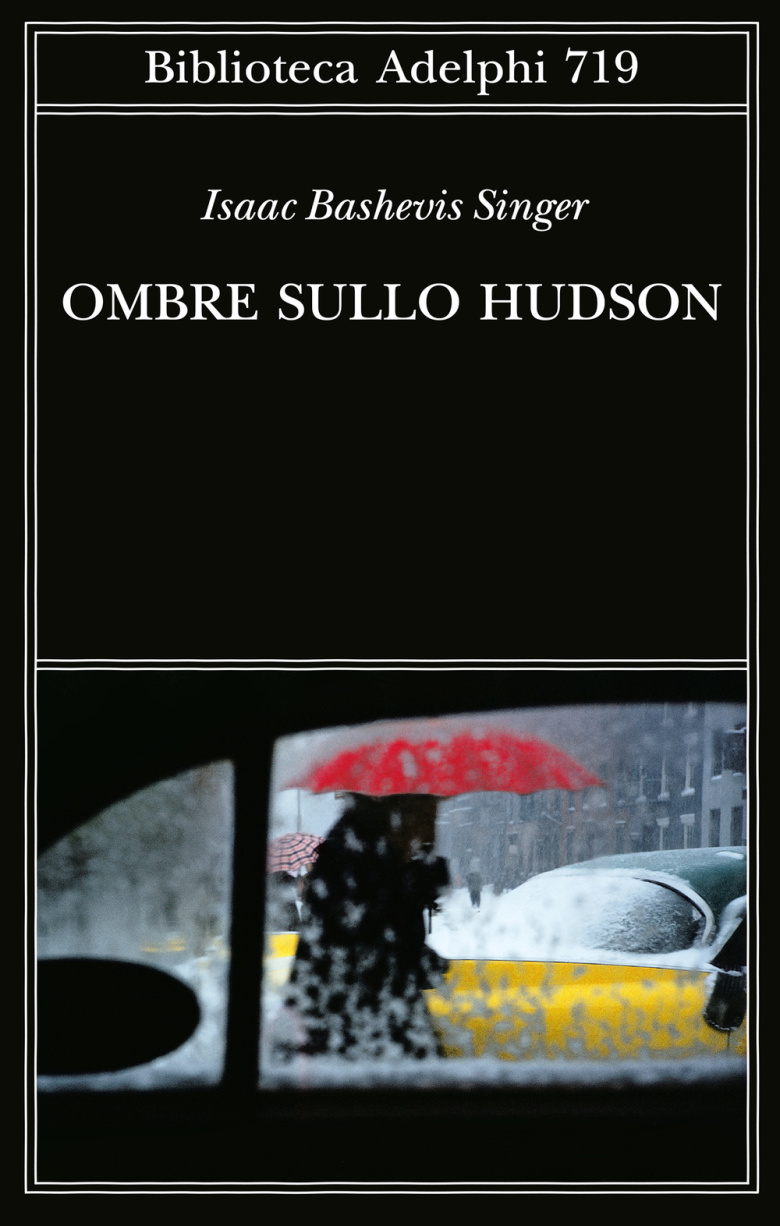
Il curatore, un grande esperto della grande mole di scritti che Singer accumulava nella sua “stanza del caos” e che, dopo la sua morte, sono stati acquisiti dallo Harry Ransom Center, Austin, Texas, ha operato una scelta, tra note autobiografiche inedite, saggi e articoli pubblicati sul “Forverts”, il quotidiano yiddish a cui Singer collaborò – sotto diversi pseudonimi – dal 1939 alla fine dei suoi giorni. Aggiungendo, inoltre, alcune prefazioni a romanzi e alcuni saggi pubblicati su quotidiani e riviste statunitensi. Tutti i testi sono usciti – con alcune eccezioni – soprattutto negli anni Sessanta, quando Singer cominciava a essere popolare negli Stati Uniti e quando, accanto alla sua opera in yiddish, si dedicava sempre di più a un’attività di traduzione e revisione del suo lavoro per il pubblico di lingua inglese.
Bene, per venire alla mia conferma – che è una conferma di come la letteratura per lui non contasse meno di Dio e del sesso – nel libro c’è un breve saggio, dove Singer, a cui probabilmente l’etichetta di “narratore nato” stava stretta, racconta due storielle: “una scherzosa e l’altra vera”. La prima è che quando Isaac nasce, sua madre chiede alla levatrice se si tratta di un maschio o di una femmina e la levatrice risponde: “È uno scrittore”. Non dice “narratore”, ma proprio “scrittore”. La seconda è un po’ più lunga e risale ai tempi di Varsavia, quando Singer è un promettente scrittore di racconti. Il più importante editore di letteratura yiddish gli chiede di pubblicare una raccolta di storie. Singer è al settimo cielo. Consegna il manoscritto. Una volta ricevute le prime bozze, si rende conto che l’opera non va, non lo soddisfa. Comincia a correggere, ma i cambiamenti richiederebbero troppo tempo. L’unica via possibile è rinunciare del tutto. Il giorno dopo comunica all’editore la sua decisione. L’editore va su tutte le furie, lo insulta. Ma Singer non si fa intimidire e per ripagarlo delle perdite traduce due libri senza ricevere alcun compenso. Cinque anni dopo Singer parte per gli Stati Uniti senza aver pubblicato la sua raccolta. La raccolta dovrà attendere ventisette anni prima di uscire in inglese con il titolo di Gimpel the Fool and Other Stories. La versione originale in yiddish ne attende addirittura altri cinque. “Fu una decisione difficile da prendere ma sono cresciuto con l’idea che la letteratura debba avere qualità durature, non sia fatta per essere pubblicata per una stagione e scomparire nell’entropia delle edizioni economiche”. Capite che si può nascere anche con un particolare talento nel raccontare storie, ma per scrivere un’opera dalle “qualità durature”, un’opera da presentare al Grande Editore e non destinata a scomparire “nell’entropia delle edizioni economiche”, bisogna avere fede, oltre che in Dio (e nel sesso), nella letteratura e nelle sue “leggi proprie”. I veri scrittori, infatti, scrive Singer nel saggio che dà il titolo alla raccolta, non possono essere atei per la semplice ragione che per la loro stessa natura devono litigare con i sommi poteri. Possono insultare Dio, ma non lo possono negare”.
Leggi anche:
Francesco M. Cataluccio | I. B. Singer dalle parti di via Krochmalna