Gesù e Giuda / La gloria di Giuseppe Berto e il trauma del tradimento
Nel suo romanzo più conosciuto e fortunato, titolato Il male oscuro, pubblicato nel 1964, Giuseppe Berto, scrittore scomodo e scontroso, pone al centro della scena della sua tormentata autobiografia psicoanalitica, come si legge sin dalle prime righe, la sua “lunga lotta con il padre”. Un padre esigente e padronale, espressione di una Legge sacrificale e inflessibile, schiaccia il figlio sotto il peso di una colpa antica: quella di non aver mai corrisposto alle sue attese, di essere stato una delusione cocente, un figlio deludente. Il corteo di sintomi che invade il corpo del soggetto traduce questa sentenza paterna in sofferenza: infiammazioni delle vertebre, disturbi gastrico-intestinali di ogni genere, nausea, angoscia, depressione, emicranie pervicaci. Questa colpa è destinata a dilatarsi smisuratamente quando il figlio, diventato ormai un uomo adulto, abbandona il padre ammalato di un tumore allo stomaco (“tremenda montagna di morte”) e in preda ad atroci dolori che lo condurranno presto alla morte.
Diversamente dal mito di Enea, qui il figlio non solo non soccorre il padre morente, ma latita, si rende assente, pensa solo a se stesso. Di fronte all’odore acre della morte che sta per sopraggiungere e colpire il padre tanto amato quanto temuto, il figlio sceglie la via della fuga. In primo piano è qui una scena di tradimento che costituisce il cuore di Il male oscuro. Anchise è abbandonato al suo destino mortale, è lasciato cadere a terra. Il padre non è più il tiranno che delude l’amore infantile e idealizzato del figlio abbandonandolo senza alcuna cura alla sua insufficienza. Questo padre morente appare ora nella sua castrazione reale. Adesso è il figlio che abbandona il padre nel momento più grave. E non è affatto casuale che sia proprio da questa drammatica scena di tradimento che sembra ricominciare l’ultima opera di Berto, La gloria, pubblicata nel 1978, l’anno della sua morte, al cui centro c’è una rilettura visionaria della figura di Giuda, il discepolo che tradisce Gesù – il suo Rabbi –, consegnandolo cinicamente al supplizio della croce. Come non vedere qui dipanarsi una prima fondamentale identificazione? Berto non è forse Giuda, il figlio che tradisce il proprio padre? Non è forse Giuda il discepolo che, anziché accompagnare fedelmente il maestro al suo destino cruento, lo abbandona cospirando attivamente per la sua morte? Non è lui il discepolo che riconosce sì il maestro, ma solo per consegnarlo ai suoi carnefici?
Il Giuda di Berto guarda sempre Gesù con sospetto. Nel suo sguardo ritroviamo quello del bambino di fronte alla sagoma pesante del padre.
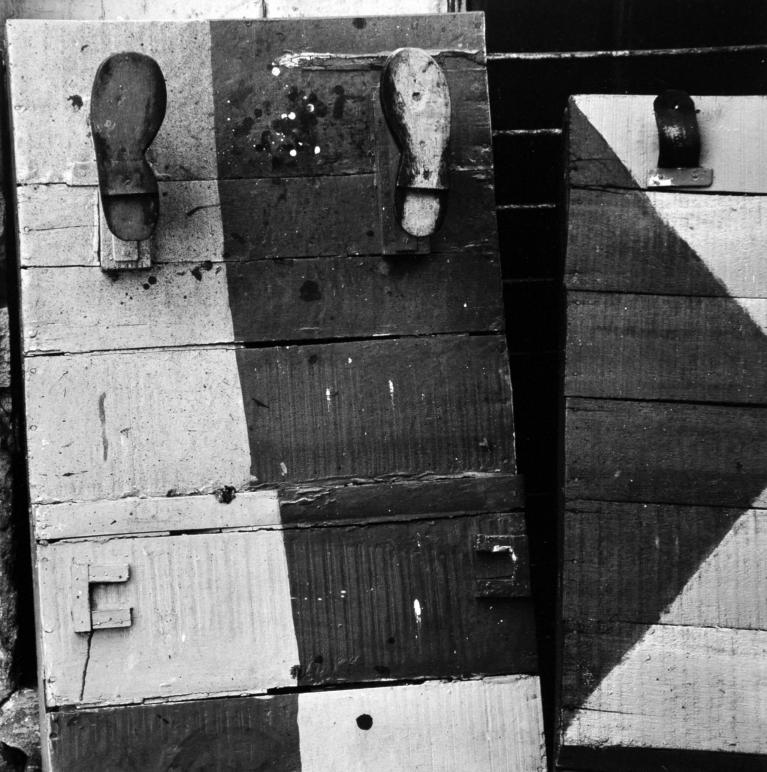
Ph Aaron Siskind.
Il dubbio lo attanaglia, lo frusta, lo domina: è davvero il figlio di Dio o è solamente un orribile mentitore? La promessa della vita eterna è una grazia autentica o una semplice impostura? Questo Giuda, come il protagonista del Male oscuro, è una figura umanissima del tormento. Innanzitutto il suo dubbio inquieto corrode il mistero della fede: non esiste fede capace di fare esistere una Verità assoluta, priva di incertezze e tentennamenti. Nessuna ideologia può risparmiarci il tarlo laico del dubbio. È il dramma che attraversa anche Young Pope di Sorrentino nel cuore stesso della cristianità. “Cos’è Dio? Dov’è Dio? Chi è Dio?”, si chiede con struggimento Lenny Belardo. “Dove è l’Eterno, c’è davvero un Eterno o c’è solo un infinito vuoto?...”, si chiede il Giuda di Berto. Ma, per entrambi, Dio non risponde, Dio tace. È il dramma profondo che attraversa anche il recente Silence di Scorsese: Dio invocato dalla preghiera e dalla fede più tenace, resta nel più assoluto silenzio. “L’Eterno – dichiara il Giuda di Berto – non può che insistere che nel suo smisurato silenzio…”. Il suo tormento dubbioso incenerisce il rapporto che unisce il figlio al padre. La domanda su Dio, in fondo, come ha spiegato Freud, almeno per un verso, non è altro che il rinnovamento della domanda originaria sul padre. Chi è un padre? Cos’è un padre? Dov’è un padre? Qual è la verità della sua Legge? Ecco le domande che dal Male oscuro discendono – martellanti – sino a La gloria.
Nello sguardo di ogni bambino, come scriveva freudianamente Berto nell’opera del ‘64, “il padre era stato una divinità onnipotente e lontana e in seguito diviene un poveraccio che mi rompeva l’anima con le sue pretese”. Nell’ultimo e testamentario romanzo questo disincanto ritorna intatto attraverso Giuda travolgendo la figura di Gesù. Anche Giuda, come il bambino che giocava teneramente sulle gambe del suo adorato papà, viene in un primo tempo catturato dal carisma di Gesù. È il tempo dell’idealizzazione: “aveva qualcosa che partiva più lontano di lui e arrivava più lontano di noi”. La devozione del discepolo maledetto a Cristo è però solo una prima faccia – quella non ostile – del complesso edipico che anima l’amore infantile per il padre. Si tratta di un amore assoluto, che non si risparmia: “m’ero offerto di morire per Te, in qualsiasi momento Tu me l’avessi chiesto avrei mantenuto, spesso sognavo che me lo chiedessi all’istante per provarTi la mia dedizione…”. Eppure – ed ecco apparire la seconda faccia, quella aspramente negativa, della medaglia dell’Edipo – Giuda non può resistere alle insinuazioni del dubbio. E se fosse un narcisista, qualcuno che pensa più alla propria luce che a quella del mondo? Se i suoi prodigi non fossero altro che trucchi? Se fosse solo un uomo come tutti noi?
Agli occhi di questo Giuda dilaniato anche la resurrezione di Lazzaro “fu una ponderata, fredda, scenografica ciurmeria”. Se, dunque, Gesù non rilascia quei segni che il discepolo ricerca ansiosamente, segni che scongiurerebbero il terrore della vacuità del mondo, se – come accade al più contemporaneo ma non meno tragico Young Pope – la domanda “dov’è Dio, dov’è l’Eterno?” resta senza risposta, allora è meglio morire che vivere. È la seconda grande identificazione, quella finale e più perturbante. Non più quella che lega Berto a Giuda nell’amore risentito verso il padre-maestro, ma quella che unisce Giuda e Gesù: il figlio della perdizione, il figlio colpevole, non è, in fondo, affatto diverso dal suo maestro. Questo è il punto estremo verso il quale si spinge Berto. Gesù è davvero differente da Giuda? Se invece non fossero che due teste di una sola persona? Non è questo che definisce la condizione umana? Essere, insieme, il tradito e il traditore, l’innocente e il colpevole, l’assassinato e l’assassino. “Morimmo alla stessa ora, Tu crocifisso sul Golgota, io poco lontano, impiccandomi, dicono, a un albero di fico”. Non la luce di Gesù – il salvatore – contrapposta gnosticamente alle tenebre di Giuda – il traditore. Piuttosto una convergenza abissale, una comunione disperata. È la scoperta traumatica di Berto scrittore e uomo: il Nome del padre contiene un destino.
I figli sono assai più simili a quel “peggio” che tendono invece ad attribuire unilateralmente ai loro padri. Il loro giudizio sprezzante verso i padri rivela la loro identità coi padri. Più l’odio interviene a dissolvere il legame più il legame si rafforza. È quella stessa mimesi sorprendente che colpisce lo scrittore nelle pagine finali del Male oscuro. Il figlio ormai anziano, separato dalla moglie e lontano da sua figlia, senza più nessuno al suo fianco, si accorge di assomigliare nel corpo e nello spirito al padre odiato: la stessa calvizie, la stessa melanconia, lo stesso sentimento di isolamento. Una mimesi che ritroviamo intatta anche nel finale di La gloria che non a caso è il finale, dal carattere fatalmente testamentario, di tutta la produzione letteraria di Berto e della sua stessa vita.
Il connubio impensabile di Gesù e Giuda ci consegna un enigma. Quale? “Essi vogliono solo morire”, scrive Berto. Anche Gesù, come il bambino del Male oscuro disperato nella solitudine del Collegio che invoca la risposta salvifica del padre imbattendosi però solo in un muro sordo al suo lamento, vive l’esperienza dell’abbandono e della caduta. Ma in Berto questo abbandono si inscrive come una marca indelebile e traumatica che tende alla sua ripetizione ostinata, mentre in Gesù è un passaggio necessario per cogliere il vero senso della Legge che è quello, come direbbe Lacan, di non cedere sul proprio desiderio. È questo il limite (ma anche la forza scabrosa) al quale la narrazione bertiana del Vangelo resta totalmente asservita: riportare Gesù a Giuda significa non riuscire ad accedere all’idea che la Legge del padre non sia fatta per assoggettare sadicamente l’uomo, ma solo per liberarlo dal sadismo di ogni Legge; significa non riuscire a sottrarsi dall’ombra spessa della melanconia del figlio che, secondo il suo Giuda, non a caso affliggerebbe da sempre, come un punto interrogativo, lo sguardo di Gesù.









