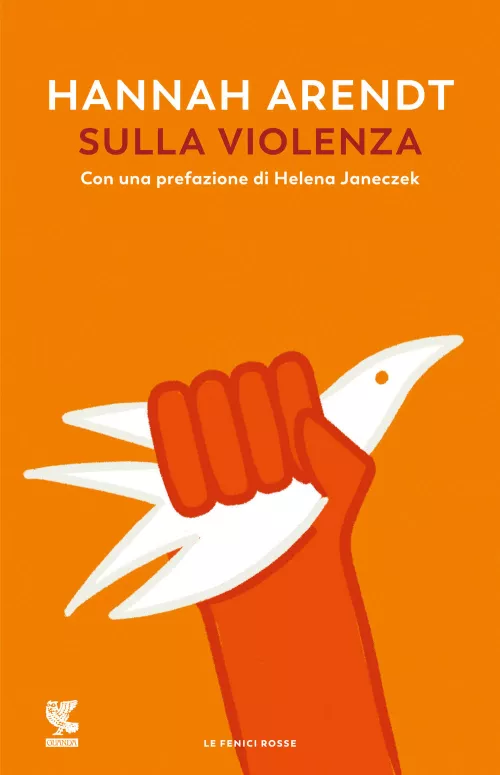Hannah Arendt: potere e violenza
Io devo capire, era il motto di Hannah Arendt. Per capire doveva pensare e per pensare bene doveva fare distinzioni, come aveva insegnato Heidegger all’università, a lei e agli altri studenti di filosofia, quelli che non volevano soltanto prepararsi per una professione ma cercavano qualcosa di più, proprio prepararsi a pensare: chi pensa, diceva Heidegger nel ricordo di Hannah Arendt, non sta sopra le cose ma va dentro, in mezzo alle cose (prendo in prestito queste parole dal recente romanzo di Hildegard E. Keller sulla vita di Arendt, Quel che sembriamo, recensito qui da Annalisa Ambrosio).
Definire termini, fare distinzioni
Arendt doveva definire con precisione concetti e nozioni e introdurre distinzioni, se voleva dare un senso alle sue asserzioni e non lasciarle fluttuare nell’universo del pressapoco se non dell’arbitrio e della confusione. Lo aveva già dichiarato esplicitamente nei saggi di Passato e futuro, del 1961: «È ovvio che nessuno ha mai sostenuto dichiaratamente che le distinzioni sono nonsense» – aveva scritto per esempio in Che cos’è l’autorità? – . Esiste però un tacito accordo tra sociologi e politologi sul fatto che ogni cosa può essere eventualmente chiamata in altro modo, e che ognuno ha il diritto di «definire i suoi termini». In questo modo (riassumo liberamente dal testo inglese) succede che termini fondamentali del linguaggio politico come «tirannia», «autorità» o «totalitarismo» abbiano perso l’accezione condivisa, oppure che abbiamo smesso di vivere in un mondo in cui le parole possiedono un significato comune indiscutibile. Anche in Sulla violenza, On violence, del 1970 – che Guanda ripropone ora, dopo la prima edizione del 1996, con una fresca prefazione di Helena Janeczek – Arendt afferma che compito di questo saggio è definire termini: in particolare potere e violenza.
Rimane la lingua
Nella sua introduzione Janeczek sceglie di presentare e commentare le idee di Arendt sulla violenza quali fari per illuminare il nostro presente, dalle rivolte di Black Lives Matter alla guerra in Ucraina, «apprezzando le parti non datate come confrontandosi con la sua inattualità». Lo scenario del saggio Sulla violenza è presentato da Janeczek come insieme anacronistico e preveggente. La posizione di Arendt è sempre binaria, contraddittoria; è ottusa e acuta, anticipa e rimane indietro, è innovatrice quanto conservatrice; il suo ragionamento è profondo e mancante.
E poi c’è la lingua: Janeczek, cresciuta lei stessa bilingue tedesco-polacco, diventata quasi bilingue tedesco-italiano, insiste non a caso sulla volontà di Arendt di non perdere la lingua tedesca pur sapendo che, avendo deciso di continuare a vivere e a lavorare negli Stati Uniti dei quali aveva preso la cittadinanza, doveva usarne sapientemente la lingua, l’inglese. Eppure furono proprio il tedesco, il francese che ben conosceva, il latino e il greco antico che aveva imparato al liceo di Königsberg che la aiutavano a capire, a costruire una terminologia cartesiana, chiara e distinta. La aiutavano ma insieme la tradivano (power non è Macht, vedremo, ma come tradurre Macht se non con power?) quando seguivano percorsi propri che non aiutavano a individuare il significato comune univoco e rischiavano la ricaduta nella terminologia privata fonte di un mondo senza senso.
In Sulla violenza Arendt alterna la ricerca di definizioni e distinzioni di concetti e di nozioni filosofico-politiche con l’analisi della violenza nel periodo nel quale scrive, gli anni ‘60 del Novecento, un periodo di guerre, rivolte, assassinii e massacri, condizionato dalla paura dell’atomica. Oggi quella paura ci ossessiona molto meno, incomprensibilmente; ci sembra lontana, sostituita com’è da paure più vicine alla nostra pelle, la pandemia, per alcuni la crisi ecologica. Abbiamo perso la paura dell’inferno con il suo enorme potere coercitivo morale e politico, non abbiamo perso la paura con la sua capacità, se ben manovrata, di esercitare un pesantissimo controllo sulle persone.

Quanto alla terminologia Arendt insiste nel distinguere il potere dalla violenza: potere e violenza non vanno a braccetto e non soltanto non sono la stessa cosa ma sono opposti. Per questo conta la lingua. Sono convinta che quando Arendt parla e scrive power ha in mente il sostantivo tedesco Macht e il verbo machen, riconducibile a una doppia origine: – mag (impastare, formare) e – magh (saper fare, possedere). La prima radice rimanda a un attrezzo, sia questo semplicemente la mano che impasta farina o argilla; la seconda a un contesto sociale nel quale si dispone di sé e degli altri, orientato al futuro. È da questo insieme complesso, solo in parte assimilabile al posse latino da cui potestas, potentia, potis, potere, power, che Arendt trae la definizione di potere (Macht) come la capacità umana di agire, di svolgere la vita activa.
La violenza dei campus
Arendt non accetta chi predica la coincidenza di potere e violenza, rifiuta le dottrine che sostengono la sostanziale violenza del potere, che affermano che la guerra fa parte dell’essenza degli stati (Bertrand de Jouvenel), o che l’aggressività è consustanziale al regno animale nel suo complesso, animali umani compresi, è stimolo vitale indispensabile alla creatività (Konrad Lorenz). «La combinazione di violenza, vita e creatività è ampiamente presente nell’inquieta situazione mentale della generazione odierna» commenta Arendt e aggiunge: «La giustificazione biologica della guerra come aggressività è pericolosa».
La violenza invece è pura forza strumentale. Il saggio di Arendt passa a concentrarsi sul suo presente, sulla rivolta studentesca dei campus americani e nella capitale francese. L’ideologia della violenza ignora la posizione sostanzialmente pacifista di Marx, cui pure i contestatori si ispirano, e si rifà alle parole violente di Sorel, ereditate poi a detta di Arendt da Fanon e da Sartre. Fanon che Arendt denigra e condanna come predicatore di violenza, senza capire la profondità – proprio lei – di un pensiero che insiste sul fatto che i dannati della terra hanno introiettato il pensiero dei loro oppressori, hanno finito col credere nella loro stessa inferiorità ed è questo che devono scrollarsi di dosso per liberarsi… Colpiscono le parole durissime di Arendt contro le richieste «folli e sfrontate» degli studenti del Black Power entrati nei lindi campus americani «senza qualifiche accademiche», «oziosi senza classe», «sottoproletariato», «gangsters», di fronte alle richieste «disinteressate e ad alto contenuto dei ribelli bianchi» (p. 55). Anche Janeczek nota l’incapacità di Arendt, radicalmente intollerante «a ogni forma di revanscismo, nazionalismo, separatismo», di riconoscere il bisogno di identità, di orgoglio minoritario da parte della comunità nera, cui l’uscita dalla schiavitù (grande tema di Judith N. Shklar, altra pensatrice ebrea europea rifugiata negli Stati Uniti e divenutane cittadina, nonché docente a Harvard) non ha dato i dovuti rispetto e riconoscimento.
In generale interessa a Arendt smontare l’idea della violenza creatrice capace di generare un mondo libero e giusto. Non ha simpatie per le idee che invitano a sovvertire il sistema con la rivoluzione, a cui pure riconosce, in altri scritti, di aver preso il posto dell’autorità e della tradizione fondatrici. L’eco delle sirene nei campus le ricordano troppo le camionette nazifasciste. Eppure, come riconosce Janeczek nella sua lettura non convenzionale, Arendt è cosciente del fatto che, pur deprecando la violenza rivoluzionaria, occorre mettere in guardia dalla violenza dello stato: un pericolo rilevato acutamente da Shklar, troppo spesso dimenticato in nome del quieto vivere e della sicurezza.
Più che l’analisi della violenza dei rivoltosi e dei ribelli convincono di Arendt altri passaggi: la violenza della burocrazia con la quale davvero ci scontriamo tutti i giorni, quella che esonera dalla responsabilità di dare risposte. O la violenza della scienza, della quale non bisogna illudersi che faccia quel che noi vogliamo, perché i suoi progressi – afferma Arendt – «non hanno nulla a che fare con ciò che vogliamo. Essi seguono le loro inesorabili leggi, costringendoci a fare quel poco che possiamo. Gli scienziati non pensano».
Anche i ribelli ecologisti di oggi sono folli e sfrontati, ma forse occorre esserlo, forse è necessario essere realisti e chiedere l’impossibile per ottenere quel possibile che non si vuole modificare. Vengono definiti violenti, talvolta lo sono, ma la violenza delle scelte economico-politiche che ogni giorno subiamo, o di cui forse siamo corresponsabili con il nostro voto, non è infinitamente più radicale e disastrosa?