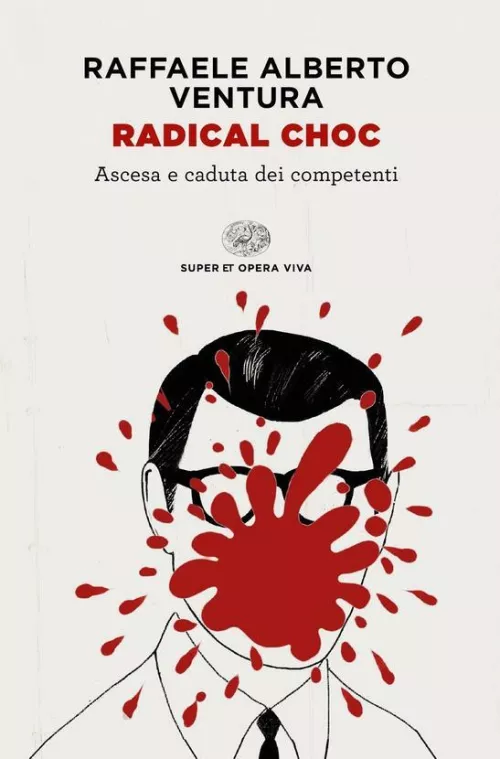Radical choc / L’impero fragile degli esperti
Mai come oggi l’esperto, il competente, il navigato conoscitore di uomini e cose è sotto i riflettori della cronaca, protagonista indiscusso, ma anche antagonista acclamato, del discorso dei media, e dunque, per proprietà transitiva, della vita di tutti noi, tanto sociale quanto individuale. Mai come oggi si invoca l’esperto per cercar di capire quel che sta succedendo, quel che è successo, e soprattutto quel che potrebbe succederci. Nel campo sanitario innanzitutto, e lo sappiamo bene da quando la pandemia ha fortemente cambiato le nostre vite, i nostri affetti, desideri, sentimenti, aspirazioni, valori. Ma in fondo in qualsiasi altro campo dell’esperienza pubblica e privata, dalla formazione allo sport, dalla politica all’economia, dalla religione ai consumi, dalla sessualità al cibo e molto oltre. Eppure, mai come adesso si dà addosso al medesimo esperto, lo si dileggia a più non posso, additandolo, se non come principale causa delle continue calamità che ci affliggono, senz’altro come inutile profeta di venture e sventure, incapace istanza burocratica che tutto acchiappa e tutto impedisce. La competenza, questa sconosciuta, questo fantasma che si aggira nelle strade maestre della società e nelle impasse della quotidianità, facendola da padrone al momento dei progetti – grande mito d’oggi – ma infrattandosi amaramente in quello della loro realizzazione. Da un lato insomma il vecchio radical chic, e soprattutto i suoi avatar, che sa come vivere e crede di sapere come far vivere; dall’altro il radical choc, o comunque lo si voglia chiamare, che ha seri problemi con l’idea stessa di sapere, e soprattutto con quella di saper fare.
La mette così, radicalizzando le posizioni, Raffaele Alberto Ventura, esperto (!) di geopolitica, in un suo recente volume intitolato appunto Radical choc. Ascesa e declino dei competenti (Einaudi, pp. 236, € 14), dove ripercorre le contraddizioni malamente gestite della cultura contemporanea, nella quale la figura del competente fa impazzire la bilancia della fiducia nelle istituzioni e nei suoi vari rappresentanti. Da una parte la ricerca affannosa di qualcuno che ci spieghi come stanno veramente le cose, e che dia ai nostri malcapitati decisori informazioni sensate e dritte d’ogni tipo; dall’altra i sempreverdi populisti che accusano il competente di non esser tale, e che parimenti invocano la loro spontanea, diretta, ingenua incompetenza come reale palliativo d’ogni male e d’ogni problema. Ancora: da un lato l’iperburocratizzazione e l’infinita parcellizzazione del sapere, tali per cui, poniamo, chi ne sa di anatomia dei grandi vasi difficilmente potrà permettersi di dire la sua su quella dei piccoli vasi – di modo che quando andiamo dal medico per un fastidioso mal di testa, ci rimpalla sadicamente fra mille specialisti che frammentano il nostro corpo nelle incommensurabili tessere di un mosaico che nessuno mai più ricompone; ma, dall’altro, la gran noia che tutto questo ci dà, per non parlare del sospetto metodico che genera: al punto che, poniamo ancora, quando scorriamo l’offerta formativa di un dipartimento universitario, siamo portati a credere che dietro le sofisticatissime denominazioni di quelle discipline mal si nasconda una fraudolenta spartizione di cattedre. Dietro il sapere, e con esso, insomma, il potere.
Potere che non è, ci hanno insegnato da tempo gli esperti in materia, moloch, dittatore o grande fratello che agisce dall’alto per censurare i nostri desideri e limitare le nostre libertà, ma gioco a rimpiattino tra forze più o meno nerborute, fra soggetti più o meni efficaci, fra situazioni più o meno vaste, più o meno limitate. Micropoteri insomma che tessono strategie di dominio cui rispondono tattiche di resistenza, e dove perciò si intrecciano interessi di parte, governi, istituzioni, chiese, finanza, tecnologie, lobbies, monopoli, come anche ideologie, valori, affetti, sogni, istanze di liberazione, credenze mistiche, voglia di tenerezza.

Così, in questa altalena di fiducie e sfiducie continue nei confronti degli esperti, ci sguazzano come paperotti giornali e televisione, che un giorno riportano il parere di un accigliato cattedratico sorboniano dai toni apocalittici e il giorno dopo intervistano un simpatico giovanottone californiano che inneggia all’ultimo microchip intelligente che, da solo, scoprirà il vaccino giusto per far fuori per sempre il maledetto coronavirus. Per non parlare dei social, dove l’astio nei confronti degli esperti raggiunge la sua acme (si pensi ai cosiddetti no vax, cresciuti a pane e facebook), come pure, antinomia solo apparente, l’attesa messianica del cervellone che saprà spiegare ai politici e agli operatori di borsa, ai medici o ai docenti di scuola come gestire e, sperabilmente, sconfiggere il predetto astutissimo virus. Libertà di opinione? Certo, evviva. A condizione di ammettere che il parere di un esperto non è nient’altro, appunto, che un’opinione come un’altra, e non – dio santo – enunciazione di una verità assoluta.
A cosa serve allora l’esperto? A dispetto di decenni e decenni di filosofia e di sociologia delle scienze (Popper, Lakatos, Feyerabend, Stengers, Latour, Collins…) che ci hanno spiegato come l’ambiente scientifico sia il regno dei conflitti e delle negoziazioni, delle ipotesi e delle confutazioni, della diplomazia e dell’incertezza, i media vecchi e nuovi ci rimandano la figura di un esperto che, come quel personaggio di Pulp fiction, è lì per risolvere problemi. Il problem solving, ennesimo mito di una contemporaneità che, facendo della Ragione il suo idolo numero uno, adesso paga il pegno di un cartesianesimo in progressiva, inesorabile dissoluzione. I politici, imboccati dai media, chiedono agli esperti di spiegare una buona volta come stanno le cose. Ma questi ultimi, quando riescono a non barattare la loro consapevolezza professionale per il solito quarto d’ora di celebrità, non sanno cosa rispondere: capiscono bene cioè che il problema, qualunque esso sia, è politico, non scientifico. L’esperto, a conti fatti, serve perciò al politico per prendere le sue decisioni, soprattutto se e quando risultano impopolari. È la vecchissima storia dell’ipse dixit resuscitata alla bisogna: chiudiamo tutto perché ce lo dice il “tavolo tecnico”, chiunque vi sia effettivamente seduto.
Tutto confuso, tutto insensato, tutto senza soluzione? Probabilmente no. Basta ritrovare le forme logiche che regolano, in profondità, le strategie e le tattiche dei micropoteri diffusi, entro cui il lenzuolo della competenza risulta sempre troppo corto. Colpisce, a questo proposito, proprio la primissima pagina del libro di Ventura, che vale la pena riportare in parte, dove l’autore illustra alcune dei più frequenti incongruenze presenti nei mille e mille discorsi circa l’attuale pandemia:
È un visus inoffensivo, soltanto un’influenza, anzi è gravissimo. Colpisce solo gli anziani, tranne quando colpisce i giovani. Il suo tasso di mortalità è altissimo, ma è stato calcolato su un numero di contagiati approssimativo, quindi è bassissimo. In Italia non arriverà mai, a meno che non circolasse già dal 2019. Bisogna sospendere ogni attività, salvo quelle essenziali, ma per sicurezza anche quelle. Chiudere le scuole non serve. Contrordine: serve. Indossare una mascherina è inutile, però aiuta a non contagiare gli altri […]. Perché il virus si trasmette nell’aria, ma scompare col caldo […]. Ce lo terremo fino all’estate, anzi tornerà in più ondate. Insomma aspettiamo il vaccino, che però potrebbe anche non arrivare mai.
Le parole sottolineate rendono conto molto bene del fatto che questa logica profonda del discorso contemporaneo non è affatto quella dell’inferenza classica (“se… allora”), come ci aspetteremmo da chi ci governa o dagli opinionisti che stanno lì a controllarli. Si tratta semmai di quella che i linguisti chiamano predicazione concessiva, che fa uso, come appunto la citazione dimostra, di continui “ma”, “però”, “sebbene”, “tuttavia”, “anzi” e simili. Dobbiamo farcene una ragione: la predicazione concessiva – come oggi in più campi si comincia a comprendere – è la forma segreta (ma nemmeno tanto) del ragionare attuale, in politica come in economia, in medicina come nella vita quotidiana. Prenderne atto à già liberarsi dai tantissimi vicoli ciechi che Ventura perfettamente illustra. Come quello della società cosiddetta “iatrogena”, dove le peggiori patologie provengono dalle medesime cure apparecchiate per sconfiggerle. Basterebbe appunto capire che, per restare a questo esempio, fra patologia e cura non c’è contrarietà ma contiguità, metonimia, parziale sovrapposizione (è il vecchio pharmakon greco).
Fra l’altro, questo ragionamento ci permette di azzardare una nuova, provvisoria definizione del competente: è qualcuno che non conosce la predicazione concessiva. Pensiamoci su.