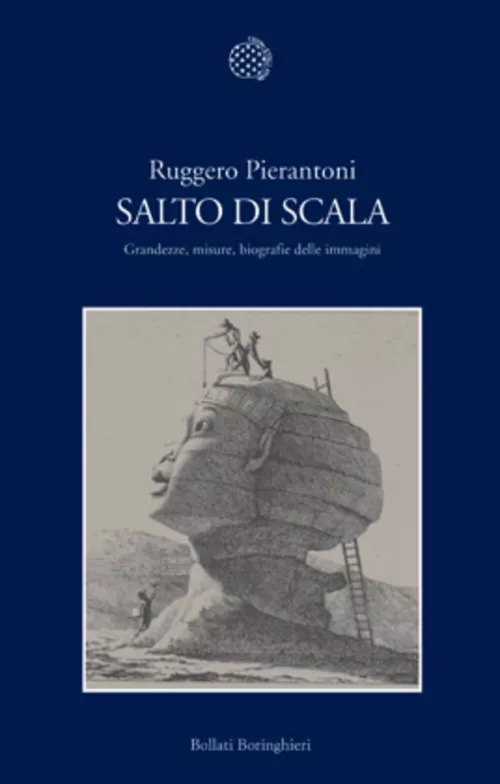Ruggero Pierantoni. Salto di scala
Non c’è bisogno di appartenere alla “setta dei poeti estinti”, come il professore de L’attimo fuggente, per avere l’impulso di strappare le pagine in cui Evans Pritchard misura sul piano cartesiano il valore di una poesia. Quell’episodio della guerra mai spenta fra le “due culture” dava voce al timore, di origine romantica, che la ragione quantificatrice possa distruggere quanto appartiene alla dimensione “spirituale” delle arti. Aprendo l’ultimo libro di Ruggero Pierantoni, Salto di scala (Bollati Boringhieri, pp. 320, euro 39), veniamo proprio invitati a prendere un righello per misurare in millimetri l’altezza di uomini raffigurati su di un mosaico di Thera o sui resti di un muro dell’antica Roma; l’archeologia recente ha conosciuto una discussa “svolta metrologica”, per la quale sembra rilevante solo quel che è cartografabile sul terreno e riducibile all’anonimato della misura. Se ci lasciamo condurre dalla mano sapiente dell’autore lungo i 43 capitoli del libro (più 40 pagine di note bibliografiche e 60 illustrazioni), veniamo coinvolti in un viaggio avventuroso che attraversa le epoche, i continenti, le arti e le scienze. Finiamo così per transitare più volte fra le due sponde dell’Atlantico, seguendo “colossi” come la statua della Libertà, o le assonanze fra il progetto di Suger, l’abate di Saint Denis del XII secolo, e Gutzon Borglum che nel 1927 inizia a trivellare il Mount Rushmore per scolpirvi i volti di presidenti statunitensi.
Il nomadismo è d’altronde la cifra esistenziale ed intellettuale di Pierantoni. Biofisico di formazione, è stato ricercatore e docente in università del Nord America, in facoltà scientifiche ma anche in Accademie di Belle Arti (ora insegna alla facoltà di Architettura di Genova, città di cui è stato apprezzato assessore alla Cultura). Chi si è lasciato sedurre dal fascino dei precedenti lavori di Pierantoni, che ruotano attorno al complicato statuto dell’immagine visiva - da L’occhio e l’idea (1981) a Forma fluens, da Monologo sulle stelle a Vortici, atomi e sirene -, sa di essere chiamato a percorrere l’intero Paese d’Enciclopedia. Salto di scala ci ricorda che misurare può rivelarsi utile, ad esempio per ricostruire dimensioni di una statua perduta e che alcune costanti metriche si conservano al di là dei mutamenti di cultura: i canoni con cui l’arte pagana rappresentava centauri e giganti si ritrovano ancora nelle “forme visive” con cui la patristica cristiana traduceva in metafore il mistero della Trinità divina. Il ricorso alla misura rimane però un atto simbolico e linguistico, carico di convenzione: quali sono i punti da cui partire per calcolare su di un mosaico le dimensioni di Ulisse e Polifemo, visto che gli estremi su cui poggia il righello sono in genere le linee di contorno visivo, non sempre corrispondenti a quelle dei corpi? Cosa misurare in “Number One”, oltre all’impronta delle dita lasciata da Pollock? E di fronte all’auriga di Mozia, lo studio deve affidarsi all’analisi o all’emozione, la mano va posta sul righello o sul cuore?
E poi “misurare non basta, anzi è assai ingannevole, soprattutto quando non si conosce la storia”: contare ha spesso bisogno del conforto del raccontare. Ecco allora Pierantoni guidarci nei meandri di “biografie di immagini” che si intrecciano con le biografie dei loro autori; mostrarci le varianti delle trasposizioni figurative di un testo scritto o gli slittamenti millimetrici dall’originale alle sue copie o dalla creta al marmo. Fra le tante riproduzioni delle fattezze e del volto del presidente Washington – compresa la statua, poi distrutta in un incendio, di Canova che lavora su un busto in terracotta di decenni precedenti – si operano insensibili sfasamenti fisiognomici, al punto che si finisce per chiedersi: qual è il vero Washington? Da cosa è data la somiglianza? Non tanto la likeness, ma la life-likeness, quell’energia vitale che scatena una reazione emotiva e sospende l’incredulità: “La somiglianza sembra a volte basarsi su un sottilissimo algoritmo sensoriale e al tempo stesso cognitivo, in cui elementi microscopici e velocemente modificati determinano la certezza del riconoscimento”, scrive Pierantoni. E tornano alla memoria le sculture di Alberto Giacometti, su cui si sofferma un saggio di Marco Belpoliti (Camera straniera. Alberto Giacometti e lo spazio, da poco edito da Johan & Levi); solo nel “salto di scala” che ne riduce le dimensioni la somiglianza trova la sua verità, ma fin dove la testa del fratello Diego può farsi minuscola e conservare i tratti dell’originale, prima di dissolversi in polvere?
Quando si ricorre alla misurazione, vanno considerate, ricorda Pierantoni, anche le condizioni di visibilità dell’immagine e la sua distanza dall’osservatore. Il fregio interno delle Panatenaiche scorreva a 10,26 metri da terra, lungo il muro della cella che restava immerso nell’ombra; formava come una successione continua, “animata” dallo sguardo di un osservatore in movimento; come per Goethe fra le rovine di Paestum, “solo girandovi intorno si comunica loro una vera vita”. Il tempo comincia a fare capolino dentro lo spazio: il fregio interno delle Panatenaiche assume un andamento “melodico”, può essere visto solo suonandolo, suggerisce Pierantoni. Ora, il nostro cervello preferisce lavorare su diapositive di locazioni spaziali e tradurle poi in sequenza temporale. Sappiamo dalle ricerche del fisiologo russo Alfred L. Yarbus quanto tempo occorre alla retina per prendere un’istantanea, possiamo calcolare i momenti di fissazione o foveazione dei particolari di un quadro; tanto più ampio è l’angolo percorso dalla pupilla nell’esplorare l’oggetto tanto più lunga sarà stata la durata dell’immagine. Ma il passaggio dalle “stazioni” di osservazioni alla misura della sequenza temporale ci fa perdere proprio la continuità della sequenza. Pierantoni ritrova qui il problema che era stato di Bergson: misurare è già tradire il tempo, e anche misurare la durata di un brano musicale è un gesto carico di convenzione, visto che non è agevole dire quando termina una melodia.
Per l’osservatore che si sposta davanti ad un affresco, gli artisti hanno inventato astuzie per il controllo verticale delle immagini, ad esempio la visione “da sotto in su” per fare apparire l’immagine più grande di quanto non sia in realtà, come fa Giulio Romano nella sala dei Giganti di palazzo Te a Mantova. Ma per lo spettatore immobile di una sala cinematografica, quanto sono grandi le immagini proiettate sullo schermo? I fotogrammi misurano 25 mill. (il cinemascope li porterà a 35) e l’aspect ratio di ogni fotogramma, cioè il rapporto tra lato orizzontale e verticale, è 1,33, lo stesso rapporto che già troviamo nelle incisioni di W. Hogarth del 1727, lontano precursore dell’idea di narrazione scenica che sarà adottata dal cinema. Ma se voglio rappresentare i dettagli dell’omicidio del Raskolnikov di Delitto e castigo, posso ricorrere, come Ejzenstejn, ad un quadrangolare, porre le immagini in primo piano, scegliere insomma la giusta “inquadratura”. Come nei retablos messicani, che ispirano i murales di Diego Rivera, quel che risulta più visibile sul piano “narrativo” può avere dimensione ridotta. I continui andirivieni di Salto di scala (qui solo accennati) confermano quel metodo “peregrinante” di cui Pierantoni scriveva nella prefazione al suo primo libro, Riconoscere e comunicare (1977): il lettore non ha l’impressione di “un procedere retto e sereno per sentieri tranquilli e ben segnati e in paesaggi forse troppo rassegnati […], ma potrà, forse, alla fine scrivere a destra e a sinistra della via seguita con sorridente serenità: Hic leones non sunt”.