Poesie e racconti di Kolyma / Varlam Šalamov: scrivere dai gulag, scrivere nei gulag
Varlam Šalamov (1907-1982) viene arrestato il 19 febbraio del 1929, a soli ventidue anni, per i suoi rapporti con alcuni attivisti politici dell’opposizione leninista-trockista e per avere scritto e diffuso il Testamento di Lenin, una lettera apocrifa in cui l’ormai defunto padre della Rivoluzione russa esprime, con la voce dello scrittore, pesanti riserve sulla successione di Stalin. Lo scrittore è incriminato in base a un articolo del Codice penale della Repubblica socialista che punisce la propaganda sovversiva di appelli destinati a danneggiare o indebolire il potere sovietico. Viene rinchiuso per tre anni nel carcere giudiziario di Butirki, sugli Urali. Scontata la pena, nel 1931 torna a Mosca.
Scrive su alcune riviste, si sposa, ha una figlia, ma su di lui pende una condanna a tre anni di confino che nessuno gli aveva notificato. Arrestato per la seconda volta nel 1937, viene internato in Siberia, nei campi di lavoro della Kolyma. Processato cinque anni dopo, è condannato a dieci anni di lavori forzati e a cinque di privazione dei diritti civili per propaganda antisovietica. Rilasciato alla morte di Stalin, vive ancora per quasi trent’anni tormentato da patologie polmonari, separato dalla moglie e rinnegato dalla figlia. Scrive negli anni ‘50 e ‘60 I racconti di Kolyma (RDK), che saranno raccolti in volume in Occidente nel 1978 e in Russia, postumi, pubblicati nel 1992: in Italia escono per le edizioni Adelphi nel 1995. Nel 2009 Mondadori pubblica il volume Alcune mie vite. Documenti segreti e racconti inediti, (AMV) e nel 2010 Adelphi i racconti di Višera. Un’antologia della sua opera poetica, Quaderni della Kolyma. Poesie 1937-1956, appare in italiano, presso Giometti & Antonello, nel 2021.
Šalamov è un autore che turba il lettore non tanto per l’evidente suggestione dei temi concentrazionari, di per sé generatori di un disagio innominabile, quanto per il tono di classica e dolente tranquillità con cui intona la sua opera in prosa e in versi, permeata da un intimo fatalismo di natura slava, screziata da una sommessa ma mai assente ironia.
Inizierò questa indagine con il breve racconto “Marcel Proust” (QDK, p. 566), che narra del furto di una copia della Recherche proprio in uno dei gulag dove l’autore lavorava come infermiere. Šalamov scrive «Il libro era sparito. Chi avrebbe letto quella strana prosa quasi priva di peso, come pronta a volare nel cosmo, dove tutte le proporzioni sono spostate, alterate, dove non ci sono grande e piccolo? Di fronte alla memoria, come di fronte alla morte, tutti sono uguali, e l’autore ha il diritto di ricordare l’abito della serva e dimenticare i gioielli della padrona. Gli orizzonti dell’arte verbale sono stati straordinariamente allargati da questo romanzo. Io, uno della Kolyma, un detenuto, ero stato trasportato in un mondo perduto da tempo, in abitudini altrui, dimenticate, inutili. Il tempo per leggere ce l’avevo. Facevo l’infermiere al turno di notte». L’ipotesi “lirica” del furto del libro si intreccia alla sarcastica riflessione sulla possibilità che il gigantesco in folio possa essere anche stato ritagliato e usato come carta da ardere per combattere il freddo polare del campo.
La serenità naturale e severa di Šalamov è evidente anche dalle poesie scritte nel gulag: «Mi sono lamentato con l’albero / con la parete di tronchi, / e la fiducia dell’albero / mi era nota. // Abbiamo pianto molto insieme, / parlato di tutto, / ci è dato spiegarci / a segni. // In una casa di mattoni, di pietra / non avrei detto nemmeno una parola, / per anni, per secoli / avrei sopportato e taciuto» (QDK, p. 17). Il traduttore, Gario Zappi, nel suo breve scritto Personale e confidenziale (frammenti per una prefazione) parla dei versi di Šalamov, da lui già tradotti con lo stesso titolo per la rivista genovese “Arca”, come di una poesia non greve e non difficile, classica e profonda, senza nulla di superfluo e di inutile. Šalamov scrive su ricettari o su carta d’imballaggio, annota versi per sopravvivere ai margini di un lager siberiano, si identifica con animali, pietre, oggetti inanimati: «Hanno dimenticato il tuo nome / non solo per noncuranza, / ti hanno mischiato qui con altre / pietre rubandoti all’eternità» (QDK, p. 23). Memorabile, in questo senso, è la poesia La conchiglia: «Sono come quei fossili pietrificati / che riaffiorano per caso / per svelare intatti al mondo / un mistero geologico. // Io stesso sono come le fragili conchiglie / dell’antico mare prosciugato / ricoperte di segni intarsiati, / come trascrizioni di un discorso. // Voglio sussurrare a chiunque all’orecchio / le parole dell’antichissima risacca, / non voglio cucirmi la bocca come Ermete / trascurando ogni possibile destino. // Che non venga mai scoperta / dai secoli seguenti / la madreperla impietrita / con versi pietrificati». Resta la sensazione che l’autore, immerso nella precarietà di un’esistenza coatta, minacciata dai morsi del freddo e dalla violenza dei carnefici, voglia proprio rannicchiarsi nella pietra come in una casa che lo protegga da ogni emozione fisica e mentale, e gli consenta, sempre però, in ogni modo e in ogni situazione, di scrivere.
In La prigione di Butyrki annota: «Ho avuto l’occasione di incontrare alcuni rivoluzionari del tempo dello zar. E mi è rimasta impressa una loro osservazione: “Con l’arresto” mi dicevano molti professionisti del carcere “sopraggiunge una sorta di sollievo morale; invece dell’inquietudine, dell’ansia, della tensione, si avverte una gioia segreta, in un certo senso tutto si è definito, sta facendo il suo corso… E, sebbene ti si prospettino l’interrogatorio, la condanna e la deportazione, in carcere l’anima finalmente si riposa, si fa coraggio e fa coraggio agli altri, se ne hanno bisogno”» (VS, p. 186).
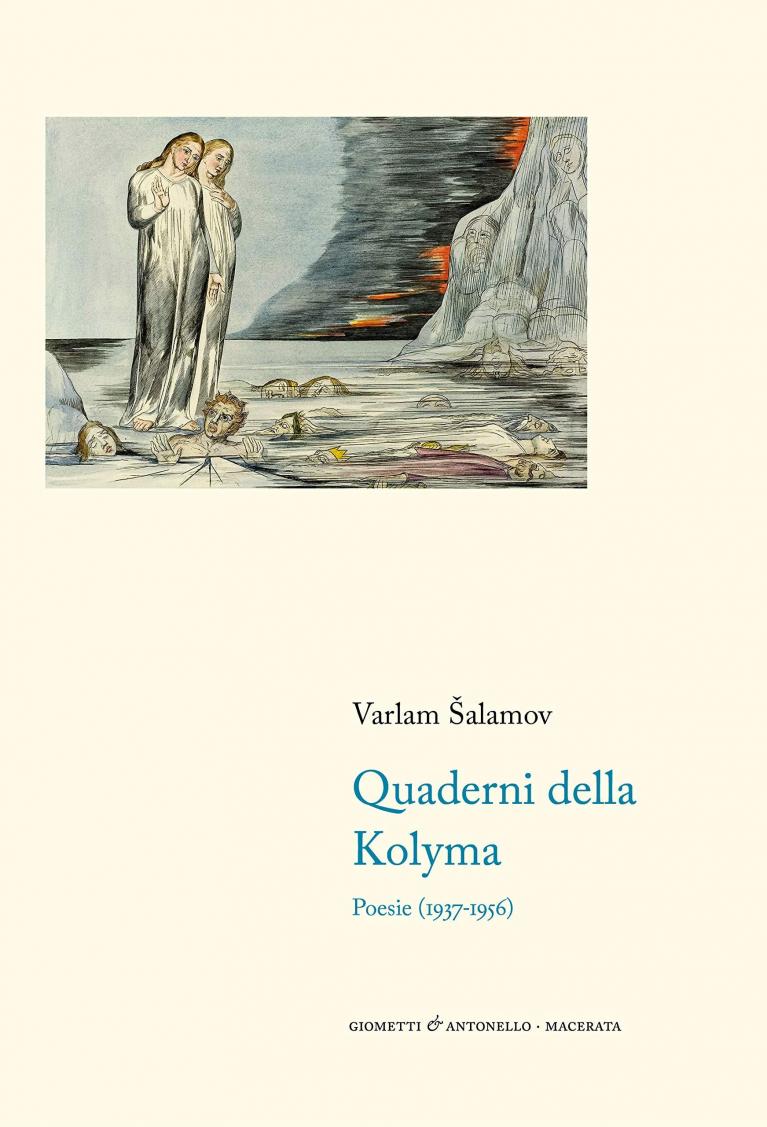
Šalamov ci racconta come nel gulag non esista solo l’angoscia della libertà assente e delle condizioni di fisica invivibilità ma anche la pacata certezza di avere in qualche modo definito il proprio destino: da qui il senso di compiutezza e di pace che emerge dalla sua scrittura. In ogni racconto dello scrittore russo è evidente la pietas per fiori, alberi, pietre, destini e la ubris ferita del prigioniero è sempre sotto controllo. Ciò che domina è l’attenzione alla vita quotidiana e alla singolarità dei destini umani, la fisica descrizione delle fatiche stremanti, la meraviglia inattesa di certi paesaggi naturali.
Scrive l’autore, come dedica, nei primi manoscritti dei Racconti di Kolyma: «Io scrivo del gulag non più di quanto Exupéry scriva del cielo o Melville del mare. Il gulag è un tema tale per cui financo un centinaio di scrittori come Lev Tolstoi possano stare uno accanto all’altro, senza essere stretti». Una misteriosa fratellanza, suggerisce Šalamov, che non sembra possibile in un mondo libero. Nell’universo del gulag affiora in modo selvaggio l’identità ferina fra uomo e animale: «Scambierà, senza uomini, senza libri, / confidando nella natura soltanto, / il proprio linguaggio umano / con interiezioni da bestia. // Scaverà con le mani il covo per la notte / nelle scricchianti foglie forsennate, / quell’uomo inselvatichito, / quell’intellettuale navigato. // E con la costola sporgente, / tendendo la pelle, / non sarà in grado di stabilire / la differenza tra il bene e il male. // D’improvviso, lavatosi all’alba / con acqua sorgiva / leverà lo sguardo alla montagna / e ululerà come un lupo...» (QDK, p. 69).
Ciò che lo scrittore fa trapelare è la tragica corrispondenza fra la vita dell’uomo libero e quella dell’uomo prigioniero: due semivite parallele, due speculari schiavitù: «Il lager è un calco anche perché dentro il lager tutto è come fuori, il sangue è sangue, spie e informatori sono altrettanto zelanti, si avviano nuove pratiche, si richiedono referenze, si svolgono interrogatori e arresti, qualcuno viene rilasciato qualcun altro viene acciuffato. Disporre del destino altrui nei lager è ancora più facile che fuori» (VS, p. 80). E, ancora una volta, affiora l’inferno di chi non può disporre liberamente della propria esistenza: «Cosa restava con me fino alla fine? La rabbia. E, conservando questa rabbia, contavo di morire. Ma la morte, che fino a pochissimo tempo prima era stata così vicina, cominciò pian piano ad allontanarsi. Non fu la vita a prendere il posto della morte, ma uno stato non del tutto cosciente, un’esistenza per la quale un termine appropriato non c’è e che non può essere chiamata vita» (RDK, 286).
Non manca mai, soprattutto nel corpus delle poesie, un accenno utopico a un mondo diverso e migliore, come in certi finali delle commedie/tragedie cechoviane: «Mi corico sulla schiena / e insieme al mondo intero / me ne vado volteggiando a mani / vuote per tutta questa lieta estate. // Mi circondano i boschi / e la terra alle spalle. / Il cielo ghignante / si è chinato su di me. // La mia mano già / tremante impaziente / ha afferrato le nubi, / le setole della criniera dei cavalli. // È come se ora trascinassi a fatica / il mondo intero con me, / come se volessi di nuovo / vivere del suo destino» (QDK, p. 125).
Nel racconto Inseguendo il fumo della locomotiva Šalamov ci spiega, con un realismo così minuzioso da trasformarsi in pura visione, cosa può significare, per un deportato, l’arrivo di un treno: «Sì, era il mio sogno: sentire il fischio della locomotiva, vedere il fumo bianco della locomotiva snodarsi lungo il terrapieno della ferrovia. Aspettavo il fumo bianco, aspettavo una locomotiva viva […]. E, malgrado tutto, il nostro respiro, nel gelo di cinquanta gradi sotto zero, sembrava il fumo di una locomotiva. I larici argentati della taigà sembravano brandelli del fumo di una locomotiva. Anche la nebbia bianca che copriva il cielo e riempiva la nostra notte era il fumo di una locomotiva. In quel bianco silenzio non sentivo il rumore del vento, sentivo una frase musicale che veniva dal cielo, e una voce umana chiara, melodiosa, squillante, che risuona nell’aria gelida proprio sopra di noi. La frase musicale era un’allucinazione, un miraggio sonoro, e aveva qualcosa del fumo della locomotiva che invadeva il mio valico montano. La voce umana era solo la continuazione, la logica continuazione di quel miraggio musicale d’inverno» (RDK pp. 526-527). Non si può non tornare con la mente all’immagine di La steppa di Cechov quando il narratore, appena uscito da un vagone ferroviario durante una pausa del viaggio, guarda la luna inondare l’amata steppa. In fondo, un piccolo sollievo è sempre possibile, anche nelle condizioni più estreme.
Šalamov, a cui non manca il senso di una sottile e straziata ironia, osserva: «Sia una cosa, sia l’altra, certo, è la fortuna, / la legge dell’essere, così si dice: / al sole è toccato, in fondo, risolvere problemi / ben più difficili del mio» (QDK, p. 123). Certo, se il sole ha avuto diversi problemi da risolvere, non ne sono mancati allo scrittore russo. Libero fisicamente dai lager, ma privo dell’amore della moglie e della figlia, oppresso da una precaria mancanza di salute, cosa poteva fare di diverso se non fermare per sempre, nella classica scrittura dei suoi racconti, l’innominabile dolore dei mai dimenticati Giorni della Kolyma? «La vita indifesa / in cui vi è troppo dolore. / La tua anima pare / la superficie di una scottatura» (QDK, p. 115). Šalamov fino all’ultimo giorno rimpiangerà di non avere mai posseduto una biblioteca tutta sua, conquistando scrittura e lettura libro dopo libro, sopportando la fame e il gelo del gulag.
Libri citati
Varlam Šalamov, I racconti di Kolyma, Adelphi, Milano, 1991 (RDK).
Varlam Šalamov, Alcune mie vite. Documenti segreti e racconti inediti, Le scie, Mondadori, Milano, 2009 (AMV).
Varlam Šalamov, Višera, Milano, Adelphi, 2010 (VS)
Varlam Šalamov, Quaderni della Kolyma. Poesie 1937-1996, Giometti & Antonello, Macerata 2021 (QDK).









