Speciale
Vito Teti: il senso dei luoghi
La riflessione di Vito Teti, la sua lunga ricerca, nell’arco di un’intera vita, ci obbliga a ragionare sul “senso dei luoghi”.
Per Vito Teti, Il luogo è oggi un crocevia del pensiero. E per questo, credo di poterlo iscrivere nel piccolo registro di questi “pensieri impazienti”, e cioè scalpitanti, desiderosi di mettersi sulla strada per aprire un varco nel mondo che su di noi sembra chiudersi come un cerchio oppressivo. “Pensieri dettati dall’urgenza, formulati in uno stato di necessità”, ho scritto aprendo questa serie esattamente un anno fa, “pensieri apprensivi”, che “avvertono le scosse del nostro suolo mentale, chinandosi verso le forme pericolanti, l’esistenza in bilico, il reale che vacilla”.
Porta questi segni, che sono forse anche ferite, la ricerca di Vito Teti, dove il luogo è una “forma pericolante”, e lo è il nostro abitare, il nostro stare. “Siamo essere soppiantati”, dice Peter Sloterdijk. Abitiamo “l’età dello smarrimento” dice Christofer Bollas. “Abbiamo completamente smarrito il mondo, ne siamo stati spossessati”, ha scritto Gilles Deleuze.
Nel luogo transitano “esistenze in bilico”, che sembrano spostarsi come le figure di Alberto Giacometti, costantemente in cammino, ma con passo dubbioso, quasi non fossero sostenute dal loro stesso essere. Non hanno suolo, queste figure. Nessuna radice. E nessun punto d’arrivo.
Poggiando su questo strato di diffusa precarietà, scivoloso, insicuro, s’interroga incessantemente l’antropologia del tutto singolare di Vito Teti. Un’antropologia, se posso dire così, ansiosa, che non si limita a promuovere un sapere dell’uomo, non si chiude, e si mette al sicuro, protetta dalle sue geometrie concettuali, ma dell’uomo si prende cura, si adopera per custodirne il senso. Sull’uomo, e su i suoi affanni, si piega. Le fratture della storia, gli impeti spesso distruttivi di una “terra inquieta”, alimentano l’intelligenza dell’antropologo Vito Teti, la orientano.
Sono molti i libri che Vito Teti ha pubblicato in questi anni, capitoli di una riflessione che non si è arresa al silenzio e all’abbandono, inseguendo con tenacia le linee mobili, ondulate, curve, rette, su cui si è mossa la sua “terra inquieta”: la Calabria. Ne ricordo alcuni: Il senso dei luoghi (ultima edizione Donzelli 2022, recensito in queste pagine da Antonella Tarpino), Pietre di pane (Quodlibet, 2011), Prevedere l’imprevedibile (Donzelli, 2020), La restanza (Einaudi 2022) e l’ultimo Il risveglio del drago (Donzelli, 2024).
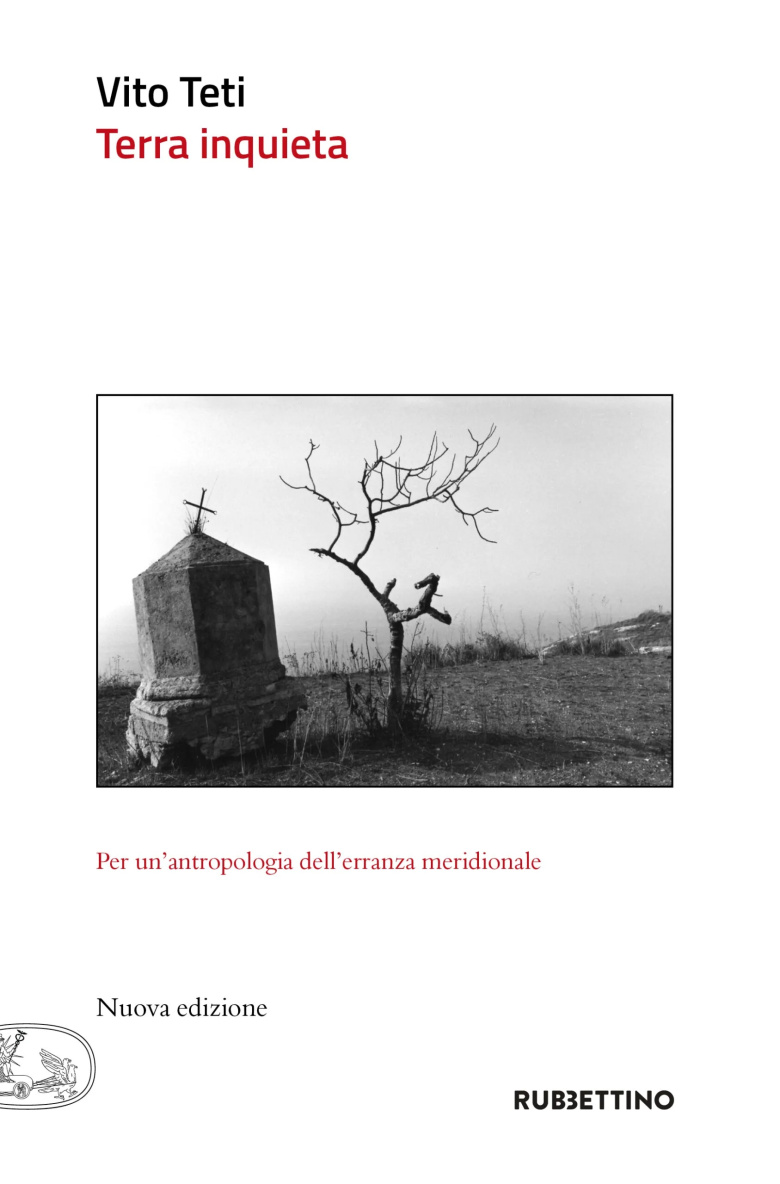
Ma Terra inquieta (Rubettino, ultima edizione 2023) mi pare lo specchio in cui si riflette l’insieme del pensiero di Vito Teti e il suo movimento, la continuità e la trasformazione, l’inerzia e l’accelerazione, capace di cogliere semi di futuro nelle pieghe inaridite del passato. È un invito a rompere il silenzio, e tornare a far parlare i luoghi, e ascoltare, e decifrare le loro molte lingue, oggi sommesse, appena sussurrate, soffocate dalla cortina della chiacchiera corrente, o svanite nella corrente distrazione.
I luoghi necessitano certamente di un diverso ascolto, ma anche di una nuova narrazione: “Sono mutati l’idea di casa, di paese, di spazio abitato – scrive Teti in Terra inquieta – e si sono trasformate le relazioni familiari e amicali, il senso di comunità, il rapporto con la memoria e con la rete, il senso della malattia, del corpo e della prossimità con le persone e con la morte”.
Questa nuova narrazione si dovrà disporre a rovistare fra le rovine che ingombrano la vita dei nostri paesi, fronteggiando il vuoto e l’assenza, che “si dilata fra le cose”, e le erode, estraendo dall’oscurità, o dall’opacità del presente, la stella del futuro.
Un compito quasi eroico. Ma è il programma perseguito da Vito Teti in tutto il suo lavoro con indefessa applicazione. Vorrei dire con amore, o con spiccata passione, se la parola amore può apparire eccessiva o impropria. Ma non può sorprendere che Vito Teti, in Il risveglio del drago, confessi il suo “rimorso per non aver saputo e potuto fare niente perché i paesi non se ne andassero”.
In questo accumulo di sentimenti si forma e si sviluppa l’attenzione antropologica di Vito Teti. Un’“etnografia partecipata” la definisce Antonella Tarpino nella sua recensione a Il risveglio del drago.
Il “drago” è l’alluvione, con la frana conseguente che fra il 6 e il 7 marzo del 2006 ha costretto alla fuga l’intero paese di Cavalerizzo, 300 abitanti, nella provincia di Cosenza. Teti segue, lungo l’arco di oltre vent’anni, le sofferte vicende della “piccola comunità” presa nel gorgo dello “spaesamento”, messa al cospetto della propria fine, e le “dispersioni” che ne scaturiscono, gli “esili”, i “dolori”, le “fratture”, i “dissidi”, le “forme di resistenza”.
Nel racconto di Vito Teti, Cavallerizzo va oltre i suoi stretti confini, si allarga, diventa il mondo, e del mondo porta alla luce l’“instabilità” che lo travaglia. Questo paese sperduto fra i monti di Calabria ci riguarda, è la “metafora di un’Italia e di un mondo che franano”, scrive Vito Teti. Ma “l’accaduto – aggiunge Teti – non è una fine”: “Ho la certezza che questa terra possa trarre dalla sua storica inquietudine, dalla sua perenne tensione tra stanzialità e spostamento, stabilità e fuga, una nuova sapienza per costruire un nuovo senso dei luoghi”.
All’elaborazione di questa nuova sapienza, Vito Teti, da anni, sta lavorando.
Leggi anche:
Maurizio Ciampa | Breve storia della nostra inerzia
Maurizio Ciampa | Tutti ciechi davanti alla fine
Maurizio Ciampa | Il rischio infinito
Maurizio Ciampa | Sonnambuli
Maurizio Ciampa | L’esitazione









