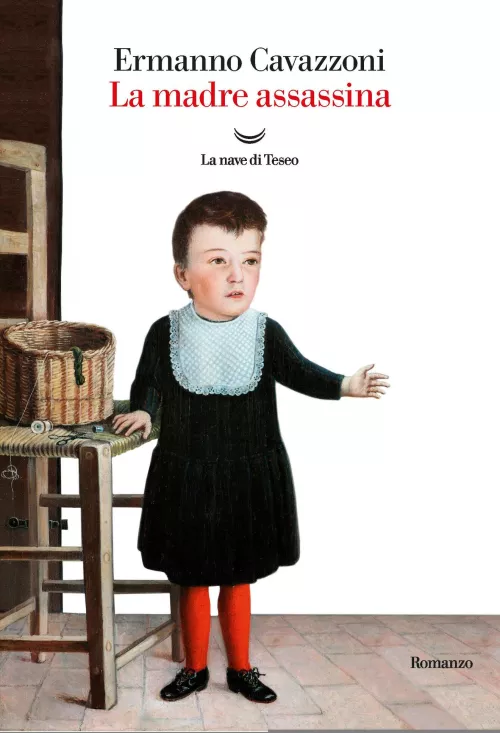Realismo visionario / Cavazzoni e la madre assassina
«Sembra che il caso sia accaduto davvero nel 2010, a quanto assicura l’autore»: così riporta il risvolto di copertina di La madre assassina (La nave di Teseo, pp. 167, 18 euro), l’ultimo libro di Ermanno Cavazzoni. «Un fatto successo davvero», si legge ancora nella breve premessa, «che la stampa ha preferito ignorare perché non generasse emulazione fra i giovani».
Tutto vero, dunque? Difficile dirlo, quando si ha a che fare con uno scrittore che ha intitolato la sua raccolta di corsivi ed elzeviri Storie vere e verissime, spiegando che «ce n’è abbastanza nel mondo da dire senza aggiungere fatti o vicende inesistenti fino a farne un romanzo». A scanso di equivoci e a dispetto di tutte le asserzioni di verità, vale la pena chiarirlo subito: La madre assassina è senz’altro un racconto d’invenzione; del resto, la dicitura “Romanzo” si legge, per quanto un po’ in disparte, fin dalla copertina, sulla quale campeggia un’immagine leggermente inquietante, ricavata da un dipinto privo di titolo (1888) di Giuseppe Antonio Ferrari, che raffigura un bimbo dai calzettoni scarlatti e dallo sguardo assente, che tende la manina paffuta nel bianco circostante.
Anzi, proprio la pretesa di raccontare il “vero” dovrebbe metterci in sospetto, dato che Cavazzoni non esita a ricorrere al più classico degli espedienti romanzeschi: il manoscritto ritrovato, escamotage dai precedenti illustri (da Cervantes a Eco, passando per Manzoni) da lui stesso impiegato in passato (pensiamo allo scartafaccio da cui prende le mosse La valle dei ladri, o al «vecchio taccuino oblungo» alla base di La galassia dei dementi).
In La madre assassina, tuttavia, la trovata suona persino più stravagante del solito. A differenza di altri suoi romanzi, che si svolgono in paesi più o meno immaginari (Il poema dei lunatici, La valle dei ladri) o addirittura in epoche remotissime (La galassia dei dementi), La madre assassina è ambientato in un tempo e in un luogo ben precisi (Milano, settembre 2010). La trama ruota attorno a un efferato delitto, perpetrato fra le mura domestiche: la madre del titolo, con la complicità dell’amministratore e forse di tutti gli altri condomini, ha fatto fuori il figlio, tale Andrea Pacini di anni 22, occultandone il cadavere e sostituendolo con una sorta di “doppio robotizzato” in tutto e per tutto uguale a lui. Seguendo una tradizione collaudata, Cavazzoni non lesina sui particolari raccapriccianti: cadaveri nascosti nel congelatore, membra umane sminuzzate per farne ragù di carne, gatti scuoiati, innocenti murati vivi in cantina, eccetera. Il tutto narrato in terza persona dalla prospettiva straniante della vittima, o quanto meno del suo sostituto artificiale.
Ora, perché spacciare per vera una storia così clamorosamente inverosimile, per di più ribadendone a ogni piè sospinto l’autenticità? Difficile credere che Cavazzoni abbia voluto confezionare una parodia volutamente sgangherata del non-fiction novel; oppure che abbia voluto mettere alla berlina il sensazionalismo pulp della cronaca nera (un aspetto che comunque non mi sentirei di escludere); o ancora, che abbia voluto satireggiare l’ossessione tutta contemporanea per le fake news.
Per rispondere, basterebbe dare una scorsa ai suoi libri precedenti, fra i quali possiamo annoverare una riscrittura della Legenda aurea di Jacopo da Varagine (Le leggende dei santi, 1993), una raccolta di agiografie moderne (Vite brevi di idioti, 1994), una di agiografie antiche (Gli eremiti del deserto, 2016) e un paio di pseudo-trattati (Storia naturale dei giganti, 2007; Guida agli animali fantastici, 2011). Poemi, novelle, biografie di santi, resoconti fantastici di creature immaginarie e viaggi in Paesi lontani; “Si dice”, “si narra”, “pare che”, “sembrerebbe”: questi i generi di riferimento e le formule predilette da Cavazzoni fin dai tempi di Il poema dei lunatici. In effetti, che cos’è la leggenda metropolitana se non la versione contemporanea, un po’ malconcia e degradata, delle migliaia di storie semivere o favolose storie che nell’Europa premoderna si diffondevano passando di bocca in bocca, giungendo nel sermo humilis e talvolta accendendo la fantasia di un Boccaccio o di un Chaucer?

La madre assassina come leggenda (metropolitana) moderna, dunque. Una struttura ideale per lo scrittore reggiano, nella quale poter convogliare alcuni dei suoi temi favoriti. Il primo è senz’altro quello della paranoia, da lui esplorato fin dagli esordi: già il Poema dei lunatici ne raccoglieva un discreto catalogo, dai pozzi parlanti alle popolazioni che abitano gli scarichi dei lavandini; in questo caso, è la trama stessa del romanzo ad apparirci come il parto letterario di una mente sconvolta (viene in mente il progressivo scivolamento nella follia dell’io narrante del Diario di un pazzo di Gogol’), che reinterpreta la realtà secondo un principio di sospettosa quanto solida coerenza. Partendo dalla constatazione di essere un automa di ultimissima generazione («La pelle copriva tutto, ed era una similpelle incredibile, duttile, di fattura avanzata, un pegamoide con un reticolo fisso di sensori, simile al tessuto umano, un polimero a lunga catena molecolare»), il delirio persecutorio del protagonista dilaga pian piano a tutti gli aspetti, anche i più banali, del quotidiano («Era una fetta di fegato. Vitello? ha chiesto con tono sarcastico. Evidente che non era vitello. Evidente che dopo la mano, adesso volesse fargli mangiare il suo fegato. Voleva eliminare il cadavere, che negli omicidi è il problema maggiore»); fino a deflagrare in un vero e proprio incubo ad occhi aperti, a sfondo gotico-fantascientifico.
Accanto alla paranoia trova posto l’ibridazione fra l’umano e il meccanico; o, più in generale, fra l’organico e l’inorganico. Anche in questo caso, siamo in perfetta continuità con le opere precedenti di Cavazzoni e in particolare con l’ultimo romanzo, il colossale La galassia dei dementi, nel quale – lo ha osservato Mario Barenghi su “doppiozero” – le pagine più felici riguardano appunto le "bizzarre commistioni" fra le due sostanze, sempre restituite con un linguaggio settorialmente ineccepibile. In questa direzione si muove La madre assassina, anche qui regalandoci momenti di allucinata comicità: «E anche il cuore batteva con moto regolare automatizzato. Diceva cuore, ma doveva essere una pompa oleodinamica, come ce ne sono nei macchinari da sterro, però molto rimpicciolita, forse di ceramica, o di un elastomero tipo isoprene o isobutilene». O ancora: «Ci vedeva in modo pazzesco, non come un microscopio ma quasi; come se avesse una lente d’ingrandimento da filatelico in ogni occhio, e quel che guardava si staccava dal resto e acquistava una sua luce, se piuttosto non era l’occhio suo fotofosforico che lo illuminava».
Passaggi come questi confermano, se ce ne fosse ancora bisogno, quanto l’etichetta di “narratore padano”, applicata al Nostro, mostri ormai la corda. Nel risvolto di copertina vengono evocati Franz Kafka e Philip K. Dick. Il primo termine di paragone è senz’altro più persuasivo, non fosse che lo scrittore praghese è uno degli autori più amati dal Nostro (si veda il saggio Un artista della scrittura, pubblicato in Il limbo delle fantasticazioni, 2009): La madre assassina ricalca ironicamente l’incipit di La metamorfosi («Dopo una notte turbata e cancellata dalla memoria, si è svegliato che non era più lui»). L’influenza del secondo mi sembra invece più generica, e limitata soprattutto all’immagine del replicante dai ricordi innestati artificialmente: un tema ripreso da Ma gli androidi sognano pecore elettriche? (e certo Cavazzoni ha ben presente anche la trasposizione cinematografica del romanzo diretta da Ridley Scott).
Se proprio volessimo giocare ai richiami e alle fonti, muovendoci indifferentemente dentro e fuori la letteratura, dovremmo forse menzionare lo Hoffmann di L’uomo della sabbia (Andrea come una sorta di Nathanael moderno?); lo Tsukamoto di Tetsuo (il momento in cui il protagonista si guarda nello specchio del bagno, «per vedere se trapelava qualcosa di sottocutaneo, tubature interne o fili» richiama uno dei momenti-chiave del film); e, soprattutto, l’universo ctonio di Lovecraft, da cui sembra discendere la scena principale (o “primaria”, come autorizzano a credere alcuni indizi vagamente freudiani sparsi qua e là nella trama), nella quale il protagonista assiste alla metamorfosi notturna della madre, in realtà creatura tentacolare somigliante a una piovra. «C’era un polipo enorme, ed era sua madre, era nel suo vero aspetto – era evidente – era un essere venuto su dagli abissi. […] Era aggrappata con i suoi lunghi tentacoli al tavolo, era grigia, umida, era la sua carnagione, la bocca sottostante coperta di peli, coi quali tastava, erano vivi, e in mezzo un becco da pappagallo, che usava per pizzicare un cartoccio aperto». L’indeterminatezza dell’autore di Providence non si addice tuttavia all’accurato realismo descrittivo di Cavazzoni; il quale semmai dimostra, una volta di più, come la precisione sia un elemento fondamentale quando si maneggia il fantastico.
Ecco allora che ritorniamo ai due poli da cui eravamo partiti: descrizione e invenzione, finzione e realtà. Ma si tratta, come il romanzo dimostra, di due poli opposti soltanto in apparenza, poiché, come ha detto una volta Federico Fellini, figura senz’altro cara allo scrittore reggiano: «L’unico vero realista è il visionario».
Leggi anche:
Una distopia catastrofica | Ermanno Cavazzoni, La galassia dei dementi di Mario Barenghi
Ermanno Cavazzoni | Il ritorno dei lunatici di Michele Farina
Il pessimismo comico di Ermanno Cavazzoni | Storie vere e verissime di Nunzia Palmieri