Cézanne, Matisse e io / Due artisti da romanzo
Un iperzelante ammiratore di un pittore che egli definisce senza esitazioni il più grande di tutta la Svezia di sempre e forse anche del mondo, intraprende il viaggio di raccolta di documentazione su di lui nel suo villaggio natale sperso tra montagne e foreste nel profondo Nord svedese e ne scrive di seguito la biografia. È L’ultimo bicchiere di Klingsor di Torgny Lindgren (Iperborea, Milano 2016), titolo che probabilmente fa il verso a L’ultima estate di Klingsor di Hermann Hesse, altro breve romanzo su un pittore di tutt’altro tono e intenzioni.
Klingsor ha fatto una scoperta che gli ha cambiato la vita: ha trovato un bicchiere, peraltro abbandonato dal capostipite della sua famiglia decenni prima, sopra un ceppo tagliato maldestramente storto; ebbene, col tempo quel bicchiere si era semplicemente raddrizzato da sé solo, “era diventato dritto in alto e obliquo in basso”. È di fronte a questo fenomeno che Klingsor diventa artista, perché “tutt’a un tratto gli fu chiaro che la materia morta non è morta”.
Subito si iscrive a un corso di disegno per corrispondenza, che poi evolverà nel corso superiore di pittura, e disegna e dipinge per tutta la vita esclusivamente nature morte, nella stragrande maggioranza con la presenza del misterioso bicchiere che porta sempre con sé. Vorrà raggiungere la sua insegnante, Fanny, a Malmö, ma non prima di avere fatto un lungo e strano giro dell’Europa per conoscere i musei e l’arte che si fa. Ma lo fa a modo suo: all’Accademia di Belle Arti di Stoccolma, per esempio, se ne resterà talmente in disparte nella classe di pittura dal vero, peraltro disegnando nature morte pur davanti a modelle nude, che i compagni lo scambieranno per un usciere. Andrà anche a Parigi, ma solo per guardare le finestre delle più famose scuole d’arte dalla strada.
Il romanzo di Lindgren è esilarante, ma di un umorismo non dichiarato, per cui noi stessi esitiamo spesso a ridere per non sentirci ingiusti nei confronti di una convinzione così radicata nel personaggio. Fanny, che all’inizio l’ha accusato di presunzione, se ne innamora e diventa la sua compagna e la sua grande difenditrice, convinta per prima che egli sia il più grande pittore vivente. Con uno zelo abnorme gli organizza l’unica sua mostra personale nella scuola abbandonata del suo paese natale neanche fosse in uno dei più importanti musei del mondo. È la gloria, secondo loro, anche se soltanto i paesani la visitano, nessuno viene da fuori e nessuno ne scrive. Un accadimento un po’ alla Capolavoro sconosciuto al rovescio chiuderà il romanzo e la vita dell’artista, che non sto a svelare per non rovinarne la lettura.
Una vita provinciale sovraccaricata da pochi superammiratori, un po’ ridicola, un po’ patetica, ma portata avanti, anche dal biografo, con una determinazione assoluta. Il fatto è che forse Klingstor ha scoperto davvero qualcosa di importante e questo gli basta, ed è il nocciolo duro anche del lato serio del romanzo. Lindgren ce ne suggerisce il valore facendo dire a Klingstor, con la sua sicumera sopra le righe: “Abbiamo una quantità enorme di cose in comune noi tre, Cézanne, Matisse e io”.
L’abbiamo anticipato: quel bicchiere che si è raddrizzato da sé gli ha fatto capire che tutta la materia vive, non esiste “natura morta” bensì, come si dice in altre lingue, silenziosa o calma. Il bicchiere è così, oltre che originario, anche “ultimo”, nel senso forte – non più ironico – delle ragioni ultime, perché mostra l’essenza fisica e metafisica della realtà, quella a cui hanno mirato anche i grandi pittori citati, e non solo quelli, quella di un’arte “capace veramente di vedere attraverso le cose, un’arte senza lati esterni”, capace di mostrare “gli straordinari movimenti e la vita eterna che esistono nell’intimo della materia”. “Gli atomi, i soli, le nebulose, i buchi neri, tutto trova spazio in una natura morta. E chi la dipinge è puro e innocente”. Anche qui Lindgren ammanta la cosa di ironia, arrivando a far dire agli ammiratori di Klingstor che sia stato lui il primo a intuire nientemeno che l’esistenza della particella di Higgs, ma forse non ride quando sintetizza definendola “quella particella dunque che collega l’esistenza con la non-esistenza”.
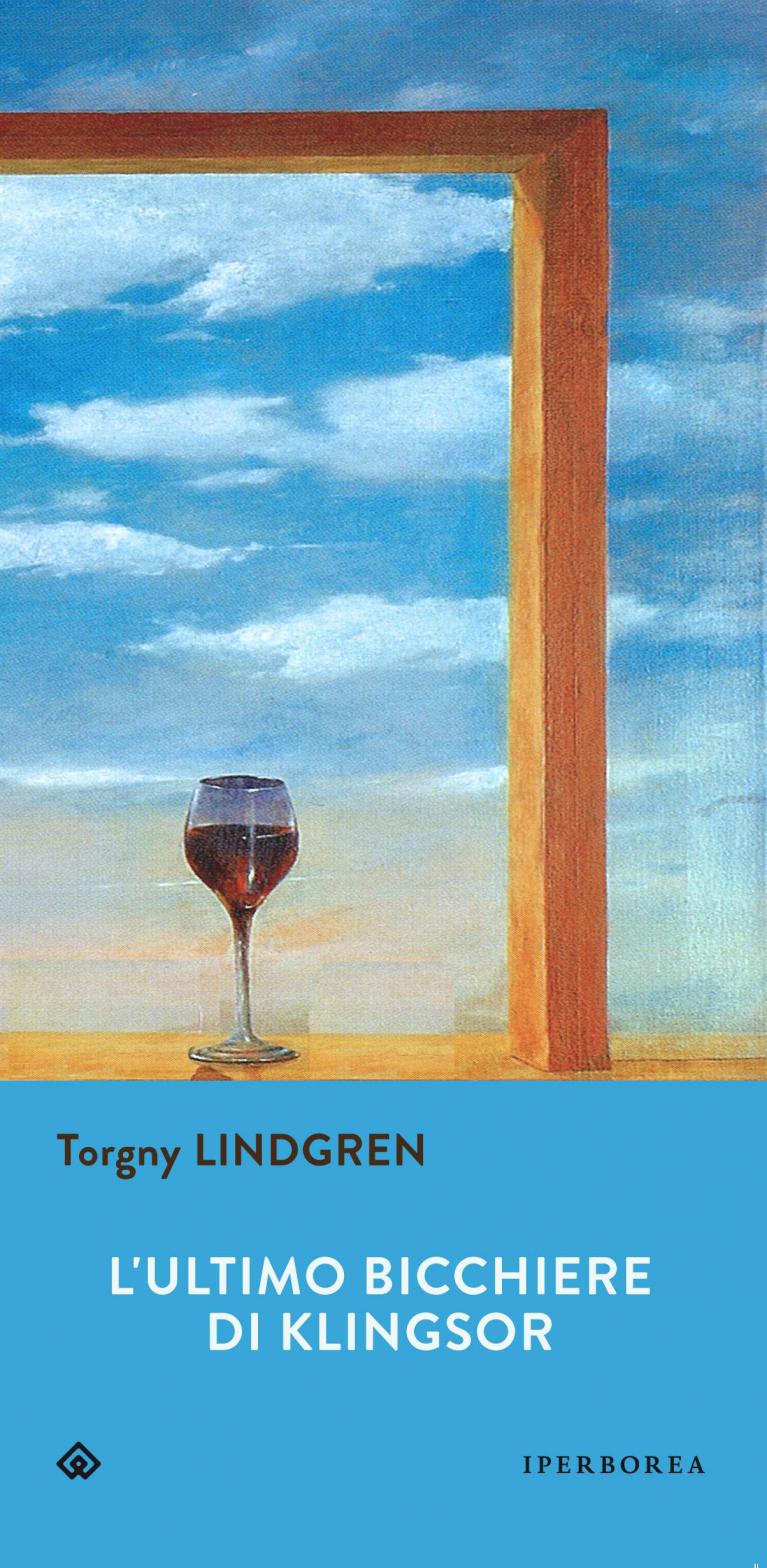
Restiamo anche noi in sospeso, perché no? Anzi a me sembra la particolarità stessa del romanzo di Lindgren, che ci fa dubitare sia quando ridiamo che quando ci sembra di cogliere un affondo estetico-metafisico. Chissà? E aggiungo: non è ciò che di fatto ci accade in coscienza di fronte a tanti artisti di tutto il mondo, anche strapaesani, che in modo diverso oscillano ai nostri occhi tra la sproporzione di ciò che credono di aver realizzato e quel “segreto” che pure forse hanno realmente còlto?
Ma veniamo al secondo artista, protagonista di un secondo romanzo. Questo artista, a differenza di Klingstor, è reale, è esistito ed è stato un vero artista internazionalmente riconosciuto, passato alla storia. Si tratta di František Drtikol, grande fotografo boemo degli anni venti e trenta del secolo scorso, situato stilisticamente dalle storie della fotografia tra l’Art Déco e il Modernismo. La specialità per cui è più conosciuto sono i nudi in cui i corpi delle modelle sono ripresi in scenografie dalle forme spesso astratte, forme tra forme, corpi tra simboli e astrazioni. Lo scrittore ceco Jan Nĕmec ne ha scritto una biografia in forma di romanzo intitolata misteriosamente, ma anche assertivamente, Storia della luce (Safarà Editore, Pordenone 2017), quasi a voler suggerire una storia dell’essenza stessa della “scrittura di luce” che è la fotografia. Il romanzo, all’opposto di quello di Lindgren, è molto intenso, sempre teso e poetico nella scrittura, preciso nella scelta degli episodi biografici significanti e profondo nelle riflessioni, estetiche e non.
Anche per Drtikol, secondo Nĕmec, c’è una sorta di scena primaria, meno esplicita di quella di Klingstor, anzi quasi nascosta, ma altrettanto formativa. È quella dell’inizio del libro: il piccolo František va a casa di un compagno di scuola e osserva come soggiogato qualcosa che sta realizzando il padre di lui. È uno stufenwerk, ovvero un modellino che rappresenta lo spaccato di una miniera – Drtikol è nato in una zona appunto mineraria – con tutti gli strati, i personaggi, gli oggetti. È dunque il contrario della luce, il mondo buio di sotto, delle profondità, ma anche – pure qui, in fondo, come in Klingstor – dell’interno, della “trasparenza”, della visione attraverso. Anche nel caso di František la scoperta è marcata da una stortura, che resta però tale, non si raddrizza come il bicchiere di Klingstor: è il “pollice deforme con l’unghia rovinata dalla quale il papà di Hynek sta togliendo la sporcizia”. La storia della luce dunque sarà la storia della lotta tra la luce e la profondità, la deformità e la sporcizia.
Così il romanzo procede raccontando in effetti una vita non facile, tormentata, diseguale, tra la fanciullezza nel paese minerario, poi l’apprendistato in un atelier fotografico locale, quindi l’ambizione di mettersi in proprio e di metterci qualcosa di originale e di artistico, gli studi all’estero, i contatti, eccetera, il tutto intrecciato alle vicende personali di scoperta della sessualità, innamoramenti, delusioni, ripieghi, e alla storia, la Grande guerra, i contesti culturali. Drtikol è ambizioso ma anche professionale, e riesce a raggiungere i suoi obiettivi, sia l’attività di un atelier che attira le persone famose a farsi ritrarre dal fotografo di punta, sia quella artistica che lo porta a esporre nelle più importanti mostre internazionali del periodo.
La sua vita si fa complicata, il matrimonio con una ballerina à la mode e la vita nel bel mondo finiscono male, la frequentazione dell’ambiente intellettuale, dapprima esaltante, si fa poi deludente: l’esoterismo dei settori più avanzati lo affascina, lui lo sfrutta anche, per costruirsi un’immagine e conquistarsi un ruolo di primo piano, ma che cosa cerca veramente, profondamente? Nĕmec ripercorre tutte le fasi e lo fa propriamente dall’interno, come se le vivesse egli stesso, cosicché ne abbiamo non solo un resoconto biografico ma anche una riflessione sentita, partecipata, viva. La scelta di fare un romanzo piuttosto che una biografia tout court ha questo senso empatico: il racconto è svolto in una particolare seconda persona, per cui il narratore è come se si rivolgesse al protagonista stesso, come se parlasse con lui, invece che di lui: “Il giorno prima che accade, sei seduto a tavola in una casetta di minatori...” L’effetto è molto singolare, di racconto in diretta, in cui il narratore esplicita al narrato quello che sta accadendo, e perfino ciò che sta pensando. Forse anche perché la storia non è, non deve essere la sua, di lui, ma quella della luce, come dichiara il titolo.
Dunque, negli anni trenta Drtikol si interessa sempre più del pensiero orientale. In realtà si tratta di un crescendo in cui Nĕmec dà fondo alle riflessioni più estetiche e filosofiche. Si comincia press’a poco così, già nella fanciullezza: “Poco dopo ti viene in mente che il mondo è come una moneta che viene fatta girare sul piano di un tavolo e, solo se si ferma miracolosamente per qualche istante, allora è possibile intravedere il suo valore e il rilievo sul rovescio”. Nĕmec non lo dice, del resto Drtikol non è ancora fotografo, ma si pensi al senso di questa riflessione sul senso della fotografia: solo se si ferma l’istante si può... E ancora, più avanti: “Non ti era mai venuto in mente che l’uomo potesse percepire solo il lato rovescio del tessuto del mondo, quello con i fili annodati, il disegno sfuocato e le cuciture al contrario; non ti era mai venuto in mente che per gli occhi di coloro che vedono, il tessuto del mondo è stato ordito al contrario, dalla parte della coscienza visibile.
Mentre ti stai addormentando pensi: E se invece le cose fossero ancora diverse? Sopra di te c’è la notte, quel tamburo bucherellato dalle stelle... E se ci fosse qualcuno dall’altra parte che guarda attraverso quei buchini e muove una manovella di ferro, in modo tale che a noi l’eternità sembri solo tempo che scorre gradualmente secondo dopo secondo, minuto dopo minuto, ora dopo ora e giorno dopo giorno?” E per noi, di nuovo: la fotografia come questa scoperta, e questo sguardo e questa idea del tempo... E allora, più esplicitamente, esteticamente, ma anche a proposito di quel “rovescio”: “Non ti manca decisamente il tempo per la tua opera creativa. Rifletti su come potresti raffigurare il diritto del mondo, quel rovescio che brilla? Come puoi persuadere l’obiettivo affinché il rovescio diventi la soggettività?”
Alla fine subentra il pensiero orientale, buddismo e yoga, si diceva. Veniamo dunque brevemente all’ultima parte del romanzo. La scena centrale è una sorta di scoperta della luce interiore: “Congiungi le mani nella posizione del dhyanamudra e sul tuo viso appare un’espressione immobile. Sei qui e sei tu. Hai una candela nel corpo, si innalza dal tuo bacino come un albero. Quando la allontani con la fiamma trasparente della coscienza, non si spegne, ma si spinge verso l’alto, si arrampica sempre più su”. E Nĕmec descrive dettagliatamente e sapientemente le fasi del percorso della fiamma, finché essa, “sfaccettata come un diamante, ti perfora con la sua punta il culmine della testa, il punto di concrescenza delle ossa del cranio”. C’entra ancora la fotografia? Sì, è il culmine e insieme, in un certo senso, la fine, l’esaurimento di un compito, di una concezione che mirava a tanto.
Drtikol smetterà infatti di fotografare, ma ecco il culmine: “Ora ti volgi verso l’intero in tutto e per tutto, sospendendo i rapporti con il mondo esterno. Se ti viene ancora voglia di dedicarti alla tua creazione libera, al posto delle modelle ti ritagli delle silhouette di cartone”, e descrive il procedimento di fotomontaggio, finché, ecco la luce: “Componi quelle figure ancora come un artista, ma ormai ti interessa di più l’esperienza interiore che esprimono. Chi ha mai rivolto la fotografia verso l’interno? È come se in quelle fotografie le figure fossero illuminate soltanto dalla luce interiore, nebulosa, soffusa. [...] Durante la meditazione capisci che la coscienza è la luce e che la luce è la coscienza. Quando si uniscono è come se in cielo tintinnassero i piatti, forse come segno sei all’equazione che sta alla base della tua vita. Là, dove c’è la luce, c’è anche la coscienza latente, e là dove c’è la coscienza, si nasconde la luce. Il Maestro è impazzito, dicono”. Eccetera, perché non è finita e anche qui il finale riserva un ulteriore svolgimento.
Due artisti opposti dunque, ma quanto anche si assomigliano?









