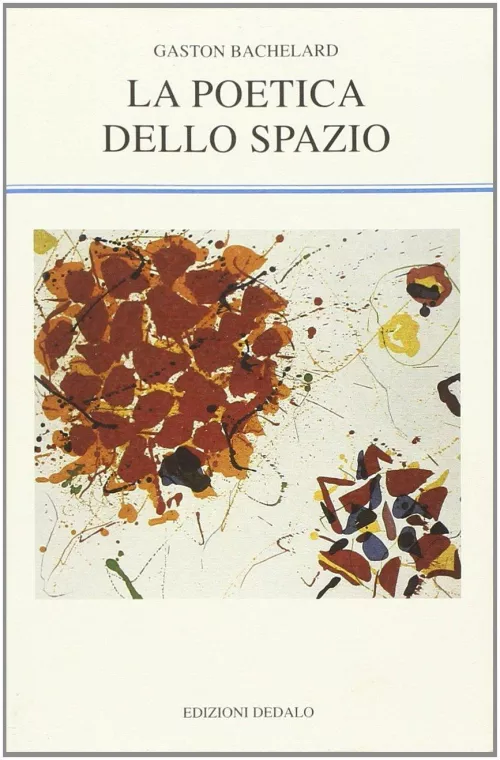Parte I / Imparare, tra cervello e macchine
“Non vi è giuoco più interessante di quello offertoci dalla nostra immaginazione”, scrive Vladislav Vancura a pagina 12 del suo capolavoro del 1934, La fine dei vecchi tempi, Adelphi, Milano 2019. Forse non vi è migliore descrizione dell’apprendimento umano che associarlo a due aspetti della nostra esperienza: l’immaginazione e la negazione. Oggi l’immaginazione ha assunto un’ulteriore centralità nei processi di apprendimento, in quanto una parte decisiva dei fenomeni e della loro conoscenza sono accessibili solo immaginandoli, come ad esempio accade con l’infinitamente piccolo, i quanti, o l’infinitamente grande, le galassie e gli universi. Allo stesso tempo la discontinuità che caratterizza l’apprendimento, nel caso degli esseri umani è notevolmente connessa alla distinzione specie specifica di dire di no, di mettere in discussione e trasgredire la consuetudine. Se, come sostiene Stanislas Dehaene, in Imparare. Il talento del cervello, la sfida delle macchine, Raffaello Cortina Editore, Milano 2019; edizione originale 2019, è solo la manipolazione delle probabilità, cioè dell’incertezza di ciò che impariamo, a consentirci di ottenere il massimo da ogni informazione, ciò è possibile non solo perché il nostro cervello tiene costantemente traccia dell’incertezza associata ad ogni informazione, ma l’aggiorna ad ogni occasione di apprendimento, svolgendo una funzione ipotetica e, quindi, almeno in parte anticipatrice. È a quel livello che entra in gioco l’immaginazione, al momento della formulazione di ipotesi di possibilità, spingendo, appunto, il reale sulla soglia del possibile. “Ed è questo ciò che rende l’apprendimento molto interessante: l’adattarsi più in fretta possibile a condizioni imprevedibili”, sostiene Dehaene [p. 18].
Grazie al linguaggio e alla matematica lo spazio delle nostre ipotesi si moltiplica in modo potenzialmente infinito, anche se poggia su fondamenta persistenti ereditate dalla nostra evoluzione. A distinguere noi umani dagli altri animali è la nostra plasticità esuberante, derivante dall’azione educativa sistematica e organizzata che ha perlomeno decuplicato il nostro potenziale cerebrale. I processi di cooperazione interpretativa del mondo che si sono sviluppati nei gruppi umani da un certo momento in poi della nostra evoluzione, hanno generato circuiti di produzione di senso condiviso e progressiva accumulazione di saperi operativi, con circolari e ricorsive ricadute epigenetiche sullo sviluppo cerebrale e sui modelli di comportamento. Dehaene mette in evidenza come la complessità della nostra società contemporanea debba all’educazione le molteplici migliorie apportate alla nostra corteccia: lettura, scrittura, calcolo, algebra, musica, senso del tempo e dello spazio, affinamento della memoria. “Per esempio, sapevate che la capacità della memoria a breve termine di un analfabeta, il numero di sillabe o di cifre che è in grado di ripetere, è circa due volte di meno di quello di una persona scolarizzata?” [p. 20]. Il confronto con la sfida delle macchine che noi umani stessi abbiamo inventato, è una costante del procedere della ricerca di Dehaene. Al tempo dei cosiddetti machine learning e deep learning, si tratta di un confronto inevitabile. Un esempio chiarificatore di Deahaene può aiutare a definire le differenze in un simile confronto. Proviamo a seguire questa domanda che riguarda un bambino: “Come fa a capire cosa signfica ‘io’, se ogni volta che lo ha sentito, il suo interlocutore parlava di …lui?!” [p.. 65]. La dimensione intersoggettiva di introiezione e proiezione con gli altri e il mondo consente apprendimenti non semplicistici. “Le reti neurali che si limitano a correlare gli input con gli output, le immagini con le parole, hanno bisogno di migliaia di tentativi per capire che la parola ‘farfalla’ si riferisce a questo oggetto colorato, lì in un angolo dell’immagine… e questo principio di correlazione non consentirà mai di capire parole senza un riferimento fisso, come ‘noi’, ‘sempre’, o ‘odore’” [p. 65].

Una bambina o un bambino possiedono una capacità ipotetica che consente loro di estrarre i significati da un insieme di ipotesi possibili. Ancor prima di imparare le parole, infatti, ogni bambino possiede una sorta di linguaggio della mente con cui può formulare ipotesi anche molto astratte e metterle alla prova. Questo è possibile perché il suo cervello non è un foglio bianco, non è una tabula rasa, e possiede le condizioni per selezionare le molteplicità del mondo, restringendo lo spazio di apprendimento e riconoscendo le parti selezionate. L’intersoggettività e le relazioni sociali del bambino danno vita a quella che può essere definita “attenzione condivisa” (p. 66), che diventa un principio fondamentale dell’apprendimento. Ogni episodio di apprendimento rafforza quello precedente, e a sua volta facilita l’apprendimento successivo. La selezione peraltro si accompagna a un principio di esclusività che associa una parola a una cosa e un concetto a un fenomeno e solo a quelli. Un esperimento aiuta a comprendere quello che accade: prendendo due ciotole identiche, una di un blu molto comune e l’altra di un colore insolito, ad esempio il verde oliva, si può dire al bambino: “dammi la scodella crapita”. Il bambino vi darà la ciotola che non è blu (una parola e un colore che già conosce) e, solo qualche settimana dopo, ricorderà che “crapita” si riferisce a questo strano colore. Del resto, antecedenti evolutivi di questa distinzione umana si ritrovano anche in altre specie animali. Stiamo parlando della capacità di usare meta-regole, che sembrano essere alla base della capacità di apprendere.
È ancora una volta, come si può facilmente intuire, il dibattito tra innato e acquisito, il punto di partenza di ogni ragionamento sull’apprendimento. Oggi abbiamo notevoli risultati di ricerca per riconoscere che forse, tra innato e acquisito, abbiamo sottostimato entrambi. “L’apprendimento è infinitamente più efficace se si ha a disposizione, da un lato, un vasto spazio delle ipotesi, ovvero un insieme di modelli mentali dotati di una miriade di regolazioni tra cui scegliere; e, dall’altro, una serie di algoritmi sofisticati per regolare i loro parametri in base ai dati ricevuti dal mondo esterno” (p. 81). Vi è una caratteristica che attraversa tutto il testo di Dehaene e che corrisponde all’importante cambio di paradigma in corso in questi anni sui temi relativi al cervello, alla mente e all’apprendimento. Quella caratteristica riguarda la progressiva affermazione del paradigma corporeo e della centralità del movimento per comprendere i nostri comportamenti e la nostra conoscenza. La rilevanza del corpo e del sistema sensorimotorio hanno dato vita al progressivo riconoscimento del cosiddetto “paradigma motorio”, che assume che la mente sia sostanzialmente radicata nella corporeità e nella capacità di movimento di un organismo.
Si tratta di un paradigma con particolari valenze innovative, frutto di risultati sperimentali e in grado di proporre un approccio naturale e non normativo allo studio della mente e dell’apprendimento. Laddove i tradizionali assunti della “teoria della mente” proponevano una concezione tradizionale delle funzioni cognitive, basate classicamente su un presunto susseguirsi di sensazione, percezione e rappresentazioni mentali, tende ad affermarsi sperimentalmente la prospettiva dell’embodied cognition, della cognizione incarnata. In base a questo orientamento teorico non c’è separazione sostanziale tra percezione e azione, tra afferenza sensoriale ed efferenza motoria; il cervello non è un semplice recettore di informazioni e un produttore di risposte in un organismo staccato dall’ambiente, ma funziona in base al riconoscimento, all’interno di una prospettiva teorica biologica integrata, dunque ecologica e complessa, dell’intimo nesso tra percezione e azione.

Tutto tende, quindi, per comprendere cosa significa essere umani, a considerare la rilevanza di ciò che ci precede, di quanto nella filogenesi e nell’intersoggettività viene prima dell’individuazione e la rende possibile. Si sta così producendo una nuova immagine dell’essere umano, che ne individui le radici genetiche ben al di sotto e ben prima della coscienza e della volontà. Come sostiene Carmela Morabito, in Il motore della mente. Il movimento nella storia delle scienze cognitive [Laterza, Roma-Bari 2020], vi è una tensione costante della ricerca verso un al di sotto, e un prima, che fa da elemento propulsore che spinge l’analisi nel corso del tempo nella direzione di un obiettivo convergente: individuare le basi neurobiologiche della mente. Sappiamo oggi che veniamo al mondo dotati di un vasto insieme di combinazioni di pensieri potenziali. “Questo linguaggio del pensiero, che è munito di primitivi astratti e regole grammaticali, precede l’apprendimento” (S. Dehaene, p. 82).
L’attività mentale è concepita in funzione della produzione dell’azione e la mente che ne emerge è incorporata: è basata sulla natura biologica, dinamica, storica dell’organismo che la esprime. Si capovolge la concezione tradizionale, logico-astratta, dello sviluppo della mente e del comportamento, proponendo una concezione organicamente integrata nell’interazione globale dell’organismo col suo ambiente: una prospettiva coevolutiva. “La mente è intrinsecamente un sistema motorio: il pensiero, la memoria, la conoscenza, la percezione, la coscienza, la motivazione, il significato, tutte le funzioni mentali nel loro complesso, affondano le radici in abilità motorie costruttive specie-specifiche” (Morabito, p. 6). L’incarnazione della mente (embodiment) è basata su una concezione corporea che pone al centro il movimento, per cui nel modello motorio si può forse individuare una via teorica al superamento della contrapposizione dicotomica tra soggetto e oggetto, tra mente e mondo. L’azione e non la rappresentazione è all’origine della cognizione. A partire dal sapere invisibile, quel vasto insieme di combinazioni di pensieri potenziali con cui veniamo al mondo, disponiamo di un linguaggio del pensiero che è dotato di primitivi astratti e regole grammaticali che precedono l’apprendimento. Importanti ed efficaci esperimenti hanno mostrato che, lungi dall’essere una tabula rasa, il bambino possiede un sapere ampio in molti campi. Tant’è vero che quando è sottoposto a delle situazioni che violano le regole di uno dei domini del sapere di cui dispone, il bambino si sorprende, rivelando la sofisticata visione del mondo che egli possiede. Disponiamo fin da piccoli e per tutta la vita di una particolare attitudine sperimentale che continua, evolvendosi. “Se queste situazioni ci piacciono”, scrive Dehaene, “è perché violano le intuizioni che tutti abbiamo sin dalla nascita e che abbiamo perfezionato nel primo anno della nostra vita” (Dehaene, p. 87).

Le abbiamo perfezionate sulla base di una dotazione filogenetica disponibile fin dalla fase prenatale e perinatale. Del resto, fino a poco tempo fa, eravamo erroneamente convinti che un neonato non sapesse nulla di matematica. Oggi siamo in grado di mostrare come un bambino, fin dalla nascita, ha la capacità di riconoscere un numero approssimativo, in maniera intuitiva, senza sapere come contare, cogliendo la cardinalità dell’insieme, indipendentemente dal fatto che l’informazione provenga dall’udito o dalla vista. Ancora una volta verifichiamo che non esiste una tabula rasa e che “i neonati percepiscono i numeri già dopo poche ore dalla nascita – e così anche le scimmie, i piccioni, i corvi, le salamandre, i pulcini e persino i pesci” (Dehaene, p. 89). Nel pulcino, ad esempio, gli scienziati come Giorgio Vallortigara e colleghi hanno controllato tutti gli input sensoriali fin dalla schiusa dell’uovo: il piccolo pulcino non ha visto neppure un singolo oggetto, eppure è in grado di comprendere l’organizzazione dei numeri (Rugani R., Vallortigara G., Priftis K., Regolin L., Animal cognition. Number space-mapping in the newborn chick resembles humans’ mental number line, Science 347, 6221, 2015, pp. 534-536). I risultati della ricerca falsificano alcune delle principali convinzioni e teorie sullo sviluppo infantile, come l’ipotesi di Jean Piaget, che riteneva che i bambini ignorassero la cosiddetta “permanenza dell’oggetto” (il fatto che un oggetto continui ad esistere anche quando non lo vediamo più) fino al primo anno di vita, o che il concetto di numero i bambini lo astraessero lentamente solo dopo alcuni anni dalla nascita. Verifichiamo oggi che è vero il contrario: i concetti di oggetto e numero sono dei primitivi del pensiero, fanno cioè parte del nucleo di conoscenze con cui veniamo al mondo, ed è combinandoli e ricombinandoli che possiamo formulare pensieri più complessi. Lo stesso vale per le inferenze probabilistiche complesse che, fin dalla nascita, si avvalgono di una logica intuitiva disponibile. Anche la distinzione tra oggetti e soggetti, tra entità il cui movimento è causato dall’esterno, e animali e persone il cui movimento è motivato dall’interno, è evidentemente disponibile fin dai primi mesi di vita. Così come è precoce e, sembra, addirittura prenatale, la capacità di percezione dei volti. Non solo un neonato con poche ore di vita si gira più velocemente verso una faccina che verso un’immagine simile i cui elementi siano stati capovolti, ma, usando una luce per proiettare uno stimolo attraverso la parete dell’utero si scopre che tre punti disposti a forma di faccia attraggono il feto più di tre punti disposti a piramide. “Il riconoscimento del volto sembra iniziare in utero” (Reid V. M., Dunn K., Young R. J., Amu J., Donovan T., Reissland N., The human fetus preferentially engages with face-like visual stimuli, Current Biology, 27, 12, 2017; pp. 1825 - 1828).
A proposito di quello che Dehaene chiama il “dono delle lingue”, il sapere invisibile di cui siamo dotati fin dalle nostre origini prenatali raggiunge uno dei vertici principali e distintivi: “Quando spegne la sua prima candelina”, scrive l’autore, il bambino “ha già posto le basi delle principali regole della sua lingua materna, e questo a tutti i livelli, a partire dai suoni elementari (i fonemi), fino alla melodia (la prosodia), passando per il vocabolario (lessico mentale) e le regole grammaticali (la sintassi)” (p. 98). Constatando quello che è accaduto nella ricerca negli ultimi venti anni circa, è difficile astenersi dalla tentazione di parlare di rivoluzione. Il cervello del neonato era una vera e propria terra incognita ed era considerato vuoto, anche se già nel 1940 Gaston Bachelard aveva scritto, in La filosofia del vuoto, che “il bambino nasce con un cervello incompleto e non, come affermava il postulato dell’antica pedagogia, con un cervello vuoto”.