Speciale
Pensatori acrobatici e funamboli / Il virus che sfugge alla presa dei saperi
L’antropologo Clifford Geertz parla dell’uomo come di “un animale sospeso a ragnatele di significato che lui stesso ha filato”.
Che cosa accade quando la trama di queste ragnatele viene lacerata? Non è difficile immaginarlo, è già accaduto, e non smette di accadere: l’animale-uomo precipita, con le sue costruzioni e i suoi azzardi mentali, nell’abisso che da sempre è aperto sotto i suoi piedi.
Augusto Placanica, storico e filosofo delle catastrofi, parla di un’onda lunga dei terremoti, un effetto a distanza, una crepa invisibile nel tessuto del pensiero, che spinge a riconsiderare il suo ambito d’azione e le sue stesse possibilità.
Prendiamo il terremoto di Lisbona del 1755, di cui ha recentemente parlato anche Gabriele Pedullà su “L’espresso” del 19 aprile. Nel 1751, inizia la grande fioritura dell’Illuminismo, con il monumentale disegno dell’Encyclopédie diretta da Diderot e d’Alembert. La luce dei Lumi comincia a diffondersi fino al momento in cui, nella città di Lisbona, alle 9.30 del 1 novembre, la terra trema, torna l’oscurità, e la Storia pare scivolare all’indietro. L’orizzonte si fa buio: “Che può lo spirito vedere all’orizzonte? Nulla: il libro del Destino si chiude alla sua vista”, scriverà Voltaire nel suo Poema sul disastro di Lisbona.
Uno schianto improvviso, l’intera città e la sua vita annientate nel giro di pochi minuti. Un brivido di morte attraversa l’Europa, dalla penisola iberica fino all’estremo Nord. E non ha fomentato soltanto le paure dell’uomo del tempo, ha polverizzato le sue certezze. Per anni, il fantasma di Lisbona agita il sonno dei grandi pensatori europei, che si applicano al funesto evento in una meditazione serrata e dal tono drammatico: Diderot, Kant, Rousseau, Voltaire. Il grande pensiero europeo transita per Lisbona, o per quello che ne resta.
Prima di ricadere a terra, Lisbona ondeggia come “grano al vento”. Vengono abbattute le sue fondamenta, con tutto quello che, nel tempo, ci è cresciuto sopra, i palazzi sontuosi, le chiese, il più ampio cerchio delle umili case, il tracciato delle strade e delle piazze, i tortuosi arabeschi dei suoi vicoli, vale a dire lo spazio dell’umano e i suoi segni. Lisbona non c’è più. Dalla poltiglia polverosa e fumante delle rovine affiorano le spoglie della vita che ha animato la città. E si alza una nube densa di dubbi e domande, pensieri irrequieti, e parole in movimento.
Il terremoto di Lisbona (un “terremoto filosofico” è stato definito) ha messo a soqquadro il pensiero, ha rovesciato le sue tavole, stravolte le mappe, con il corredo dei suoi nomi altisonanti: Dio, Natura, Uomo, Male, un intero lessico della mente sbriciolato, con le sue triangolazioni, i suoi riti, le sue cerimonie.
Lisbona è una lama conficcata nel corpo del pensiero, dritta al suo cuore. La diffusa convinzione che il mondo sia ordinato al bene, o comunque sia ordinato, disposto in armonia di cause ed effetti, scritto in “lingua matematica”, tutto questo va in frantumi insieme ai palazzi e alle case della città, inabissato con i suoi morti.
Nel suo Poema, Voltaire, che ha patito la scorreria devastatrice del disordine, raccoglie l’enorme portata interrogativa dell’evento. Non c’è ragione che lo possa contenere, o comprendere: esso eccede ogni umana misura.
“Filosofi che osate gridare tutto è bene,
venite a contemplare queste rovine orrende,
muri a pezzi, carni a brandelli, e ceneri.
Donne e bambini ammucchiati uno sull’altro
sotto pezzi di pietre, membra sparse;
centomila feriti che la terra divora,
straziati e insanguinati ma ancora palpitanti.”
“Confessiamolo pure, il Male è sulla terra…La ragione profonda resta sconosciuta”, così Voltaire conclude il suo canto accorato e dolente.
Ho evocato, e sommariamente ricostruito, questo tragico passaggio storico per arrivare a dire che, mutati tempi e circostanze, l’epidemia del Coronavirus, di cui stiamo facendo esperienza, può essere il nostro “terremoto filosofico”, un luogo di domande, che affiorano dalla “voragine” in cui siamo precipitati. Che esito dare ai pensieri assediati delle nostre quarantene? E al borbottio mentale, quando, murati nel “distanziamento”, ci mettiamo in fila al supermercato? Uno sciame di pensieri insonni, per nulla saldi, schizzi d’ansia nel generale smottamento psichico, e nella combustione dei cuori.
Scrutando la fila al supermercato, oggi abbastanza lunga, ho il tempo di chiedermi come può una società come la nostra, che era già prossima alla stagnazione, mantenersi in vita con l’immobilità, con la sincope sociale, e come può il ridotto orizzonte delle mura domestiche diventare la nuova frontiera dell’immunizzazione, l’ultimo baluardo da cui difendere la nostra vita.
Me lo chiedo, e provo a rispondermi, come credo facciano molti, che, almeno per il momento, sono le sole misure efficaci per piegare il virus, o attenuare la sua invadenza aggressiva, sfuggendo al suo abbraccio, lasciandolo precipitare nel vuoto.
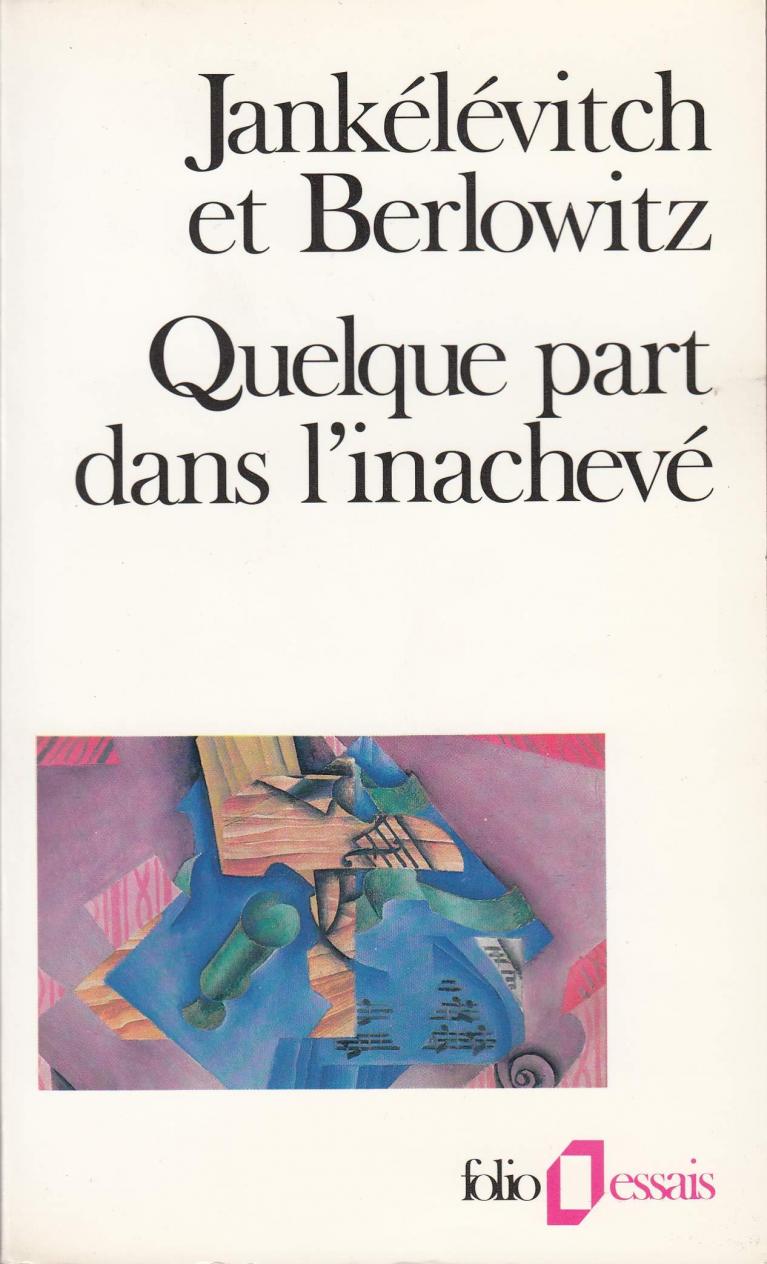
Mi rispondo che non c’è altra strada da percorrere, sperando che non sia un vicolo cieco, dove ci spinge la forza della Necessità, come in una rappresentazione tragica. La mia parte più diffidente rumoreggia, inducendomi a sospettare che dall’insieme di queste misure possa sortire una specie di sovranismo domestico. Diffidenza inopportuna? Può darsi. Devo però dire che mi prende lo smarrimento, quando sento la dissoluzione di ogni relazione sociale considerata come una forma di solidarietà, l’autoisolamento come attenzione all’altro. Mentre i corpi vengono aspirati dalla vertigine digitale, s’inneggia a una nuova sensibilità. Virtuale, naturalmente.
Noto poi che nelle lunghe file per accedere al supermercato, nessuno parla con chi gli sta attorno, davanti o dietro, come se fosse svanito nella distanza prescritta: un metro è un oceano, dove il mio vicino naufraga, evanescente come un fantasma. E sono io a spingerlo in quelle acque. Quantomeno non lo trattengo.
Il cellulare regna sovrano (si parla solo con il proprio simile), tronfio nel suo protagonismo. Se no, silenzio, in un surplus di prudenza, o di paura. Perché? Forse perché l’altro è ritenuto un antagonista, un’ipotetica fonte d’infezione, il sociale stesso è visto come una fonte d’infezione, la soglia del pericolo, zona rossa; oppure semplicemente perché, quando il virus si è avventato su di noi, la società era già finita, disgregata per effetto dello tsunami individualista. Da tempo, Alain Touraine parla della “fine del sociale”, e segnalo che s’intitola La morte del prossimo un libro di Luigi Zoja del 2009 (“L’uomo metropolitano si sente sempre più circondato da estranei”, scrive Zoja). Ed eccoli qua gli estranei, sigillati nel silenzio, eccoli inquadrati, nel loro sinistro splendore, in una fila abbastanza ordinata di un supermercato romano, il cui nome sembra una presa in giro: “Élite”.
È pur vero che l’emergenza sanitaria ha riportato in vita un desiderio di prossimità, che da tempo versava in pessime condizioni. Durerà?
Rientrando a casa, resto impigliato nelle mie domande. Ma trovo un buon appoggio (si può trovare sostegno in uno sguardo limpido) nel passaggio di un libro di Vladimir Jankélévitch di oltre quarant’anni fa (“Quelque part dans l’inachevé”). Nonostante le tante piroette della nostra storia, francamente le sue parole non mi sembrano tramontate:
“Sostengo che noi siamo in uno stato d’indigenza. E che il nostro sapere, esso stesso indigente, ci priva di ogni punto fisso, di ogni sistema di riferimento, di contenuti facilmente decifrabili, in grado di farci tirare delle conclusioni, alimentare il discorso e aprire un lungo avvenire di riflessioni. Questo nostro sapere che non sa è piuttosto una prospettiva, un orizzonte… Eccoci improvvisamente muti di fronte all’irriducibile”.
Credo di poter dire che “Doppiozero” stia dando un contributo importante per orientarci nel paesaggio di rovine mentali che andiamo accumulando, e quotidianamente ci capita di esplorare. Strappando qualche parola al “mutismo” “di fronte all’irriducibile” (è una forma di mutismo anche il frastuono dei media).
“Qualcosa è accaduto, ha scritto Rocco Ronchi in “Teologia del virus”, segnando una discontinuità radicale e irreversibile nelle nostre vite, ma non ha un contenuto da offrire al sapere. Restiamo attoniti, istupiditi, senza un discorso capace di trasformare il colpo subito in un sapere comunicabile”.
Il virus sfugge alla presa dei saperi, non conosce il galateo scientifico, rifiuta ogni intento classificatorio. Indocile, non si fa trovare dove lo si aspetta. Ed è curioso, ma significativo, che ad essere spiazzati siano stati proprio quei saperi della vita che, fino a ieri, sembravano vicini a un esteso dominio sul vivente.
Per risollevarsi dopo questo “terremoto filosofico”, occorre destreggiarsi nelle forme monche di un sapere dalle verità ridotte, un “semi-sapere”, il solo, mi pare, cui si possa, oggi, legittimamente aspirare. Servono pensatori acrobatici, funamboli, che non temano l’infezione dell’anomalia, i salti e le rotture del discontinuo.









