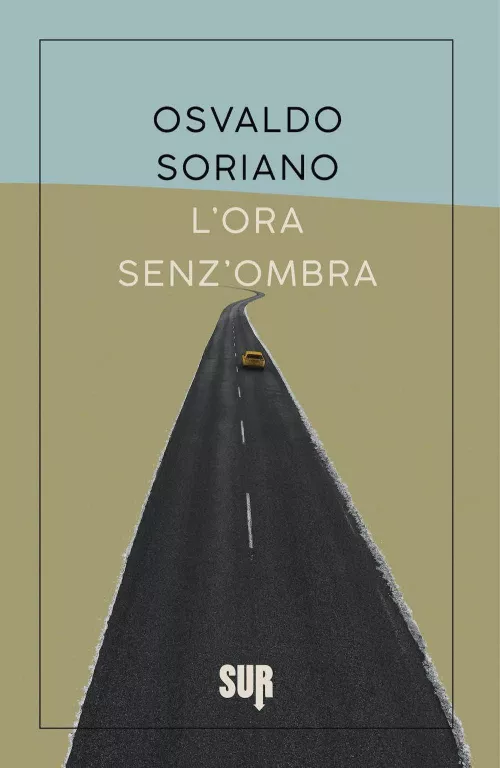Torna il grande argentino / Osvaldo Soriano, L’ora senz’ombra
Ho l’abitudine di rileggere, di tanto in tanto, alcuni autori amati particolarmente, concentro queste nuove letture specialmente d’estate. Lo faccio non solo per il piacere di tornare dentro pagine meravigliose ma anche per misurarmi di nuovo, per pesarmi rispetto a quei romanzi, o a quelle poesie. Quando rileggiamo a distanza di anni non siamo più gli stessi, siamo un’altra persona, abbiamo più compleanni alle spalle, forse più conoscenze, di certo un ampio bagaglio d’esperienze. Se siamo fortunati a quelle storie possiamo aggiungere nuovi significati, mantenendo (o rinnovando) il sapore di quel primo stupore. La letteratura grande non scade, noi invece sì, ma possiamo arrivare a quel finale nel modo migliore. Una delle mie consuetudini è rileggere, tornare nel luogo sicuro e insicuro della scrittura bella. Ogni mese d’agosto riprendo un libro qualunque di Pavese e poi gli affianco antichi amori, un anno Ricardo Piglia, un altro Silvina Ocampo, un altro Roberto Bolaño, le poesie di Nicanor Parra, un’altra estate Juan Carlos Onetti.
Quattro o cinque anni fa ho letto di nuovo tutti i libri che ho di Osvaldo Soriano, che incanto, che pomeriggi stupendi. Triste, solitario y final; Quartieri d’inverno; L’occhio della patria; Pensare con i piedi; Fútbol e L’ora senz’ombra (tutti, fino a quel punto, in edizione Einaudi). L’ora senz’ombra l’ho letto per ultimo, l’ho finito una sera di fine agosto, pioveva, avevo le lacrime agli occhi per la gioia. Un raro capolavoro di introspezione, inventiva, ricerca letteraria, costruzione dei personaggi. Poi, come succede spesso, ho dimenticato tutto. Non ho dimenticato le cose, ma ho dimenticato che fossero in quel libro.
«In quei ritratti degli anni Quaranta si vedeva mia madre raggiante e felice: sembrava una ragazza vanitosa e sfacciata, anche se le foto sono istanti della vita che poi non si sa mai dove mettere».
Le cose, i personaggi. Di frequente mi tornava in mente il campione di basket che dall’Arizona va a giocare in Argentina si innamora di una donna bellissima, e poi un giorno si presenta in banca con una pistola, saluta tutti, ringrazia, prende i soldi e se ne torna in America.
Ho pensato spesso all’uomo che girava l’Argentina in lungo e in largo nei cinematografi per tagliare le scene che la censura non voleva. Ho pensato al prete che viaggiava con due valigie piene di denaro, affranto e senza auto. All’omino delle sorprese degli ovetti Kinder. A una vecchia Cinquecento guidata da una donna bellissima. Ho ricordato queste cose in maniera nitida, ma mai tutte insieme, non le associavo a Soriano, a un suo romanzo, o a qualunque altra opera. Erano fatti di cronaca? Erano sogni che avevo fatto? Fotografie che avevo osservato a una mostra? Scene di un film di Campanella? Erano, forse, tutte queste cose insieme, era la letteratura.
Ho fatto cuore e memoria qualche settimana fa, quando Sur ha ripubblicato L’ora senz’ombra (nella traduzione di Glauco Felici), e ho cominciato a leggere, a quel punto, per la terza volta. Ho scoperto (e forse lo avevo solo scordato) che tra i compiti di un’opera letteraria c’è quello di fornirci delle emozioni, delle immagini, e poi di spostare un’azione, un movimento molto più in là dello spazio e del tempo della narrazione pura.
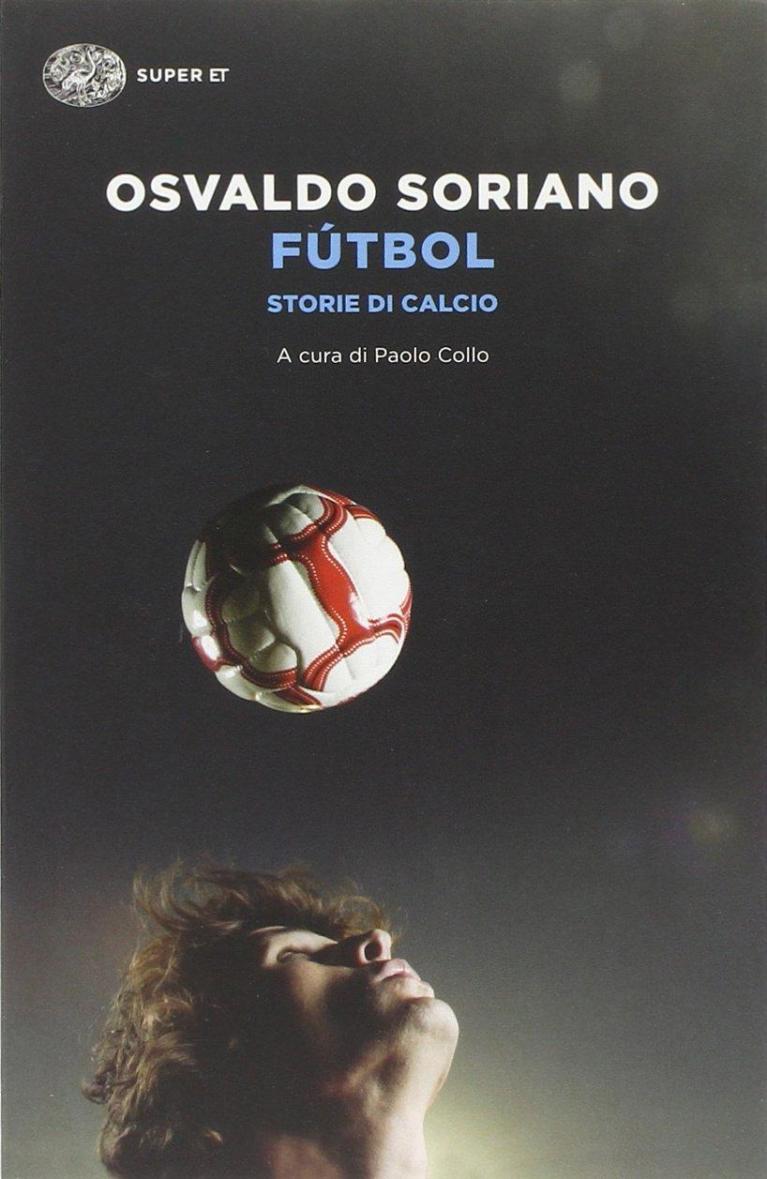
In un certo senso, il romanzo riuscito, la poesia più bella, sono destinati a scomporsi e ad accompagnarci in altra forma, frammento, sguardo. Quello che abbiamo letto diventa così tanto cosa nostra che pare un ricordo, una cosa saputa ma di cui non ricordiamo l’origine. Ed ecco il campione di basket, l’uomo del cinematografo, ecco la donna bellissima, il prete, l’editore, ecco l’attore che si rotola sulla spiaggia, ecco la Ford Torino e il suo incendio, ecco la macchina da scrivere, ecco le strade d’Argentina, ecco il romanzo andato perduto, ecco uno dei più grandi scrittori di sempre: Osvaldo Soriano.
«Viviamo in attesa di qualcosa di grandioso e questo ci fa stare in piedi».
Uno scrittore al volante di una vecchia Ford Torino, ha ricevuto un anticipo dal suo editore per scrivere una sorta di guida sentimentale sulle passioni argentine. Attraversa le strade della provincia argentina, scrive senza pause, dorme in auto, si lava quando capita nei fiumi, in qualche hotel, a un abbeveratoio di mucche. Incrocia piccoli paesi e città mentre sullo sfondo scivola la sua vita, compaiono Buenos Aires e Mendoza, si delinea il suo passato, la sua vita, l’origine, la costruzione dell’io, la perdita. Laura ed Ernesto madre e padre, che si sono amati tanto e per poco. Anzi no, forse Ernesto l’ha amata per sempre, anche dopo la morte. Ernesto in precaria salute, che scappa dagli ospedali, fino a diventare un personaggio nel personaggio. Soriano lo racconta in memoria e in assenza.
Il narratore lo cerca in fondo al baule della Torino, assembrata proprio dal padre, nei vecchi giornali, nei diari, nella testa. Un padre in bianco e nero, un avventuriero, un peronista, uno da casinò, discoteche, amori da una notte, da sigarette senza sosta, da auto in corsa con il finestrino aperto. Un padre perduto e mai svanito, un padre che serve al narratore a mantenersi in vita, a proseguire il viaggio. E poi Laura, bellissima sulle copertine dei giornali, insicura e decisa, libera, sognatrice di Hollywood, ma finita a Mendoza, scappata con un droghiere, morta presto, mai dimenticata da Ernesto, ricostruita come in un mosaico di lacrime e fotografie dal figlio.
«Non so, mi sembra che arriviamo sempre tardi a ciò che amiamo».
Soriano congegna il romanzo perfetto, l’opera che compie la sua parabola narrativa, dentro c’è tutto. La storia dell’Argentina, il tema della fuga (come se l’esilio non si esaurisse mai e si dispiegasse all’infinito a bordo di quella Ford), l’invenzione del racconto e le tracce del memoir al suo interno. E il memoir è vero, e il memoir è finto. Si parte per scrivere una storia e poi si scrive di sé, e si scrive sempre la stessa vicenda, pare volerci dire questo il protagonista di questo romanzo, che pagina dopo pagina somiglia a ognuno degli attori che Soriano dispone sulla scena. È il giocatore di basket, è ognuno degli uomini che si sono innamorati di sua madre, è l’uomo delle sorprese Kinder, è il dentista mezzo matto che è stato nazista, è il prete disperato, è l’attore amico che diventa incendiario (suo malgrado), è Laura ed è Ernesto. Soprattutto è la donna che si spedisce le lettere da sola, perché L’ora senz’ombra è una lunga lettera di Soriano ai lettori e alla letteratura, e del narratore a sé stesso.
Comincia a spedirla quando avvia il motore, la riceve nelle ultime pagine, sulla soglia dell’ultimo capitolo.
«Sapevo che dall’altra parte delle parole c’è il più grande dei fallimenti. Era questo che voleva dirmi mio padre quando sosteneva che la scienza è superiore alla letteratura».
Mentre crea un personaggio, Soriano, pone questioni sulla scrittura, omaggia gli autori amati, Borges su tutti e ci ricorda a che serve la letteratura. A tutto e a niente, a farci sognare, ad aiutarci a capire chi siamo e a metterci al volante di una Ford Torino senza un motivo particolare, ma con mille ragioni che salteranno fuori a ogni curva, tutte le volte che ci fermeremo a far benzina, a bere lungo la strada, a piangere senza motivo davanti a un cartello stradale di cui avevamo scordato l’esistenza.