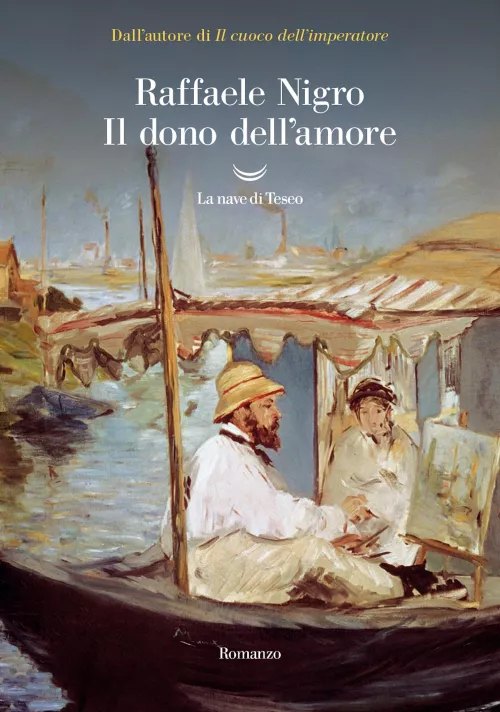L'altrove di Raffaele Nigro
Chi va a Matera e visita Palazzo Lanfranchi non può non rimanere colpito dall’imponenza del telero che Carlo Levi allestì per il centenario dell’Unità d’Italia, nel 1961, un’opera epica e monumentale (3 metri di altezza x 18 di larghezza) che celebrava la Lucania e, soprattutto, Rocco Scotellaro, il figlio prediletto di quel mondo contadino che tanto aveva affascinato Levi stesso fino a diventare uno snodo cruciale della sua poetica. Scotellaro è il filo che unisce un racconto in tre atti: l’infanzia con i suoi giochi, la giovinezza di intellettuale e politico, la sua morte e il compianto funebre di una madre e di una terra. Quel che il telero Lucania ’61 non diceva apertamente, però, era lo spirito di una civiltà che non aveva mai smesso di sentirsi comunità, sia pure appartenente a un mondo minore, periferico, poco avvezzo a calcare i palcoscenici della Storia. Levi questo lo aveva intuito.
Aveva capito cioè che preesiste nel Mezzogiorno il bisogno di raccontare attraverso i caratteri di una festa mobile, alla maniera di Hemingway per intenderci – un Hemingway un po’ latino, certo, diciamo anche mediterraneo o meridiano –, a dispetto di ogni dramma che sta a contorno del racconto e lo cinge d’assedio. Levi, in altre parole, aveva compreso che nel Sud non può attecchire il romanzo dell’individuo chiuso nella sua solitudine (anche se la civiltà contadina resta pur sempre ai suoi occhi una comunità impermeabile ai movimenti della Storia) e, se proprio bisogna rappresentare qualcosa che appartiene all’epica dell’individuo, questo qualcosa dev’essere attorniato da altri volti, altre voci, ritratti, sagome, figure. È stato questo il paradigma della narrativa meridionale almeno per un lungo tratto di Novecento e in un certo modo dovrebbe esserlo ancora: un corteo carnevalesco che cammina sull’orlo dell’abisso, una delirante sfilata di maschere trasognate, brave a interrogare l’irriconoscibilità del tempo presente in nome di un tempo arcaico e solenne, robusto com’era quello delle divinità preistoriche.

Poi in realtà, questa inclinazione, la narrativa meridionale l’avrebbe dimenticata o persa del tutto, come se l’istinto comunitario si fosse inabissato per fare spazio al torbido del delitto e del giallo, i nuovi criteri che hanno attecchito sotto l’antico confine del Garigliano e sul culmine del passaggio tra Novecento e Duemila, quando il vecchio secolo ha ceduto il testimone al giovane millennio, il Sud si è scoperto una terra di delitti, di commissari, di avvocati e di carabinieri. Prima gli scrittori del Sud si sentivano amici di Boccaccio, adesso vivono in un far west stemperato da gerghi dialettali innaffiati da calici di bianco, ma è una tenebrosità che poco ci appartiene. Per fortuna resiste qualche scrittore che ha conservato il segno hemingwayano della festa mobile, quell’aria un po’ scombinata in cui sembra che stia per accadere da un momento all’altro qualcosa d’importante e poi magari tutto riconduce a una normalità di rapporti tra storie svagate e ciarliere. Raffaele Nigro è uno dei (rari) meridionali in cui sopravvive questa dimensione narrativa e ogni suo nuovo libro obbliga a interrogarci su cosa sia diventato il Mezzogiorno da quando egli stesso ha cominciato a raccontarlo, nel 1987, con le scorribande dei suoi briganti e lo studio dei documenti d’archivi.
In effetti, se dovessi pensare a trovare un paragone per Il dono dell’amore (La Nave di Teseo, p. 423, euro 22), il primo pensiero va proprio al telero di Lucania ’61 e non perché Nigro lo incastona tra le sue pagine, ma in virtù di un’aria scanzonata che accompagna una comitiva di artisti baresi nei suoi giri notturni, nelle loro trasferte di lavoro, nelle avventurose scorribande dove i discorsi transitano dalla malinconia allo scherzo, dalla fantasia ai ricordi e formano quel robusto brusio di sottofondo che fa acquisire al romanzo il carattere di un’infinita conversazione, sia essa una disputa tra filosofi (com’è nella Scuola di Atene di Raffaello) o il sogno vagheggiato da un Dante prigioniero del bisogno di amicizia: «Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io…» Chi tiene in piedi l’architettura del libro è la voce in controcanto di Marsilio De Ponte, giovane pittore che fa dei propri sogni la materia del suo lavoro e non teme di sentirsi inattuale in un paesaggio votato alla più spinta occidentalità.

Non è difficile venire a conoscenza di quel che si insinua nei dialoghi di questi personaggi che hanno il mare perennemente negli occhi e la testa ai mondi che sono stati o che non lo saranno mai. Basta fermarsi a metà di una qualsiasi pagina e tendere l’orecchio al vocio: amori impossibili, futuro incerto, il rimpianto per una identità perduta, la fine di una civiltà antica senza che un’altra l’abbia sostituita con altrettanta autorevolezza, perfino la consapevolezza di vivere in un mondo i cui modelli sono ormai tramontati ma con la consapevolezza che qualcosa può essere sopravvissuto, «di qua il mondo contadino, di là il postindustriale», si legge a un certo punto. Ma è questa strana condizione di altalena a dominare la scena, lo stare cioè «ai confini del benessere occidentale e del primo malessere mediorientale» che assegna alla terra di Puglia lo statuto di una frontiera mai del tutto convinta del suo ruolo protettivo.
Ci sono donne dalla bellezza eburnea che entrano ed escono dalle pagine come fate misteriose, imprenditori pungolati dal sogno di un benessere democratico, indomiti cartapestai assediati dal delirio carnevalesco, creature in fuga da se stesse come discendenti di un’antica inquietudine che proprio su quei mari, tra l’Adriatico e l’Egeo, ha fatto di ogni viaggio una specie di mitologica odissea. Dove vuole condurci Nigro con questa sua storia di artisti che si interrogano sulla condizione del nuovo Mezzogiorno? Dove va a concludersi il loro senso di inappagamento che induce a leggere il Sud come una terra da cui allontanarsi per sempre? «Milano è il centro dell’Europa straricca. Bari è il centro del Mediterraneo strapovero»: sono considerazioni che l’io narrate dissemina per giustificare il comportamento dei giovani affamati di settentrione che abbandonano famiglie e amici per andarsene nelle latitudini di un benessere calvinista ed efficiente. Ma non è più l’emigrazione degli anni Cinquanta/Sessanta, quando si andava a Milano a indossare la tuta blu da operaio. È una forma di rifiuto o di ripudio, una maniera per disegnare l’attesa di un futuro.
Il romanzo deve molto a questa dimensione dell’addio e dell’altrove. Lo deve anche in relazione ai sentimenti di amicizia e di amore che inevitabilmente conducono a quel pensiero mediterraneo secondo cui nel mare coesistono sogno e disperazione, passato e utopia, Paolo di Tarso e Agostino di Tagaste, Claudio Magris e Pedrag Matvejevič. Poi a un certo punto tutto riconduce verso il desiderio di un mondo innocente, come lo era il tempo prima del moderno: profondo, autentico, immacolato. Nel libro ha le fattezze di una ragazza tanto afflitta nel corpo quanto affamata di vita. È lei il punto cardinale che raggruma la speranza di un nuovo domani, la destinataria di un’eccezione che elegge nuovamente il pane come viatico per un miracolo che non ha nulla di trascendentale se non il sospetto di una soglia poco oltre le fattezze del finito. Nigro, va detto, ha sempre cercato mondi innocenti e stavolta lo fa caricando a bordo di una nave – il «vasel» di cui parlava Dante – la comitiva di amici in rotta verso oriente. «Ho preso questo viaggio come una traghettata verso un mondo irreale, il paese che sogno da sempre dove regna la felicità assoluta» dichiara un certo punto Michele Damiani, uno degli artisti. «Ho lasciato i miei ricordi a casa».