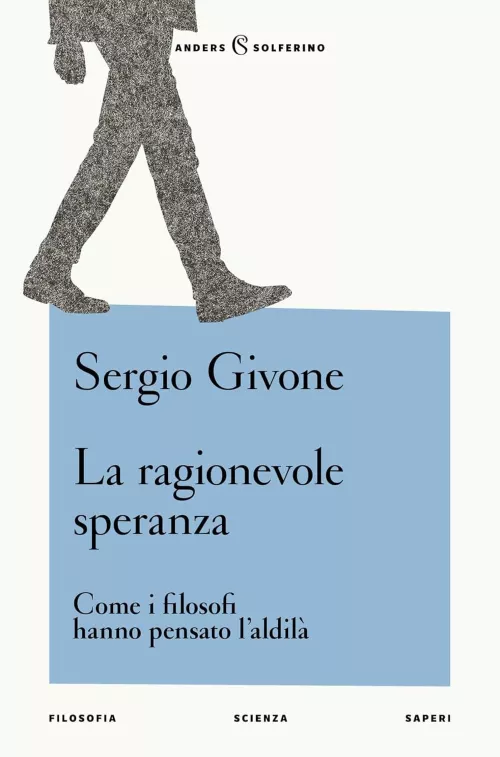Sergio Givone, i filosofi e l'aldilà
“Mi pare che il mondo dorma”, è l’esergo dal Re Lear di Shakespeare con cui il filosofo russo Léon Sestov apre la seconda parte (“Audacie e sottomissioni”) di uno dei suoi libri più noti, “Sulla bilancia di Giobbe”.
L’uomo – dice Sestov – vagheggia “un’epoca nella quale nessuno si porrà più domande… L’uomo cesserà d’interrogarsi e diventerà pari a Dio”.
È, la nostra, l’epoca in cui le domande tacciono, l’epoca prefigurata da Sestov? Direi di no a giudicare dall’ultimo libro di Sergio Givone (La ragionevole speranza. Come i filosofi hanno pensato l’aldilà, Solferino, 2025). Rompendo il galateo filosofico corrente, che fa della “secolarizzazione” un presupposto quasi naturale, Givone inquieta il suo lettore risollevando interrogativi, ben presenti nel pensiero d’Occidente, ma oggi quasi spenti o affievoliti, come residue fiammelle che non arrivano a illuminare la superficie dello stordente aldiquà in cui ci troviamo a vivere. Givone agita le acque ferme, le abitudini consolidate del pensiero filosofico a noi contemporaneo, scoperchia la lastra della sua inerzia mentale, prende di petto l’indifferenza, riportando alla luce un oggetto di cui, a stento, credo, riconosciamo i contorni: l’aldilà, oggetto non-classificato potremmo dire. Givone si adopera per dare legittimità o cittadinanza a questo strano oggetto. Con “una lanterna in mano”, con la sua luce sottile, attraversa l’intero corso della tradizione filosofica, dai greci fino a oggi, o fino a ieri. E non per rischiarare ciò che ipoteticamente fa seguito alla morte, non basterebbe la luce di una lanterna, ma per dire qualcosa di sensato, di “ragionevole” sulla vita che scorre in noi, “stupefacente e angosciante… mirabile e assurda. Dolcissima e amarissima”. Come possiamo ricapitolare la rete dei suoi antagonismi, il suo ritmo discorde, lento, e, insieme, forsennato, e la selvaggia fioritura di sentimenti fugacissimi che provvisoriamente la abitano? Sono lampi, precarie irruzioni di luce che costeggiano appena la massa dell’oscurità (“Tutto è pieno di luce e di tenebra impenetrabile”, dice un passo di Parmenide citato da Givone). Come venirne a capo? Non c’è modo forse. “Non c’è traccia della strada, ci siamo persi, che facciamo? Un demonio ci conduce, e ci porta in qua e in là”, recitano i versi di Puškin con cui Dostoevskij apre “I demoni”.

A Givone non basta la constatazione della condizione umana di smarrimento, ne vede gli effetti, conosce i terremoti dell’anima, che devastano il Novecento. Può forse risultare fuorviante il sottotitolo di La ragionevole speranza, “Come i filosofi hanno pensato l’aldilà”: fa pensare a una tranquilla successione di pensieri sull’ aldilà, a un’armonica composizione di riflessioni. Non è così: c’è nel libro di Sergio Givone un pensiero in lotta, un pensiero che, azzardando, prova ad aprire la strada non ancora tracciata. E lo fa a passi lenti, consapevole di muoversi su una linea di confine, in bilico sul nulla:
“Eppure se la vita è tutto, se con la morte tutto finisce, se la morte è un muro invalicabile, nulla è la vita. Se invece la vita, il mondo, l’intero universo non sono la sfera di Parmenide, ma l’infinito; se la porta della trascendenza resta aperta, allora possiamo sperare di avere una risposta sul senso della vita.
Di fronte all’infinito. Nell’infinito. Dove il silenzio è grande”.
Da molti anni conosco Sergio Givone, e conosco il suo itinerario filosofico, e le sue incursioni nella forma narrativa, nel desiderio, credo, di lambire la vita più di quanto l’esercizio della filosofia possa consentire, la vita e i suoi impeti, il suo procedere a strappi che al pensiero oppone resistenza, lacera il suo tessuto, ne spezza i fili. La narrazione, ma anche la poesia, diciamo la letteratura nel diverso insieme delle sue espressioni, si muovono nella carne del tempo, sanno perdonare le sue irregolarità, e si limitano a trascriverle. Potremmo arrivare a leggere l’atto letterario come un gesto di misericordia nei confronti dell’umano, un gesto di incondizionata accoglienza, di sua smisurata comprensione. Sull’umano, la letteratura si china. Mentre, la filosofia sembra guardare a distanza.
In un libro del 1984, Dostoevskij e la filosofia, Sergio Givone scriveva: “Esponendosi all’opera di Dostoevskij è la filosofia che rischia se stessa”. La ragionevole speranza, quarant’anni dopo, torna a giocare questo rischio, facendo oggetto di pensiero “quello che si ritira dal pensiero”, come si legge in un passaggio di Emmanuel Lévinas.
“Vediamo di restare in ascolto sempre, fino all’ultimo”, scrive Sergio Givone giunto quasi alla fine del suo ragionare, svelando, io credo, la natura più autentica del suo lavoro, che ha la sua radice nell’“ascolto”. È un’indagine aperta quella condotta da Sergio Givone in La ragionevole speranza, ma non scaturisce dal distacco della riflessione, nasce dalla lotta, dall’azzardo. Non dalla meraviglia come volevano i greci, ma dalla disperazione. Come per Pascal, sul quale a lungo Givone si sofferma. Come per Kierkegaard.