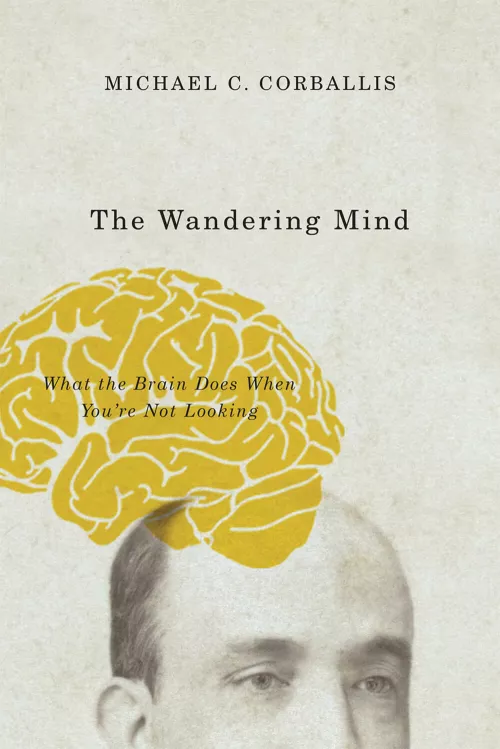Meglio concentrati o distratti?
È meglio essere distratti o concentrati? Che domanda! si dirà. Meglio essere concentrati, ovvio: è da quando abbiamo messo piede per la prima volta in un’aula scolastica, se non da prima, che insegnanti, genitori, educatori, superiori ci invitano a fare attenzione, a stare attenti. Valga l’etimo: attenzione da ad+tendo, «aspiro, miro a qualcosa»; per raggiungere lo scopo, qualunque scopo, bisogna impegnarsi. Già. Però è un dato di fatto che la nostra mente ha una forte inclinazione a disimpegnarsi e divagare: la frequenza stessa di quei richiami, a tutti familiari (state attenti! stai attento!) lo dimostra. Dalle ricerche psicologiche emerge un dato sorprendente: per un tempo pari a circa la metà della nostra esistenza vigile – quindi, sonno escluso – non pensiamo a niente di preciso. La mente umana, spesso e volentieri, vaga senza una meta apparente. Questo non significa che sia inattiva, tutt’altro; semplicemente, non è focalizzata su un obiettivo. L’alternanza fra attenzione e distrazione rientra nella fisiologia dell’attività cerebrale: la mente si tende e si allenta, si fissa e gironzola, punta e si guarda intorno. Stavo per chiedere: vi è mai capitato di distrarvi durante una lezione? durante una conferenza, un concerto, uno spettacolo? Ma la domanda giusta sarebbe un’altra: vi è mai capitato di non distrarvi, assolutamente mai, per tutto il tempo? Davvero?
Pochi mesi fa è uscito un libro dal titolo affascinante, The Wandering Mind – la mente girovaga – e dal sottotitolo ancora più suggestivo, What the Brain Does When You’re Not Looking, cioè «quello che fa il cervello quando non guardi» (The University of Chicago Press, 2015). L’autore è lo psicologo neozelandese Michael Corballis, nome non nuovo per i lettori italiani; nel 2008 Raffaello Cortina ha infatti pubblicato quello che è forse il suo libro più famoso e uno dei testi più notevoli e influenti in un certo settore degli studi sull’evoluzione, Dalla mano alla bocca. Le origini del linguaggio, traduzione di Salvatore Romano (From Hand to Mouth, The Origins of Language, Princeton U.P. 2002). La tesi di fondo di The Wandering Mind è che l’oscillare della mente fra concentrazione e distensione, di solito deplorata come semplice segno di pigrizia e svogliatezza, affonda le sue radici in una disposizione biologica, la quale presenta anche aspetti costruttivi e adattativi. Se l’attenzione è discontinua, e di norma intervallata da più o meno lunghe pause di rilassamento, non è soltanto per esigenze di riposo: nel concedersi spazi di ristoro e di svago, nel distaccarsi dalla contingenza la mente esercita anche altre facoltà, con esiti vantaggiosi per la nostra specie.
La trattazione muove da uno sguardo panoramico sulla memoria. La memoria è infatti il repertorio dei materiali sui quali si esercita il mind-wandering, rielaborando, rimuginando, ricombinando le tracce delle percezioni esperite. In sostanza, la memoria comprende tre livelli: le capacità acquisite e assimilate (skills), come parlare, camminare, scrivere, andare in bicicletta; le conoscenze (knowledge), che consistono nell’insieme delle cognizioni sul mondo possedute, svincolate dalle circostanze di apprendimento (idea non lontana dal concetto semiotico di «enciclopedia»); e infine la memoria episodica (episodic memory), ossia la memoria comunemente intesa, la riattivazione dinamica del passato. Le ricerche sul funzionamento della memoria, come di norma accade, sono alimentate dallo studio di lesioni, patologie, anomalie. Noto è il caso di Kim Peek, detto Kim-Puter, ispiratore del film Rain Man (per il quale il protagonista Dustin Hoffman e il regista Barry Levinson vinsero l’Oscar nel 1989); ancor più straordinario è quello di Lu Chao, che nel 2006 è riuscito a recitare i decimali di π fino alla posizione numero 67.890. Ma i riscontri più significativi riguardano la debolezza, la labilità, la malleabilità della memoria. Non solo i ricordi sono di norma incompleti e imprecisi, ma è molto facile indurre ricordi fittizi o fasulli. Il punto è che la memoria è rivolta molto più al futuro, che non al passato; e del resto le zone del cervello attivate dalla rimemorazione di eventi passati corrispondono largamente a quelle attivate dall’immaginazione di eventi futuri («the brain hardly knows the difference »).
Tre sono anche i principali ambiti della mente girovaga, ossia gli spazi dell’attività cerebrale non focalizzata: il vagabondaggio mentale cosciente, il sogno, le allucinazioni (fomentate o no da sostanze stupefacenti). Su ciascuna di tali dimensioni ci si potrebbe soffermare, cominciando dalla considerazione che durante la veglia il confine tra mind-wandering e paying attention non è assoluto. Sorprende tuttavia l’esiguità della differenza, in termini sia di attività cerebrale sia di afflusso di sangue (tra il 5 e il 10%). Se paragoniamo il cervello a una città, nelle fasi di ozio non è che le strade siano deserte: semplicemente, gli abitanti attendono ai casi propri, salvo confluire in un medesimo luogo quando accade un evento importante. A un profano risultano poi strabilianti le indagini sull’attività onirica, uno dei tanti orizzonti aperti dallo sviluppo della diagnostica per immagini. In particolare, la fMRI cerebrale (la risonanza magnetica funzionale), consentendo di localizzare le aree del cervello attivate da questo o quel comportamento, dischiudono inedite prospettive sulla possibilità di intuire non solo che cosa sogniamo noi, ma perfino cosa sognano gli animali.
Che cosa accade dunque quando la mente vaga? O meglio: quali sono le forme di divagazione mentale che possono essere risultate utili dal punto di vista evolutivo? Un primo fenomeno consiste nel viaggio mentale nel tempo (mental time travel). Questa disposizione comprende e combina la capacità di rievocare eventi passati e quella di costruire possibili scenari futuri, sganciandosi dal presente – sia dalla situazione di fatto, sia dalle presenti condizioni della coscienza. Anni fa, in un articolo firmato insieme a Thomas Suddendorf (Mental time travel and the evolution of the human mind, 1997), Corballis aveva ipotizzato che tale fenomeno costituisse la principale differenza tra umani e altre specie. In questo libro è alquanto più cauto; richiama più volte una celebre affermazione del Darwin dell’Origine delle specie («per quanto grande, la differenza che passa tra la mente dell’uomo e quella degli animali superiori è certamente di grado non di qualità»), e si guarda da conclusioni affrettate. La storia della psicologia è piena di esempi di funzioni cognitive considerate dapprima un’esclusiva di Homo sapiens, e poi riscontrate in altri animali.
Quello della «discontinuità» è davvero un tema topico nelle scienze cognitive: qualcosa a metà fra il tormentone e il passaggio obbligato. Ciò vale anche nella prospettiva delle ricerche sull’origine del linguaggio; per inciso, ricordo che è appena uscito un nuovo contributo del massimo studioso italiano dell’argomento, Francesco Ferretti (La facoltà di linguaggio. Determinanti biologiche e variabilità culturali, Carocci 2015). La posizione di Suddendorf (The Gap. The Science of What Separate Us from Other Animals, New York, Basic Books 2013) sembra oggi un po’ diversa da quella di Corballis. Fatto sta che il viaggio mentale nel tempo mette in gioco opzioni alternative, consente di valutare le conseguenze possibili: e così facendo produce flessibilità, attitudine preziosa per una specie che si trovi a doversi misurare con ambienti differenti, contesti mutevoli, sfide inattese.
Un altro tema cruciale è quello della cosiddetta «teoria della mente» (theory of mind), come viene chiamata l’attitudine a rappresentarsi gli stati mentali altrui. Si tratta di una capacità non solo metacognitiva (ovviamente), ma ricorsiva (ad esempio: «Io credo che tu credi che io credo a Babbo Natale»). Benché non sia difficile indicare eccezioni, il nostro interagire con il prossimo è regolato molto più da quello che supponiamo gli altri abbiano in testa, cioè dalla loro «postura intenzionale», che non dai loro attributi fisici. L’incapacità di comportarsi in questo modo, ossia la cecità relazionale (mind-blindness) è la forma di patologia che chiamiamo autismo. Anche qui Corballis dà conto delle indagini compiute su soggetti non umani, in particolare sugli scimpanzé, e riporta una conclusione di Josep Call and Michael Tomasello: «trent’anni di ricerche dimostrano che gli scimpanzé hanno comprensione degli obiettivi, delle percezioni, della conoscenza di altri individui, ma non delle loro credenze e dei loro desideri». I più abili a leggere nella mente parrebbero però i cani, circostanza evidentemente legata all’antichissima domesticazione. Può essere questo il discrimine fra Homo sapiens e gli altri animali? Certo è che sviluppare la disposizione a mettersi nei panni altrui aumenta le possibilità di comprensione reciproca, e quindi di empatia e di intesa sociale, con evidenti vantaggi per la sopravvivenza del gruppo. Quando la mente nel suo divagare si interroga sui pensieri altrui, non è affatto in ozio: sta esercitando, sia pure a basso regime, una facoltà essenziale.
Uno degli aspetti su cui Corballis più insiste è il legame fra la dimensione mentale e quella corporea. È probabile che il vagare della mente sia geneticamente connesso all’esperienza dello spostamento fisico; e verosimile è altresì che proprio l’esperienza di luoghi e territori differenziati sia connessa alla propensione della mente a vagare, in un incontrollato ma alacre andirivieni tra rievocazioni, anticipazioni, simulazioni, ipotesi. Ecco la chiave della questione: svincolandosi dal qui-e-ora la mente acquisisce dimestichezza con le evenienze possibili e si prepara ad affrontare pericoli e imprevisti. Non a caso, la maggior parte dei sogni (da ⅔ a ¾, secondo lo psicologo finlandese Antti Revonsuo) rappresentano simulazioni di eventi minacciosi: aggressioni, fallimenti, incidenti, sventure. La vita dei nostri progenitori del Pleistocene era rischiosa: occorreva guardarsi dai predatori, procurarsi cibo esponeva a mille pericoli, ci si muoveva spesso su terreni sconosciuti; inoltre (possiamo aggiungere) l’interazione sociale era sempre più indispensabile e sempre più impegnativa. Sognare situazioni di pericolo, argomenta Corballis, può essere stata quindi una forma di adattamento per sviluppare adeguate strategie di risposta. Del resto, se il mind-wandering spontaneo – si tratti del libero vagare della mente vigile o di attività mentali involontarie – è caratterizzato dallo sganciamento dalla situazione presente e da un’assidua rielaborazione e manipolazione dei dati empirici, da un’ininterrotta opera di rimaneggiamento e rimuginìo che vaglia, scompagina, rimescola, emulsiona, ebbene, appare evidente che il vagabondaggio della mente è la sorgente della creatività. A cominciare dalle narrazioni.
«The wandering mind is the source of fiction» leggiamo a p. 2; e alle storie è dedicato un intero capitolo (il sesto, su nove). Raccontando, il vagabondaggio mentale diviene oggetto di condivisione. Possiamo dire, con una terminologia diversa, che si passa dalla fantasticheria privata a un esercizio sociale dell’immaginazione. È il piacere di girovagare nella mente altrui che ci induce a creare personaggi d’invenzione, apposta per questo scopo; ed è il piacere di spostarsi nel tempo che ci porta a inventare trame. La narrazione è geneticamente connessa al gioco: a questo proposito Corballis cita un testo di Brian Boyd (On the Origin of Stories, Harvard U.P. 2009) che è una delle pietre miliari del cosiddetto «darwinismo letterario» (Darwin literary studies), e che sarebbe davvero meritorio pubblicare anche in Italia. Ma in termini psicologici il riferimento più immediato è l’inclinazione dei bambini, specie in età prescolare, a inventarsi compagni di gioco immaginari, amici e confidenti invisibili. «Insieme alla capacità di viaggiare mentalmente nel tempo, viaggiare mentalmente nelle menti altrui costituisce la piattaforma di una caratteristica che sembra davvero essere una peculiarità umana universale: raccontare storie».
Chi ha avuto la pazienza di arrivare fin qui avrà ora chiaro per quale motivo uno studioso di letteratura può essere motivato a occuparsi di queste faccende. A parte, s’intende, il piacere di imparare che l’ippocampo è il centro della coscienza temporale e della localizzazione spaziale, che le fasi di sonno REM svolgono una funzione di regolazione delle emozioni, e le fasi non-REM di consolidamento della memoria; o, ancor più, la curiosità di sapere se è lecito parlare di mental time travel anche per gli uccelli che (come la nocciolaia) nascondono le provviste, o per lo scontroso scimpanzé Santino, che nello zoo svedese di Furuvik, durante le ore di chiusura, mette da parte pietre per tirarle poi ai visitatori. In questa luce, dicevo, anche l’attività di narrare non può che essere una forma di adattamento: i nostri remoti progenitori sono letteralmente diventati umani narrando, cioè usando il linguaggio per riferire, condividere, tesaurizzare esperienze (reali o immaginarie, poco importa) ritenute rilevanti per le sorti del gruppo. Ma c’è un ultimo tema di questo libro su cui mi vorrei brevemente soffermare, cioè il contributo della mente girovaga alla creatività. L’essenza della creatività, sostiene Corballis, consiste in un processo in due tempi: accumulo di variazioni casuali e ritenzione selettiva: blind variation, selective retention (e non sfuggirà che si tratta dello stesso meccanismo dell’evoluzione naturale). In altre parole, la scintilla della creatività scocca sulla base di un girovagare mentale casuale, che istituisce relazioni fra le cose diverse da quelle date: finché, provando e riprovando, ci si imbatte in una combinazione inedita utile. Certo, occorre riconoscerla. Come si diceva prima, è proprio dell’attività mentale alternare la fase del vagabondaggio senza meta apparente e quella dell’attenzione mirata.
Sulla base di questo medesimo argomento, cinquant’anni or sono Calvino accoglieva con provocatorio favore l’ipotesi di usare i calcolatori elettronici come macchine per narrare. Il saggio Cibernetica e fantasmi (1967) – per più versi la chiave di volta della raccolta Una pietra sopra – discorre appunto della narrativa come processo combinatorio, richiamandosi fra l’altro al saggio di Ernst Gombrich Freud e la psicologia dell’arte: «è il piacere infantile del gioco combinatorio che spinge il pittore a sperimentare disposizioni di linee e colori e il poeta a sperimentare accostamenti di parole: e a un certo punto scatta il dispositivo per cui una delle combinazioni ottenute seguendo il loro meccanismo autonomo, indipendentemente da ogni ricerca di significato o effetto su un altro piano, si carica di un significato inatteso o d’un effetto imprevisto, cui la coscienza non sarebbe arrivata intenzionalmente».
Per concludere, confesserò che dalla lettura di The Wandering Mind penso di cavare anche un piccolo ma non insignificante consiglio pratico. Quello che le nuove tecnologie e gli odierni mezzi di comunicazione producono, in termini di rischio, non è un eccesso di distrazione ma, al contrario, un eccesso di focalizzazione. La possibilità di concentrarci di volta in volta su tanti oggetti differenti, grazie allo smartphone o al tablet o al computer che abbiamo sempre inesorabilmente a portata di mano (a tacere di tv, radio, iPod), ci preclude la possibilità di distrarci davvero. Abbiamo una mente che per natura è girovaga: perché funzioni al meglio, dobbiamo consentirle di girovagare. Camminando, magari, e abbandonandoci – come Jean-Jacques – alle rêveries. Insomma: non guardiamo troppo il nostro cervello. Sta lavorando per noi.
Il libro: Michael C. Corballis, The Wandering Mind, What the Brain Does When You’re Not Looking, The University of Chicago Press, 2015, pp. 148, $ 20,00