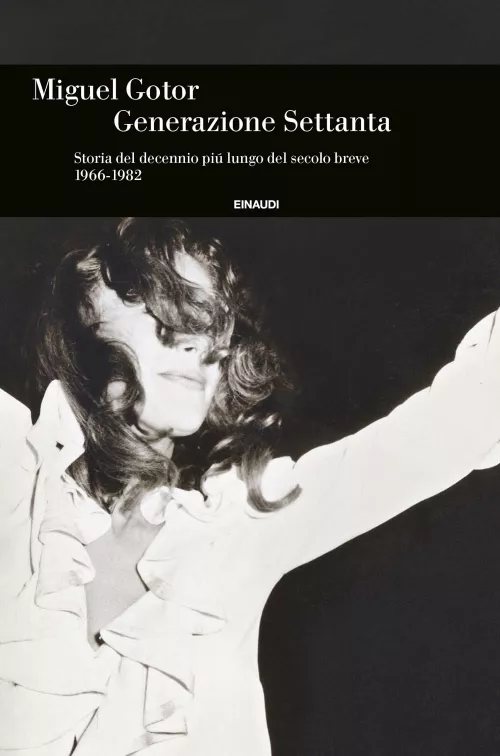Generazione Settanta: dagli angeli del fango alla P38
Il Ventesimo secolo, rispetto ai secoli che lo hanno preceduto, ha avuto una peculiarità assoluta: tutte le terre del pianeta sono state esplorate, tutti i paesi e i continenti sono stati mappati, ogni lembo terrestre, ogni tratto di mare, ogni isola, fino alla più remota, sono stati assoggettati a una nazione; l’uomo che lo ha vissuto si è trovato a far parte di un mondo, come lo ha definito Stefan Zweig, “senza misteri”. Se tuttavia osserviamo il Novecento attraverso la lente italiana, ci accorgiamo che esiste un secolo dentro al secolo. In quel mondo svelato compare una voragine, al contrario, fitta di misteri. Misteri che non riguardano le esplorazioni geografiche di luoghi ignoti, bensì i fatti che ne hanno modellato la Storia. Quel secolo nel secolo è rappresentato dagli anni Settanta.
Ma che cos’è un decennio? E perché siamo abituati a suddividere il tempo di cent’anni in dieci comode rate, convinti che dopo il nove si riparta sempre daccapo, che all’improvviso cambino le mode, i generi musicali dominanti, gli stili culturali, che si scavino solchi tra le nuove e le precedenti generazioni? Un decennio è una pura approssimazione storica. Miguel Gotor, tra i maggiori studiosi italiani degli anni Settanta, nel suo nuovo lavoro, da poco uscito per Einaudi Storia, fin dal titolo – Generazione Settanta. Storia del decennio più lungo del secolo breve (1966-1982) – ci mette in guardia da certi schematismi.
Alla celebre definizione coniata da Eric Hobsbawm per descrivere in due parole il Novecento, Gotor contrappone il “decennio più lungo”, indicandone l’inizio (l’alluvione di Firenze del 1966) e la fine (la vittoria dell’Italia ai mondiali di calcio spagnoli del 1982). Perché compito dello storico non è solo analizzare i grandi fenomeni, ma rintracciarne gli inneschi e le ultime propaggini. La prima ribalta in cui emerge una nuova volontà di protagonismo giovanile dunque non è il ’68, come sarebbe facile pensare. È a Firenze che si mostra per la prima volta la “generazione Settanta”. È nella città sommersa in cui accorsero da tutta Italia gli “angeli del fango”, come furono chiamati i giovani volontari che liberarono le strade dalle acque dell’Arno. Ed è con una maglia azzurra, la numero venti, che questa storia finisce: quella indossata da Paolo Rossi, il calciatore riabilitato dall’onta del calcio scommesse che con sei gol riscatta se stesso e un’intera nazione sfiancata da anni di conflitti e di sangue.
Individuati i confini temporali, bisogna scorgere il filo che li attraversa e che li annoda, il continuum. Dove si cela questo filo? Nella rabbia sociale? Nell’uso ampio e sistematico della violenza? Nella fame di progresso che si scontra con le pulsioni più retrive e oscure? Nella gioventù stessa che per la prima volta si prende il proscenio della Storia? Nella politica che dilaga in ogni settore della vita pubblica – piazze, scuole, luoghi di lavoro – e a cui nessuno, neanche volendo, può sottrarsi? A leggere le pagine di questo libro si ha l’impressione che sia un po’ in tutto questo, e che forse non c’è un solo filo, ma una solida intrecciatura che finisce per comporre un tessuto di un colore e di una trama inconfondibili.
 Gotor individua nella trasformazione dell’università l’humus in cui attecchisce una nuova consapevolezza, e da cui proviene questa generazione critica, contestataria e rivoluzionaria. Ancora negli anni Cinquanta gli atenei erano luoghi di formazione riservati alle élite. La loro conversione in istituzioni di massa era avvenuta senza un rinnovo dei metodi d’insegnamento. Il divario tra le esigenze di una nuova classe di studenti e l’antica rigidità dell’offerta didattica è il detonatore che spinge verso il terreno della protesta. Una reazione che si allarga presto al mondo del lavoro, alle fabbriche soprattutto, e che ha il suo apice in una data precisa, il 12 dicembre 1969, quando il Senato approva in prima lettura lo Statuto dei lavoratori, momento culminante del cosiddetto “autunno caldo” delle “tute blu”, e nel pomeriggio, a Milano, in piazza Fontana, presso la Banca Nazionale dell’Agricoltura, una bomba esplode uccidendo diciassette persone e ferendone ottantotto. Quell’attentato, considerata la madre di tutte le stragi, “diede inizio – scrive Gotor – a una scia di sangue e di morte senza precedenti e senza confronti nella storia democratica dell’Occidente”.
Gotor individua nella trasformazione dell’università l’humus in cui attecchisce una nuova consapevolezza, e da cui proviene questa generazione critica, contestataria e rivoluzionaria. Ancora negli anni Cinquanta gli atenei erano luoghi di formazione riservati alle élite. La loro conversione in istituzioni di massa era avvenuta senza un rinnovo dei metodi d’insegnamento. Il divario tra le esigenze di una nuova classe di studenti e l’antica rigidità dell’offerta didattica è il detonatore che spinge verso il terreno della protesta. Una reazione che si allarga presto al mondo del lavoro, alle fabbriche soprattutto, e che ha il suo apice in una data precisa, il 12 dicembre 1969, quando il Senato approva in prima lettura lo Statuto dei lavoratori, momento culminante del cosiddetto “autunno caldo” delle “tute blu”, e nel pomeriggio, a Milano, in piazza Fontana, presso la Banca Nazionale dell’Agricoltura, una bomba esplode uccidendo diciassette persone e ferendone ottantotto. Quell’attentato, considerata la madre di tutte le stragi, “diede inizio – scrive Gotor – a una scia di sangue e di morte senza precedenti e senza confronti nella storia democratica dell’Occidente”.
È in quella scia di sangue e di morte che si inabissa il libro, percorrendola tutta senza tralasciarne alcuna sfumatura, avendo sempre come stella polare il metodo storico, seguendo le tracce apparentemente secondarie accanto ai grandi fattori collettivi, con la consapevolezza che la Storia va interpretata nel modo più oggettivo possibile.
Ma la Storia, oltre che interpretarla, bisogna saperla raccontare. E non tutti gli storici maneggiano l’arte dell’affabulazione. Questa qualità – come si era già apprezzato nei lavori precedenti, fra i quali va segnalato senz’altro Il memoriale della Repubblica sugli scritti di Aldo Moro dalla prigionia, uscito anch’esso per Einaudi nel 2011 – Miguel Gotor la possiede. Non ci si potrebbe altrimenti imbattere in una pagina, come la 86, in cui lo storico immagina Giulio Andreotti la sera del 26 giugno del 1972, al culmine della sua ascesa politica, affacciato in vestaglia da camera alle finestre del suo appartamento “da cui con un solo colpo d’occhio si potevano abbracciare la cupola di San Pietro illuminata, il lungo filare di luci di via della Conciliazione e la maestosità di Castel Sant’Angelo”, e da cui “Roma e l’Italia intera, finalmente brulicanti ai suoi piedi, dovettero apparirgli di struggente, feroce, ingovernabile bellezza”, concludendo con un’allusione al padre morto di febbre spagnola quando il piccolo Giulio aveva appena due anni: “chissà se pensò che suo padre, di cui non aveva fatto in tempo a serbare il ricordo di una sola carezza, sarebbe stato fiero di lui”.
Ampie e documentate sono poi le parti che riguardano il racconto della strategia della tensione, nelle quali si mette in evidenza come il fenomeno abbia trovato qui da noi terreno fertile per via della naturale propensione degli italiani a quella che oggi definiremmo “polarizzazione”, ossia all’integralismo delle posizioni osteggianti e a una certa connaturata disposizione ad assoggettarsi allo straniero per vincere il nemico interno.
Così come, imprescindibile, il racconto della nascita e dell’ascesa delle Brigate Rosse, l’operazione Moro che rappresenta il culmine della loro azione, il successivo sfaldamento e la definitiva sconfitta. E ancora, i “cadaveri eccellenti” di Pecorelli e Ambrosoli, il ritorno dello stragismo nell’estate del 1980 con Ustica e la bomba alla stazione di Bologna. Fino agli anni del “riflusso”, o come si diceva allora del “trionfo del privato”, del rampantismo e dell’edonismo che caratterizzeranno gli anni Ottanta, anni dominati dalla pubblicità e dai “colonizzatori dell’immaginario collettivo”, il brodo culturale nel quale iniziò a fermentare il nuovo potere politico che si affermerà pienamente solo un decennio più tardi sulle macerie fumanti della prima Repubblica.