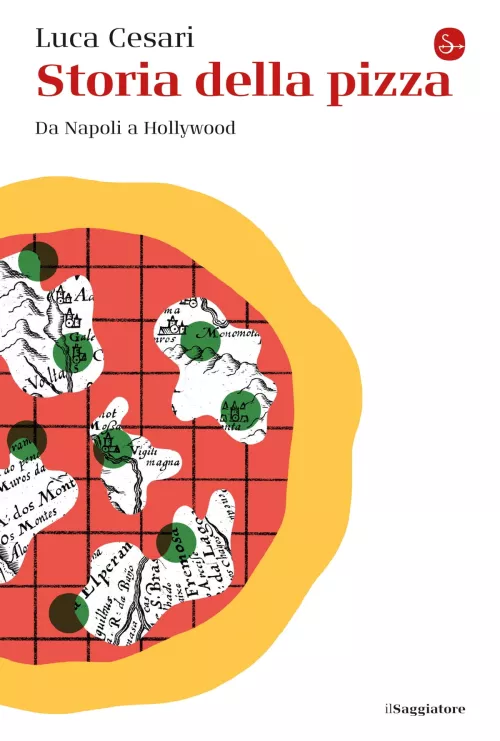La doppia invenzione della pizza
In tempi di conclamata identità nazionale, una storia della pizza ha valore politico. Basta prendere le cose con calcolata leggerezza: piuttosto che litigare sulla presunta identità italiana, fra chi la rivendica in purezza e chi la scioglie in un coagulo di differenze (onde poi servirsene, entrambi, per scopi di prestigio se non di potere), proviamo a vedere se e come questa specialità gastronomica planetaria abbia vissuto uno strano ping pong fra le due sponde dell’Atlantico, un via vai continuo che l’ha fatta diventare, poco a poco, il cibo che più sprizza identità, tradizione, gusto locale. Rimbalzando fra Napoli e New York, l’Italia e gli Stati Uniti, l’Europa e il resto del mondo, tutti la vogliono, tutti la cercano, e tutti pensano che sia roba loro (come dire, invertendo il punto di vista, cosa nostra).
In breve: la pizza vanta origini italiane, anzi napoletane. E le leggende in proposito non mancano, dalle dicerie del rione Sanità al teatro popolare, passando per la smorfia, De Filippo, Totò, De Sica e soci. Ma la pizza deve il suo successo mondiale soprattutto agli Stati Uniti, che l’hanno adottata poco dopo la sua nascita, grazie al massiccio arrivo di italoamericani oltreatlantico, impossessandosene e rilanciandola globalmente. Come dice Luca Cesari nella sua recente Storia della pizza (Il Saggiatore, pp. 348, € 19), la schiacciata più semplice e più famosa del mondo è stata inventata due volte: la prima nella città partenopea, sembra per ragioni di sussistenza fra le classi più disagiate, cibo poverissimo e, spesso, non gradevole; la seconda nella metropoli newyorkese, che, ripensandola come propria, ne ha decretato il successo e la fortuna.
Problema: cosa vale per definire una identità? la nascita o l’adozione? l’origine o il processo della sua diffusione? la genesi o gli esiti? Problema giuridico, si dirà, ma anche storico, etnoantropologico sicuramente e, appunto, politico. Quando l’identità, qualunque cosa essa sia, diviene strumento di affermazione di una consorteria politica o, che è lo stesso, di critica di tale fazione, ecco che stabilirne il senso e il valore, come anche i dispositivi formali che la pongono in essere, diviene istanza legata alla res pubblica, più pubblica che res, potremo dire.
Torniamo allora alla pizza. Leggendo il bel libro di Luca Cesari, già autore di una fortunata Storia della pasta in dieci piatti (ipertradotto e iperpremiato) viene fuori con chiarezza, grazie a una paziente raccolta di testimonianze più disparate (dai ricettari alla stampa d’epoca, dai resoconti dei viaggiatori settecenteschi al teatro di strada e al cinema d’autore), le cose si intrecciano e al tempo stesso si distendono. Basta rifletterci: se New York reinventa la pizza dichiarandola cibo tipicamente americano, è perché è zeppa di emigrati italiani che a un certo punto, fra gli anni Venti e Trenta del Novecento, sfiorano l’ottanta per cento della popolazione cittadina. Costoro, a differenza di altre etnie presenti nella Grande Mela, tengono molto a conservare le proprie tradizioni d’appartenenza, venerano l’istituzione famigliare e, dunque, pretendono di mangiare quel che mangiavano nel loro paese – o, meglio, quel che si raccontava si mangiasse, da sempre, nel loro paese.

La pizza, insomma, è emigrata negli USA, povera fra i poveri, appagata nell’aver fatto fortuna in America. Ha trovato l’America. Anche e soprattutto grazie a una passione, la nostalgia, e a una macchinetta potentissima, la narrazione. Gli emigrati veneti o liguri, per esser chiari, la pizza non l’avevano mai mangiata, né loro né tanto meno i loro genitori o nonni. Sbarcati a Ellis Island, avevano sentito dire che si trattava d’un cibo italiano, e si son messi lì, con orgogliosa abnegazione, a infornare pane schiacciato, pomodoro e formaggio a più non posso. Felici di conservare delle supposte radici che vere e proprie radici non erano (rizoma?).
La cosa interessante è che questa reinvenzione, come ricostruisce attentamente Cesari, è l’esito di una accurata operazione di selezione. Innanzitutto, fra le mille varianti napoletane della pizza (spesso anche dolci), si elesse a pizza per antonomasia quella con pomodoro e mozzarella, e cioè la cosiddetta margherita (sembra per via della regina Margherita, che amava assaggiare le pietanze popolari: scatenando ulteriori leggende in merito). A partire da questa specie di prodotto base, la creatività non ha avuto limiti, secondo il principio tutto americano per cui nothing is impossible. E lì peperoni come se piovesse, ma anche il famigerato ananas. Si diffuse inoltre l’idea stessa di pizzeria come luogo fisico dove incontrarsi per mangiare bene e a poco prezzo. Nacque così il mito della pizza, mito nel senso tecnico di meccanismo che risolve un altro livello (quello del cibo, in questo caso) le opposizioni presenti nella società (ricchi/poveri, gusto/disgusto, Europa/America…).
La storia, ovviamente, continua. Grazie all’affermarsi progressivo della cosiddetta dieta mediterranea, che valorizza i cereali rispetto ai grassi, la pizza torna spocchiosa da questo lato dell’oceano, e diviene il simbolo militante della guerra alle proteine. Non solo cibo economico e saporito, ma anche salutare. Il gioco è fatto: l’arte del pizzaiolo dal 2017 è stata iscritta dall’Unesco a esponente del patrimonio immateriale dell’umanità. Chapeau.
Questa storia ha una morale che dovrebbe esser nota ma non fa male riprendere: inventare una tradizione non significa ingannare, creare dal nulla una cosa che nel passato non c’era; significa semmai reimbastire alcuni dati, ridistribuirli e reimpacchettarli per far emergere un potenziale al tempo stesso vecchio e nuovo, per scopi strategici, obiettivi ideali, gusti, valori che, stando al gioco, possono vincere come perdere. L’invenzione della tradizione, in questo senso, non è una specie di reato di lesa maestà delle tradizioni vere, genuine, originarie. Come non è forse abbastanza chiaro (diciamolo!) nel noto libro di Hobsbawm e Ranger che ha forgiato questa espressione, inventare la tradizione non significa mentire ma produrre linee genealogiche, costruire nuovi valori, compiere delle precise mosse nell’arena sociale e nella sfera culturale. Dal nostro punto di vista non si tratta dunque di smentire, di smitizzare, di ritrovare verità vere, origini autentiche, ma di ricostruire stratificazioni antropologiche, indicare fatalità storiche. Potremmo forse liberarci, allora, del mito delle identità dure e pure, ma anche con le demistificazioni tanto ostinate quanto inutili. Pensiamoci quando andiamo a votare. La pizza ci guarda, e se la ride.