L’eccesso e la gloria: Il Passeggero di McCarthy
Gli explicit dei romanzi di Cormac McCarthy sono tutti incipit. Prendono una rincorsa vertiginosa e lasciano il lettore sulla faglia di un mondo in formazione. Il passeggero non fa eccezione, anzi, ha uno dei finali più belli e potenti di McCarthy, uno di quelli che solo a pensarci ti torna la pelle d’oca e senti di trovarti di fronte a un gigante senza tempo della letteratura. I libri importanti, però, non si sentono e basta, devono generare quell’improbabile equilibrio di testa, cuore e pancia che ti fa dimenticare tutto il resto, ad esempio la cronaca culturale o il mondo del libro, luoghi in cui i McCarthy sono pietre d’inciampo, sassate di realtà poetica, filosofica, antropologica che ci mostrano che il re è nudo, e che la sua nudità non è per nulla regale. Ma il finale di Il Passeggero, oltre a essere un incipit che agisce come uno schiaffo, è anche un prisma semiotico e narratologico che ci dice qualcosa sull’intero romanzo e sulla sua relazione con quello che l’ha preceduto, La strada. I due explicit, infatti, sono così simmetrici da suggerire un’intratestualità consapevole, un gioco di rimandi reciproci nel fluido atemporale dell’opera dell’autore:
Una volta nei torrenti di montagna c’erano i salmerini. Li potevi vedere fermi nell’acqua ambrata con la punta bianca delle pinne che ondeggiava piano nella corrente. Li prendevi in mano e odoravano di muschio. Erano lucenti e forti e si torcevano su sé stessi. Sul dorso avevano dei disegni a vermicelli che erano mappe del mondo in divenire. Mappe e labirinti. Di una cosa che non si poteva rimettere a posto. Che non si poteva riaggiustare. Nelle forre dove vivevano ogni cosa era più antica dell’uomo, e vibrava di mistero. (La strada, traduzione di Martina Testa, Einaudi 2007, pp. 217-218)
La tempesta passò e il mare scuro si stendeva freddo e greve. Nelle gelide acque metalliche le sagome ribattute di enormi pesci. Nei flutti il riverbero di un bolide liquefatto che avanza nel firmamento come un treno in fiamme.
Si chinò sulla sua grammatica alla luce della lampada. Con il tetto di paglia che sibilava nella campana di tenebre sopra di lui e la sua ombra sulla superficie grezza del muro. Come quegli studiosi dei tempi andati che sgobbavano sui loro rotoli nelle loro fredde stanze di pietra. I paralumi delle lampade fatti di gusci di tartaruga bolliti e raschiati e forgiati in un torchio e le geografie casuali che proiettavano sui muri della torre paesi ignoti agli uomini così come ai loro dèi.
Alla fine si sporse e raccolse le mani intorno al cilindro di vetro e soffiò sulla fiamma e si stese nel buio. Sapeva che quando sarebbe morto avrebbe visto il suo volto e sperava di portare con sé quella bellezza nelle tenebre, ultimo pagano sulla terra, cantando piano sul suo giaciglio in una lingua sconosciuta. (Il passeggero, traduzione di Maurizia Balmelli, Einaudi 2023, p. 385)
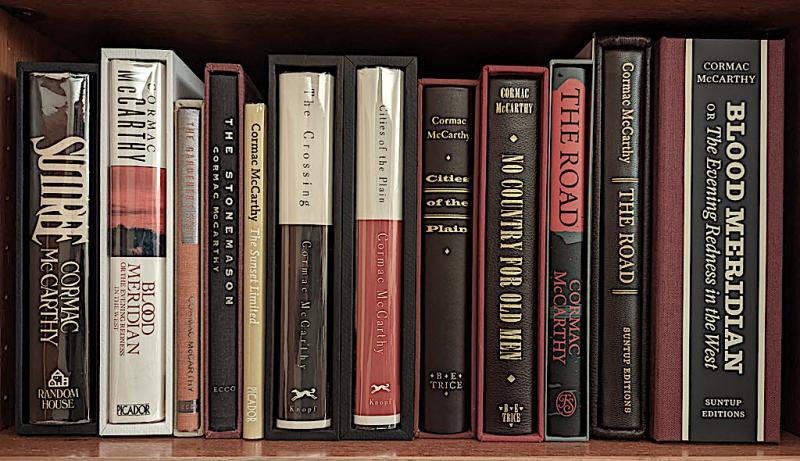
I salmerini e gli enormi pesci, le mappe del mondo in divenire e le geografie casuali di paesi ignoti, la vibrazione di mistero e la lingua sconosciuta, le cose più antiche dell’uomo e gli studiosi dei tempi andati. Ma anche il buio del mondo come resa, come abbandono finale. Queste le somiglianze. Poi le differenze: l’allungo prosodico, la falcata ampia che in Il Passeggero ha bisogno di molte più parole, il bolide liquefatto come emblema apocalittico, la grammatica che è la non-letteratura, i monaci, probabilmente irlandesi, e l’eremita americano che è McCarthy stesso, mentre spegne la luce e si congeda forse per sempre dalla scrittura. È così che possiamo iniziare a leggere questo romanzo, come continuazione di La strada e come sua detonazione.
Passiamo allora all’incipit vero e proprio, la scena del ritrovamento nella neve del corpo di Alice Western, una pagina che fa foreshadowing e trasforma il senso di colpa del protagonista in presagio tragico. Bobby Western, che nel finale spera di ritrovare nelle tenebre il sogno della sorella morta e chiudere il cerchio di una vita di mancanza, condurrà un’esistenza rovesciata, in cui la fine c’è già stata e il presente si è ridotto a una filiera estenuante di scene disarticolate, quelle che di fatto compongono il romanzo, intercalate dai deliri schizofrenico-paranoici di Alice. Proviamo a immaginare questa scena iniziale come se fosse generata nell’amnios di La strada:
Nella notte era scesa una leggera nevicata e i suoi capelli ghiacciati erano aurei e cristallini e i suoi occhi gelidi e duri come pietre. Uno degli stivali gialli le si era sfilato e spuntava dalla neve sotto di lei. La sagoma del cappotto impolverata di neve si disegnava dove l'aveva lasciato cadere e vestita solo di un abito bianco lei pendeva tra i nudi e grigi tronchi degli alberi invernali con il capo chino e le mani leggermente rivolte all'infuori come quelle di certe statue ecumeniche la cui postura chiede che ne venga contemplata la storia. Che vengano contemplate le fondamenta del mondo poiché originano dal travaglio delle sue creature. Il cacciatore si inginocchiò e conficcò il fucile accanto a sé nella neve e si sfilò i guanti e li lasciò cadere e giunse le mani l'una sull'altra. Pensò che avrebbe dovuto pregare ma preghiere per una cosa simile non ne aveva. Chinò la testa. Torre d'Avorio, disse. Oro del Tempio. Rimase li inginocchiato a lungo. (Il passeggero, p. 3)
Questo inizio lascia pochi dubbi sul posizionamento narratologico di McCarthy. Dal Bilderatlas del folklore europeo ecco emergere in filigrana una fiaba dei fratelli Grimm tra Biancaneve e la Bella addormentata nel bosco, un racconto celtico di Lady Gregory o di James Stephens, oppure Túrin Turambar e Niniel di Tolkien, Crimilde e Sigfrido dei Nibelunghi, Kullervo del Kalevala. Bobby Western, innamorato della sorella, maledetto dalla sua morte, antieroe ramingo, “ultimo pagano sulla terra”, è il personaggio epico di una saga precristiana piena di crepuscoli spenti, aurore boreali, abissi beowulfiani, geografie dell’esilio. Ma, dicevo, dobbiamo immaginare questa pagina come se fosse una scena spuria di La strada, uno scartafaccio rigettato dall’autore che però intercetta così un altro livello tragico, non quello edipico, ma quello del collasso. L’aurora boreale diventa concussione nucleare, il cacciatore è uno scavenger, Alice e le sue allucinazioni una coorte di zombie. Questi primi segnali diventano adesso segni, coordinate per entrare nel romanzo sia come macchina narrativa sia come emporio di simboli. E di questo ne parleremo per anni.

Per il momento si può dire che il sovraccarico di scene, luoghi, personaggi, le smagliature eccessive e sfrontate della trama, le scivolate quasi spocchiose nel barocco e nel kitsch, la sintassi per accumulo di coordinate non devono essere lette con il filtro di una presunta estetica letteraria o con quello banalmente rassicurante della senilità dell’autore. Sono La strada gettata in una centrifuga e cucinata da McCarthy come una specie di metanfetamina. Lo scopo è potenziare la carica allucinatoria e onirica della scrittura, e gli effetti più evidenti sono appunto le parti “nuove”, quelle in corsivo, dedicate alle visioni grottesche e disperate di Alice:
Le genealogie sono sempre interessanti. Volendo puoi ricondurre l'intera faccenda a qualche impronta nella pietra di una forra. Sei sul punto di appisolarti e si scatena l'inferno. Quando sbirci nello specchio questi vergangenheitvolk ti sbirciano di rimando. Loro se non altro non sono venuti in bus. Sarai felice di saperlo. Immagino. Dove sta la tua materia in queste storie? Anche i riflessi viaggiano alla velocità della luce? Il tuo amico Albert cosa ne pensa? Quando la luce colpisce la lastra di vetro e riparte nella direzione opposta non deve prima fermarsi del tutto? E così ogni cosa sembra dipendere dalla velocità della luce ma nessuno vuole parlare della velocità delle tenebre. Cosa c'è in un'ombra? Le ombre si spostano alla velocità della luce che le proietta? Che profondità raggiungono? Quanto a fondo puoi fissare il tuo calibro? Da qualche parte a margine hai scribacchiato che quando si perde una dimensione si rinuncia a ogni pretesa di realtà. Salvo per la matematica. Esiste una via dal tangibile al numerico che non sia ancora stata esplorata? (p. 113)
Spense l'abat-jour e nel buio della stanza dove la luce al mercurio incorniciava la finestra si sfilò jeans e felpa e calzini e si infilò nel letto e tirò su le coperte e rimase in ascolto. Lo senti avvicinarsi. Coccolenza, ascoltami, le sussurrò. Non saprai mai di cos'è fatto il mondo. L'unica cosa certa è che non è fatto di mondo. Quando ti accosti a certe descrizioni matematiche della realtà non puoi evitare di perdere quel che viene descritto. Qualunque indagine soppianta ciò che indaga. Un momento nel tempo è un evento, non un’eventualità. Il mondo si prenderà la tua vita. Ma soprattutto e in ultima istanza il mondo non sa che sei qui. Tu questa cosa credi di capirla. Ma non la capisci. Non intimamente. Se così fosse saresti atterrita. E non lo sei. Non ancora. E adesso, buonanotte. (p. 128)
Alice nel paese delle non-meraviglie parla con dei bianconigli focomelici, parla soprattutto di questioni in cui fisica quantistica e metafisica esistenzialista si fondono nel brusio infestante della lingua. Ma la lingua di chi? Alice è solo l’oggetto di una pulsione desiderante che scavalca gli steccati della morale. Il Kid, invece, che le sta davanti con le sue mani a pinna di foca, a metà tra Humpty Dumpty e il ragazzino col banjo in Deliverance di Boorman, è invece l’altro grande personaggio del romanzo, assieme a Bobby Western, in cui McCarthy auctor diventa McCarthy agens. Non a caso, quando si materializza dalla mente di Alice, è per stare seduto su una scrivania. Da lì le parla come Yorik, “a fellow of infinite jest, of most excellent fancy”, sboccato, sì, ma sempre sul pezzo per svolgere una funzione ermeneutica, come in un dialogo socratico o galileiano. E, un po’ alla volta, in questo alternare bar, barche, baracche, torri, terreni, spiagge e oceani con i tarocchi viventi partoriti dalla psiche malata di Alice, McCarthy scopre il “Bosone di Cormac”, che gli permette di occupare molti spazi quantici, o narrativi, nello stesso tempo.
L’effetto generale è quello di un romanzo deflagrato e glorioso. E sarebbe interessante farsi alcune domande sul come e sul perché un novantenne americano sia in grado di fare quello che un quarantenne italiano non oserebbe neanche immaginare, cioè un romanzo capace di intercettare per temi e forme il panico del post-Olocene. Sarebbe interessante non per definire per l’ennesima volta lo status quo della letteratura italiana, ma per capire il limite di annientamento di una cultura che si ostina a confondere Antropocene e cambiamento climatico, collasso cognitivo e disastro ecologico, crollo del tempo e futuro prossimo, realtà della narrazione e narrazione della realtà. Perché Il passeggero di McCarthy è proprio questo: il più grande romanzo dell’Antropocene mai scritto, il romanzo del collasso finale della materia e della mente, il romanzo che, ambientato negli anni Ottanta del Novecento, sposta la questione della Fine da domani a ieri, e il romanzo che erode tutta la realtà per incontrarla:
Alla fine, aveva detto, non ci sarà niente che non possa essere simulato. E sarà il superamento definitivo del privilegio. Questo è il mondo che verrà. Non un altro. L’unica variante sarà la sorpresa di fronte a quelle antiche forme marchiate a fuoco nel cemento.
Le età dell’uomo che corrono da tomba a tomba. Dei conti su una lastra di ardesia. Sangue, oscurità. Un residuo di bambini morti su una tavola. Le stratificazioni rocciose del mondo con le loro impronte fossili di forma e quantità illimitate. I petroglifi moderni di mio padre e la gente sulla strada nuda e urlante. (p. 385)









