L'argentino che volle farsi italiano / Wilcock, iconoclasta solitario
“Sarà esistito davvero?”: è questa la domanda che mi faccio sempre ogni volta che chiudo un suo libro. Sarà esistito veramente Juan Rodolfo Wilcock, o è soltanto un personaggio partorito dalla fantasia di qualcun altro? Prima ancora che uno scrittore (Adelphi, suo editore storico, sta pian piano ristampando in edizione economica tutte le sue opere), Wilcock è in effetti un gran personaggio letterario. Anche per questo non mi ha sorpreso più di tanto ritrovarlo fra le pagine del non-fiction novel di Sandra Petrignani Addio a Roma (Neri Pozza, 2012), indispensabile regesto di aneddoti sulla Roma delle Arti e delle Belle Lettere a cavallo del mezzo secolo.
Il “personaggio-Wilcock” possiede innegabilmente un suo pittoresco fascino, a cominciare dalla scelta di vivere nell'estrema periferia capitolina, in un fabbricato anonimo di via Demetriade, fra la Tuscolana e l'Appia Nuova: un appartamento che l'amico Elio Pecora definiva «barocco, pieno di libri, di polvere e peli di cane» e dove Sebastiano Vassalli ricordava d'aver preso anche le pulci («e non fu cosa facile debellarle»). Né passava inosservata la sua aria da dandy straccione, con gli abiti acquistati di seconda mano e un laccio da scarpe al posto della cravatta: «Un gioco di parole: fra callo e collo», come egli stesso spiegò a una perplessa Ginevra Bompiani.

Wilcock interpreta Caifa ne "Il Vangelo secondo Matteo" di Pier Paolo Pasolini, 1964.
E ancora: Wilcock, l'intellettuale dalla cultura cosmopolita (nato a Buenos Aires da padre inglese e madre svizzero-italiana); l'ingegnere con incorporata la vocazione alla scrittura (come vuole la tradizione: Musil, Gadda...); il giovane protetto della triade Borges-Ocampo-Bioy Casares; il poeta che, nonostante la promettente carriera letteraria in patria, abbandona l'Argentina a metà degli anni Cinquanta. Celebri le parole che rivolse, prima di imbarcarsi, all'amico scrittore Héctor Bianciotti: «Se non te ne vai subito da questo Paese sei perduto per sempre. C'è una nave che parte per l'Italia tra venticinque giorni, non è cara. Io la prenderò».
Anche se quello di Wilcock si sarebbe ben presto rivelato un esilio nell'esilio (persino la cittadinanza gli venne concessa postuma), lui fece comunque della lingua italiana la propria patria letteraria, lasciando memorabili versioni di scrittori anglofoni – autori tutt'altro che agevoli, dall'amatissimo Joyce (pagine scelte dal Finnegans Wake, recentemente raccolte dal wilcockiano Edoardo Camurri e pubblicate da Giometti & Antonello), a Flann O'Brien (Una pinta d'inchiostro irlandese).
Importanti le sue incursioni nella pubblicistica: Il punto, Il Mondo, La voce repubblicana, L'espresso. Su Il punto teneva una rubrica dal titolo sfacciatamente borgesiano (“La biblioteca di Babele”), in cui, al posto dei libri da leggere, (s)consigliava quelli “da non leggere”. Inutile precisare che si trattava perlopiù di titoli inesistenti. Qualcosa di analogo fece su Il Mondo di Mario Pannunzio, ove tra l'altro già pubblicava velenossissimi elzeviri sulla società letteraria degli anni Sessanta. Secondo Roberto Calasso, Wilcock sostituì per un certo periodo Nicola Chiaromonte come critico teatrale. Ma, poiché «andare a teatro lo annoiava profondamente», s'inventava di sana pianta gli spettacoli da recensire. Particolarmente apprezzate erano le regie del catalano Llorenz Riber, che era arrivato a mettere in scena le Ricerche filosofiche di Wittgenstein e che finì divorato da un leone nei pressi di Fort Lamy, nel Ciad, in circostanze che l'autore tiene a definire «ancora oscure».
Questa di Riber è una delle trentasei "voci" biografiche de La sinagoga degli iconoclasti, che Wilcock pubblica nel 1972 per Adelphi. Intervistato dalla Rai qualche tempo dopo l'uscita del libro, egli lo descrive come «una collezione di scienziati fasulli... Li ho presi abbastanza sul serio, non ho preso in giro nessuno. Tutte le teorie si possono perdonare. Se legge una storia della scienza, vedrà che tutti i più grandi filosofi hanno proposto teorie che stanno più o meno sull'orlo del ridicolo...».
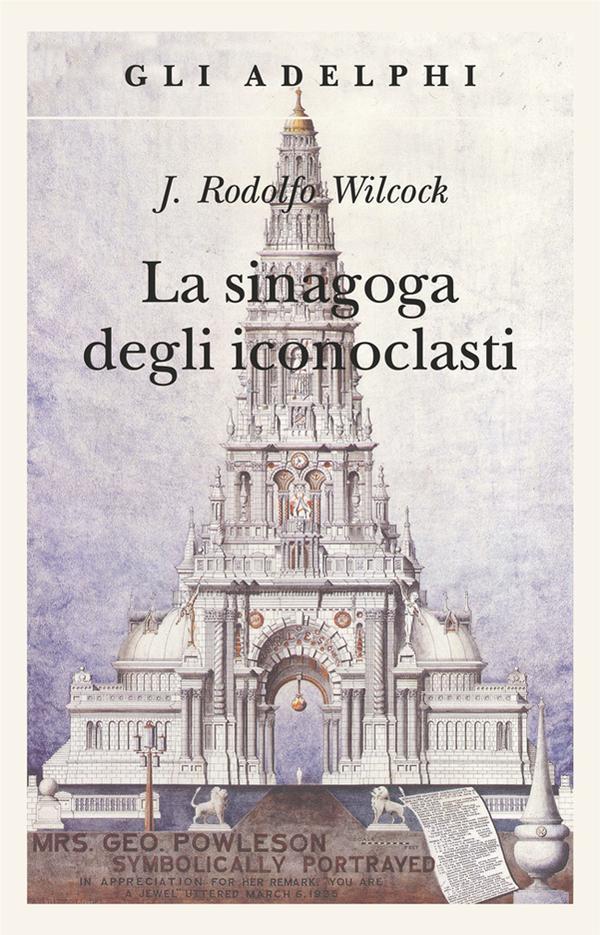
Libro amatissimo da Roberto Bolaño, che a quanto pare vi ricavò lo spunto iniziale per il suo La letteratura nazista in America, più che nel solco delle Finzioni di Borges (riferimento tanto ingombrante quanto ovvio), La sinagoga sembra volersi collocare a modo suo in quello delle Vite immaginarie narrate da Marcel Schwob: brevi biografie tracciate con l'impassibile rigore filologico del compilatore di epitomi. Uno stile che, in questo caso, contribuisce ad acuire la sensazione di vertigine: pagina dopo pagina, il lettore si rende conto che il contenuto riportato dalle singole voci fa decisamente a pugni non soltanto con la logica, ma anche con le più elementari leggi della fisica. A confondere ulteriormente le acque, ci si mette una nota conclusiva di Wilcock, che avverte il lettore di come alcune di quelle biografie siano state ricavate da testi del tutto attendibili come In the Name of the Science (Nel nome della scienza, 1957) di Martin Gardner; e di come altre siano ispirate a personaggi realmente esistiti, incluso un bisnonno italiano dell'autore. Nel frattempo, però, noi ci siamo innamorati di personaggi come Aaron Rosenblum, deciso a riportare indietro le lancette del progresso umano fino all'Età Elisabettiana; come Roger Babson, fondatore dell'istituto scientifico più inutile del XX secolo, dedicato alla ricerca della sostanza «capace di isolare e annullare la forza di gravità»; o come Klaus Nachtknecht, «geologo tedesco di nessuna fama», il quale, convinto che «nulla giova alla salute come vivere sopra un vulcano», si impegnò nell'impresa di costruire una catena alberghiera alle falde dei vulcani attivi di mezzo mondo e perì sotto un'eruzione nel 1924.
Libro “gemello” della Sinagoga è Lo stereoscopio dei solitari, pubblicato nel medesimo anno dal medesimo editore e riedito in edizione economica pochi mesi fa. L'autore lo presentava come «un romanzo con settanta personaggi principali che non s'incontrano mai». Più che romanzo in senso canonico, è una serie di frammenti che sembrano quasi ricavati da narrazioni più ampie (inizi in medias res, conclusioni sospese, tronche, impreviste) e che tuttavia risultano compatti, completi in ogni loro parte – esattamente come le immagini stereoscopiche riuscivano a riprodurre, su scala ridottissima, interi mondi: favolosi scenari tridimensionali che facevano sognare la piccola borghesia europea del XIX secolo.

Nello stereoscopio di Wilcock, però, non c'è più posto per la meraviglia. Per quanto le sue prose siano disseminate di personaggi biblici (L'angelo), classici e mitologici (Il centauro, Medusa, La sirena), tutti risultano in qualche modo degradati, anacronistici. Solitari, appunto: ultimi superstiti non soltanto di una ipotetica “età dell'oro”, ma anche di una letteratura che non esiste più – se non sotto forma di parodia o di trivializzazione. Come nel racconto L'aruspice, nel quale l'indovino del titolo, ridottosi a leggere il futuro frugando nelle viscere dei polli d'allevamento («notoriamente imprecisi nelle loro indicazioni»), deve oltretutto fare i conti con il proprio stipendio d'impiegato ministeriale. O come ne Il vanesio, in cui Wilcock traccia il ritratto di Fanil, che «ha la pelle e i muscoli trasparenti, tanto che gli si vedono i diversi organi del corpo, come rinchiusi in una vetrina». Ma tutto questo non sembra meravigliare nessuno. Anzi, scrive Wilcock, «riesce estremamente spiacevole», poiché Fanil non fa che «mettere in mostra» la sua peculiarità: «Invece di nasconderla, se ne vanta […] come se dopotutto non avessimo tutti un cuore, uno stomaco e due polmoni».
Nel disincantato universo wilcockiano, gli effetti di mise en abyme e altri trucchi non producono alcuna magia, ma soltanto allucinazioni, disagio e inquietudine. Se l'idea di base del racconto I cani da esca può ricordare certe sequenze dei cartoons di Tex Avery, col malcapitato di turno sballottato fuori e dentro il fotogramma, Wilcock sceglie di descriverla dal punto di vista del protagonista. Al riso si sostituisce inevitabilmente l'angoscia di qualcuno costretto a vivere «come un naufrago che si appiattisce sul suo scoglio viscido [...] aggrappato alle tre dimensioni di ogni giorno per paura di scivolare della quarta». Il mondo narrativo dello Stereoscopio non conosce possibilità d'uscita. Le uniche vie di fuga sono l'autosegregazione, anche a rischio della vita (Nel buio) o la follia. In uno dei racconti a mio avviso più belli della raccolta, Liberazione, il protagonista si sottopone di sua sponte a una serie di pratiche lobotomizzanti: anche in questo caso, gli accenti comici, per certi versi affini al cinema di René Clair (la cerimonia funebre messa a soqquadro con un lancio di carciofi, il salmone servito a tavola con ripieno di polvere pirica) finiscono via via raggelati da uno sguardo “scientifico”, alla Raymond Roussel, privo di empatia e di enfasi. Quello di Wilcock è un comico che non fa ridere.
Da dove Wilcock estragga questa comicità negativa non è facile dirlo. Una possibile lettura potrebbe partire dal rifiuto – ovviamente aristocratico e venato di misantropia – della contemporaneità. Ne è un esempio il bozzetto Gli amanti, nel quale il tema dell'amore libero (siamo agli inizi degli anni Settanta) viene declinato nell'orrida immagine dei due protagonisti, intenti a divorarsi l'un l'altra: «Anestetizzati dal desiderio, si strappano grossi pezzi di carne con i denti [...] si bevono l'un l'altro il sangue; poi, sazi, fanno di nuovo l'amore, come possono [...] Non sono belli a vedersi, certo, insanguinati, dilaniati, appiccicosi; ma il loro amore è al di sopra delle convenzioni». Un'indole da “moralista darwiniano” che sfocia addirittura nell'apocalittico con l'ultimo racconto Le forme nuove, quasi un referto su una palingenesi nucleare prossima ventura che, una volta cancellata l'umanità, darà origine a nuove forme di vita «molto ardue da descrivere nei termini che si usavano prima della fine del mondo».
Un'altra lettura possibile coinvolge invece lo stesso Wilcock e la sua condizione di marginale, di «ospite assai singolare della nostra letteratura – per non dire un alieno» (così lo presentava Adelphi all'epoca dell'esordio). Quanto c'è di autobiografico in questi ritratti di singolarissimi dropout? Penso a quei racconti che alludono in modo scoperto alle tare della società letteraria dell'epoca (La lettrice, in cui una gallina viene assunta come consulente editoriale; Le bambole, che assimila gli scrittori a pupazzi), e che costituiscono quasi una riscrittura “poetica” delle cronache letterarie raccolte ne Il reato di scrivere. Proprio in quest'ultimo libretto (una silloge edita da Adelphi, ancora per la cura di Camurri), all'interno di un testo intitolato Illusione e critica, Wilcock sembra far luce sulle componenti “autobiografiche” della propria scrittura.

«Per due motivi noti di carattere biologico (il sesso e la nutrizione)», scrive, «siamo costretti a sopportare l'esistenza, la vicinanza e perfino il contatto di esseri contrari alla nostra ragione; questi esseri vengono genericamente chiamati gli altri». La felicità e il privilegio dei grandi scrittori consiste perciò nel sostituire «le orribili (perché incomprensibili e incomprensive) persone che ci circondano con esseri immaginati, comprensibili e comprensivi, dunque piacevoli». Forse è proprio questo che spinge Wilcock a prendere sul serio i folli scienziati della Sinagoga, a raccogliere vite di reietti nello Stereoscopio: creare un mondo a propria (dis)misura, alla maniera di Lewis Carroll (il quale, ricorda Wilcock, riusciva a concepire «la vita alla stregua di un dialogo fra una tartaruga e un termometro»). Al tempo stesso, l'opera di Wilcock testimonia il fallimento di questa possibilità: forse perché non esistono più grandi scrittori, ma soltanto scrittori mediocri, «costretti viziosamente a riprodurre gli esseri che già conoscono: il più delle volte degli esseri umani».
Non saprei dire se Wilcock soffrisse oppure – almeno un poco – godesse della propria marginalità. Di sicuro, buona parte delle testimonianze di chi lo conobbe personalmente ci restituisce l'immagine di un uomo animato nel profondo da una sorta di cupio dissolvi. È ancora Vassalli a raccontare, per esempio, che, durante un loro incontro, lo scrittore se ne uscì con una definizione lapidaria: «L'amore e l'amicizia vanno e vengono; il solo sentimento durevole è l'odio. Se qualcuno ti odia non sei mai solo». C'è tutta la cupa grandezza di Wilcock, in questa frase, e anche i suoi limiti. Forse non è un caso che, nel Vangelo di Pasolini, egli avesse interpretato la parte di Caifa, l'Antagonista per eccellenza. Può darsi che sia soltanto una suggestione letteraria, ma credo che in qualche modo Wilcock si divertisse a essere odiato, messo ai margini, disprezzato. Soltanto qualcuno che cerca il disprezzo altrui (dei suoi ex-amici Morante e Moravia, per esempio) poteva accettare di collaborare alla pagina culturale di un quotidiano ultraconservatore come Il Tempo, oltretutto diretta all'epoca da Fausto Gianfranceschi, neofascista conclamato. Soltanto qualcuno che vuole ostinatamente stare ai margini poteva scegliere di autosegregarsi nella campagna laziale, in un casale di contadini, con la sola compagnia del proprio bestiario e di qualche occasionale amico, come il solito Pecora («Ci restai sette mesi. Era un posto delizioso, pieno di rose»).
Il 16 marzo 1978 Wilcock moriva, a soli 58 anni, in quel di Lubriano, nel viterbese. Per una coincidenza beffarda e al tempo stesso drammatica, che pare ancora una volta uscita da uno dei suoi libri, era lo stesso giorno del rapimento di Aldo Moro. A parte Gianfranceschi su Il Tempo, quasi nessuno, ovviamente, prestò attenzione alla sua morte. Wilcock aveva scritto: «Felici furono Kafka, Lewis Carrol, Joyce: brevi tratti di vita occidentale dedicati, fra una vita e una morte quasi contemporanee, al sorriso e al divertimento generosi». Si può dire che il destino lo abbia esaudito.









