
Speciale
Adolescenza: immagino dunque sono
In terza liceo, quando li incontro, i miei studenti, per lo più, li sopporto poco. Non li capisco, il loro linguaggio raramente mi incuriosisce. In quinta, per lo più, ne sono innamorata. In terza voglio che si accendano per la filosofia e non accade; in quinta mi interessa la differenza che sono diventati, mi appassiona il loro saper mettere parole e, soprattutto, mettere in parola, quella differenza. In terza, come in quinta, mi preoccupo, mi entusiasmo, mi angoscio e mi compiaccio: misuro la mia impotenza; cerco soluzioni; leggo successi e sconfitte; valuto. La vita di insegnante si svolge tra questi poli, ingombrata dal mio io e da un discorso sociale che utilizzo come metro e chiave di lettura.
C’è poi un altro incontro, quello nella stanza di analisi. L’età è la stessa: tredici, sedici, oppure diciotto anni. Non ho davanti una classe, ma un volto soltanto. La classe esiste, sì, ma prende forma a partire dai discorsi di chi ascolto: così Chiara mi racconta di Serena, che è più brava di lei e tanto magra; e Pietro mi dice che Luca è un idiota, e non capisce perché piaccia tanto. Chiara e Pietro non sono, per me, né in terza né in quinta; non c’è la filosofia tra noi e non ci sono io. Non mi aspetto niente, né da Chiara né da Pietro: ascolto il castello di senso che costruiscono davanti a me; il modo in cui hanno disposto gli elementi; il ruolo che si sono dati. C’è un ulteriore elemento: sebbene Chiara, o Pietro, sono lì, nel mio studio, probabilmente per una sofferenza, che può manifestarsi in sintomi anche gravi, la mia angoscia, o le mie preoccupazioni, raramente prendono il sopravvento. Non ho risposte, né soluzioni. E non ho nemmeno scadenze, né fretta.
Niente di sorprendente, in linea teorica: la posizione di insegnante e la posizione di psicoanalista sono differenti, le conseguenze che ho tracciato vengono da sé. E tuttavia, abitandole entrambe, a distanza di un’ora l’una dall’altra, questa ovvietà teorica è diventata, per me, motivo di interrogazione: insomma sì, la teoria universale; ma Kierkegaard ha ben ragione quando ci insegna che c’è poi la verità singolare.
Gustavo Pietropolli Charmet, nel suo ultimo libro, mette al centro della pratica clinica il rapporto con un mistero: Adolescenti misteriosi. Cosa è questo mistero e cosa c’entra con questo lungo preambolo?
Adolescenti misteriosi è un libro fatto di nomi propri: c’è anche Lu, che è un nome, e non il solo, di Narciso. Charmet ci invita, procedendo – sempre per fare spazio a Kierkegaard – più per narrazioni che per concettualizzazioni, a mettere al centro l’assoluta differenza che l’adolescenza rappresenta. E a prenderla sul serio.
Uno psicoanalista lo dovrebbe fare, ma, forse, è urgente che lo si faccia non solo come clinici, ed è urgente che, quale che sia la posizione che occupiamo rispetto agli adolescenti, poniamo attenzione a un elemento che ha più a che fare con noi che con la loro alterità: l’angoscia. Sì: ci angosciano i tagli sulle braccia; ci angoscia “la pericolosa rivolta delle anoressiche”; ci angosciano i mondi virtuali in cui non sappiamo cosa accade. Ci angoscia quello che non capiamo.
Charmet è molto chiaro: “i ritirati sociali e le anoressiche sono adolescenti che hanno detto ‘no!’ a un modello di vita e a un universo di valori secondo loro sbagliati e si sono smarcati dai modelli prevalenti: molti di loro hanno esagerato e hanno perso. Se vogliamo che ci siano meno vittime civili bisogna organizzare una tregua e corridoi che consentano ai ragazzi di fare altre scelte, pena la morte o la pazzia”.
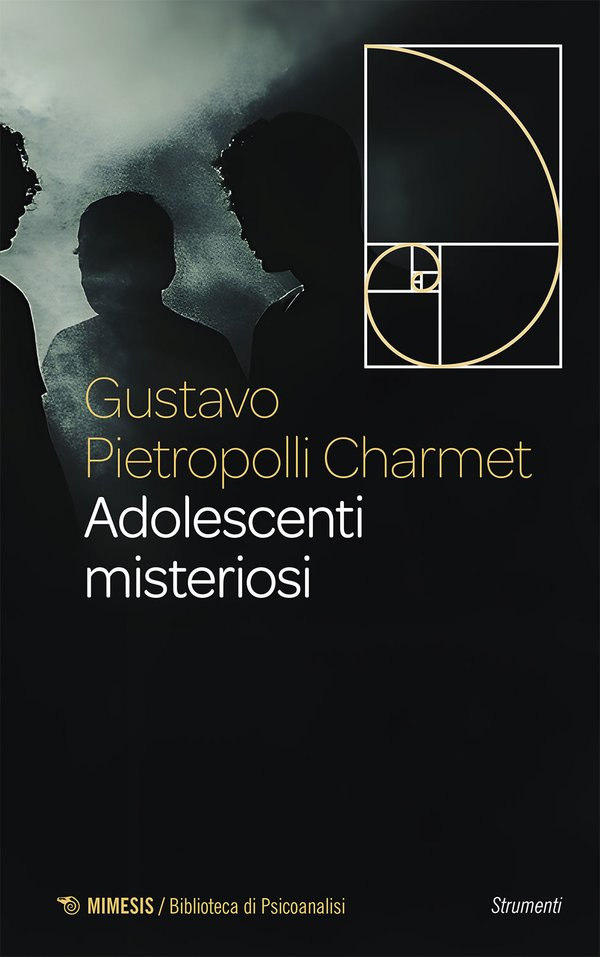
Sappiamo pensare, rappresentarci, ascoltare gli adolescenti, senza averli già pensati? Sappiamo inventarci questi “corridoi” stando in rapporto alla soluzione comunicativa tutta singolare che il sintomo spesso rappresenta, senza lasciare che l’angoscia prenda il sopravvento, spingendoci a curarlo, a spiegarlo attraverso una diagnosi, così da impedirci di intercettarne le intenzioni comunicative, di accogliere lo scandalo che rappresenta rispetto a dei modelli di riferimento che abbiamo introiettato così tanto da applicarli in modo impensato? Quando insegno, insomma, non sono così capace di sospendere le attese, di cercare un'alternativa a quel funzionare secondo i parametri del discorso sociale che, se provo a mettere in dubbio a parole, rientra e si fa spazio, come dimostra il bisogno di soluzioni che mi anima.
Anche l’adolescente è all’interno di questo stesso discorso sociale che noi, come adulti, subiamo. Charmet lo sottolinea più volte: un adolescente non è soltanto figlio dei propri genitori, è immerso in una narrazione fatta di miti, ideologie, mode. Tre sono in particolare i valori sociali drammaticamente pervasivi per un giovane uomo e per una giovane donna: la competizione totale e spietata; la negazione della morte e del dolore; il dominio degli ideali, in particolare dell’ideale di bellezza.
“Bambini felici diventano adolescenti strani che sembrano malati”, scrive Charmet, “non so nemmeno io di che cosa si tratti, ma penso che abbiano tutti lo stesso dolore: non è la famiglia, non è la loro infanzia, e presumo non sia responsabile del disastro nemmeno internet. […] È la società che li disorienta […] sono abituati e addestrati a competere socialmente su tutti i temi della crescita e su tutti i compiti che bisogna assolvere. La spinta a raggiungere livelli elevati di bellezza e visibilità è intransigente […] l’evaporazione del Super-io rende la competizione senza regole: si può dire e fare tutto purché serva a raggiungere l’obiettivo personale”.
Charmet racconta di Mirko, quindici anni: i cambiamenti corporei lo hanno portato a ridurre le occasioni in cui stare con gli altri, a dimettersi dalle attività sportive e così, progressivamente, abbandonare la scuola e ogni forma di attività sociale. Depresso? Psicotico? Ludopatico? Charmet, che lo ascolta, vede in Mirko un sensibile antropologo impegnato nel tentativo di immaginare la mascolinità in un modo differente dalla modalità prevalente, certo di non voler intraprendere la via che, nel discorso dominante, si presenta come l’unica possibile. Mirko, che della ideologia della competizione e della forza non vuole saperne niente, ha trovato, in un mondo virtuale, una nuova strada per la costruzione di un discorso identitario, alternativo ma efficace abbastanza da consentirgli di raggiungere la maggiore età in un modo possibile per lui, libero dalle dotazioni virili apparentemente necessarie. E Sandra? Perché non vedere che l’anoressia può presentarsi come un’opposizione all’ideologia patriarcale, rifiutando il tipo di crescita che la sessuazione del corpo le propone, sottraendolo a ideali di bellezza che segnano un destino già scritto, ovvero quello di esistere come oggetto di uno sguardo maschile? Poi c’è Paolo, abbandonato da Katia. Paolo, che ha amato Katia sin da piccolo e si è trovato, di colpo, estromesso dal mondo immaginato. A Paolo, forse, servirebbe poter parlare con qualcuno del proprio desiderio di morire, ma non sembra previsto che si possa fallire: “quando Paolo soffre non deve dire quale sia il motivo, deve dire che ha mal di testa e che ha ‘preso un moment’, che guarisce ogni tipo di dolore e restituisce una visione più realistica del proprio destino”.

Mirko, Sandra, Paolo, hanno trovato delle vie per mettere in campo una sofferenza che non sanno dire: un po’ perché nessuno insegna le parole per dirla, ma solo le cure per risolverla, o le diagnosi con cui leggerla, e un po’ perché “il dolore non ha diritto di esistere, in quanto significante della morte”. E noi, gli adulti, non vogliamo saperne niente.
Charmet scrive senza ricorrere a etichette psicopatologiche: “rifiutare il linguaggio significa non cedere all’incasellamento dei ragazzi dentro una patologia, la pratica clinica ci mostra quanto siano capaci, all’occorrenza, di imitarle quasi tutte”. Un adolescente in crisi non è un malato mentale: la sofferenza appartiene al vivere, e, ad ammalarli, e ad ammalare anche noi, è spesso il negare questa dimensione tutta umana. Ascoltare significa stare con il mistero che rappresentano, aiutare la costruzione di una storia che consenta loro di integrare elementi avvertiti come indicibili e capire quel “no” che manifestano, e le sue buone ragioni: “una mattina sono entrato nella camera di Sandra e sul muro, vicino al letto, col sangue a lettere cubitali c’era scritto ‘no’. Sandra è stata poi fedele al suo no, scritto di notte, avvolta nel lenzuolo imbrattato dal suo sangue e dal suo rifiuto. Quella mattina ho capito che sarebbe stato impossibile trasformare quel ‘no’ in un ‘sì’ scritto con il rossetto, ma ho pensato che si può vivere trovando un’altra soluzione, personale e nuova: senza sangue e senza rossetto”.
È difficile non subire il fascino di un no con il sangue che diventa un sì con il rossetto: dal rifiuto del sangue mestruale al trucco che ci fa donne. È difficile guardare Sandra sgomberando il campo dal desiderio di questa soluzione che ci seduce, che risponde all’immaginario del discorso in cui siamo immersi. Ma questa non è la sola possibilità: ecco quello che Sandra ci insegna. Allearsi con il sintomo, con la ricerca singolare cui ci invita. Il mistero è la lingua segreta che parlano, pur fingendosi autoctoni: vorremmo saperli ma non li sappiamo.
Abbandonare la strada proposta dal discorso sociale è un compito difficile, per tutti. Leggiamo il disagio quando il banco resta vuoto, quando i corpi svaniscono o intravediamo i tagli dalle maniche delle ampie felpe... ma Silvia? Con i suoi voti perfetti, il suo corpo perfetto, il trucco mai sbavato, Silvia che studia tantissimo e non manca un giorno, rispetta ogni consegna e vive per la nostra ammirazione? Non sono così certa di sapere dove sia Silvia, e se Silvia sappia dove desidera essere, ma è certo che è lì, dove ci aspettiamo di trovarla. Silvia funziona, i suoi binari sono i nostri, e non ci angoscia.
Educare e curare restano posizioni differenti, entrambe impossibili. Questo impossibili è, a ben vedere, un gran sollievo per il complicato rapporto che anche noi, benché adulti, abbiamo con l’ideale: se qualcosa è impossibile, fallire è lecito. Vale la pena tentare, dunque, un tentare che mi pare si possa tradurre in un imparare a non credere troppo alle soluzioni universali, in uno smetterla di annullare nel pensiero la realtà, in un lasciare da parte non solo le diagnosi che tanto ci spiegano e placano – dandoci strumenti per il presente e previsioni per un futuro già scritto –, ma anche i miti sociali che noi stessi patiamo, così come l’ostinata tentazione che sempre abbiamo di leggere l’esistente attraverso il già esistito.
L’invito di Charmet, con questo libro, è duplice. Ascoltare sì, ma non basta: serve immaginare.
Adolescenti misteriosi. Incontro con Gustavo Pietropolli Charmet: domani sera, 10 febbraio, alle 18.30 al Teatro Franco Parenti di Milano, Gustavo Pietropolli Charmet dialoga con Elena Buday e Anna Stefi. Qui per informazioni e biglietti.
In copertina, illustrazione di Flupieland.
Leggi anche:
Elena Dal Pra | Jonathan Haidt: La generazione ansiosa
Vittorio Gallese | Haidt: quelli che... il digitale
Ivan Levrini | Meno cellulari e più trapani
Marco Rovelli | Adolescenza e disagio: figli perfetti
Alfio Maggiolini | Tutti in ansia e insicuri
Laura Porta | Gli adolescenti e il male
Enrico Manera | Studenti e docenti uniti nell’ansia
Marco Rovelli | Amelia C.: Adulti io vi accuso
Laura Porta | Gli adolescenti non vogliono essere capiti
Anna Stefi | Ma tu quando piangi? In dialogo con Pietropolli Charmet









